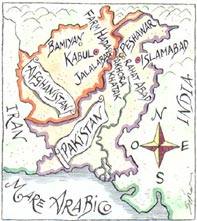| Dear Visitors, these next pages are a heartful tribute to Maria Grazia Cutuli, sweetest friend, valued travelmate and skillful writer for Corriere della Sera, major italian newspaper, who was ambushed and killed by unknown assailants on November 19 2001, while traveling from Jalalabad to Kabul (Afghanistan) together with colleagues Julio Fuentes (spanish newspaper El Mundo), Harry Burton and Hazizullah Haidari (cameraman and photographer, Reuters). |
||
|
||
|
|
|
I'm trying to make available ALL THE STORIES written by Maria Grazia Cutuli.
Big kudos to publishers Corriere della Sera-RCS and Arnoldo Mondadori Editore, for allowing me to post here all the stories they hold copyrights for. |
| lunedi, 19 novembre 2001 Un deposito di gas nervino nella base di Osama Contenitori di armi chimiche abbandonati in un campo di Al Qaeda sulle colline di Jalalabad Un deposito di gas nervino nella base di Osama Contenitori di armi chimiche abbandonati in un campo di Al Qaeda sulle colline di Jalalabad DAL NOSTRO INVIATO FARM HADA (Afghanistan) - Gas sarin: la scritta in caratteri cirillici appare su un' etichet ta rossa, incollata su una scatola di cartone. Dalla confezione spuntano venti fialette di vetro, simili a piccoli termometri, riempite di liquido giallo e pastoso. È una delle sostanze più velenose e letali prodotte in laboratorio. Un gas nervino, u n' arma chimica capace di uccidere al solo contatto con la pelle. È stata trovata dal Corriere della Sera e dal quotidiano spagnolo El Mundo dentro uno dei più grandi campi di Osama Bin Laden in Afghanistan, una base abbandonata dopo la frettolosa ri tirata dei talebani da Jalalabad. Una scatola intera, forse dimenticata durante la fuga. Oppure lasciata apposta, come segno di avvertimento ai futuri profanatori. L' abbiamo scoperta a Farm Hada. Un posto sperduto in mezzo a una landa rocciosa, a un ' ora di macchina dalla città. Ci arriviamo percorrendo una pista di sabbia che si addentra per chilometri in una vallata bruciata dal sole. Un' area inaccessibile fino a qualche giorno fa. Off-limits per chiunque non fosse parte della rete di Osama. Ora troviamo solo un check-point, controllato dai mujaheddin e una vecchia sbarra di ferro a bloccare l' entrata. I miliziani ci salutano, sorridono, lasciano che il nostro fuoristrada passi senza troppe obiezioni. Oltre la barriera, piccole colline desertiche costellate da muraglie quadrate, mimetizzate sullo sfondo di un paesaggio ocra: caserme, baracche d' argilla protette da vecchi carri armati. L' autista guida lungo mulattiere tortuose. Si ferma davanti a una fila di nicchie sterrate sul fianco di una montagnola. Da lontano sembrano tunnel. In realtà sono trincee zeppe di pezzi di artiglieria, bossoli, proiettili di granata. Una sorta di barriera difensiva, dietro la quale si nasconde una banchina di cemento, circondata da muri di ar gilla, con un cancello di ferro chiuso da un catenaccio. Attorno, container di metallo, una casupola che doveva servire come posto di guardia e una baracca dal tetto di lamiera, stipata di munizioni. Gli arabi devono essersene andati in fretta da Far m Hada. Un' armata allo sbaraglio, se per terra c' è ancora una scodella incrostata di cibo, un mucchio di stracci, e poco lontano, gettati alla rinfusa, mine, ordigni esplosivi. E' qui che appare la scatola di cartone. Non riusciamo a capire che cos a contiene. Il giornalista del Mundo, Julio Fuentes, la incide sul lato, tirando fuori ad una ad una le fialette in vetro bianco, ampolle sottili come siringhe da insulina, strozzate alle estremità e isolate una dall' altra dentro piccoli scomparti d i cartone. Ne contiamo una ventina. È l' etichetta attaccata alla confezione a rivelare il contenuto: gas sarin, scritto in russo, e, sotto, l' indicazione sull' antidoto da usare, l' atropina, l' unica sostanza capace di contrastare gli effetti leta li. Una traccia sinistra dell' arsenale che potrebbe essere in mano ai combattenti di Osama. Una prova che nelle caserme dello sceicco saudita non ci sono solo kalashnikov, missili o granate, ma anche armi non convenzionali, utilizzabili da attacchi terroristici in tutto il mondo. E forse non è un caso che tra tutte le basi abbandonate dagli uomini di Al Qaeda in questi giorni, dopo la partenza dei talebani e l' arrivo dei mujaheddin, Farm Hada sia una delle poche a non essere stata bomba rdata dagli americani. Tiriamo via l' etichetta e, per precauzione, lasciamo le ampolle. Troppo rischioso portarle via. Il gas Sarin ha effetti neuro-tossici. Le abbandoniamo lì dove si trovano, sotto il sole. Intorno non si vede nessuno. Il silenzio è pesante e sinistro. Non ci sono mujaheddin a custodire la base. Non siamo neanche sicuri che l' area sia completamente libera dagli arabi di Osama. Ma certo è che qualcuno deve essere passato da qui, dopo la partenza dei membri di Al Qaeda, a mett ere i lucchetti su ogni portone. «Gli uomini di Younis Khalis», dice la nostra guida. I miliziani dello stesso leader politico che mercoledì scorso, dopo un lungo negoziato, ha costretto i talebani a sloggiare dalla regione. L' abbiamo visto Khalis, qualche giorno fa, entrare nel palazzo del governatore, la barba tinta di arancione, uno zuccotto in testa, a passi faticosi su un paio di stampelle. Lo accompagnavano i suoi fedeli, sorreggendolo ad ogni gradino. Ha pronunciato poche parole, sillabe gutturali e cavernose per annunciare la pace. Ma è lui il grande vecchio, il capo storico dell' Hezb-i-Islami, una delle fazioni che combatterono la Jihad contro i sovietici, ad aver concesso a Osama il permesso per costruire la base di Farm Hada su i suoi terreni, all' interno del suo feudo. Era il 1996. Lo sceicco del terrore, scacciato dal Sudan - raccontano a Jalalabad - si era accampato in una brigata di arabi nel villaggio di Teerah, all' interno della zona tribale del Pakistan. I capiclan lo avevano tollerato per un po' , poi l' avevano pregato di andarsene. Osama si è spostato a Tora Bora, il rifugio sulla Spinghar Mountain, la stessa parte dove gli arabi in fuga si sono arroccati in questi giorni. E quindi a Jalalabad con l' assens o della Shura locale. È stato qui che ha trattato con Khalis l' acquisto dei terreni. Il leader, che lo conosceva dai tempi della Jihad, gli offrì ospitalità permettendo ai combattenti di Al Qaeda d' installarsi nella sua roccaforte. Con l' arrivo de i talebani, all' ottobre dello stesso anno, Osama si è trasferito a Kandahar, lasciando a Farm Hada uno dei suoi principali avamposti militari. Per anni si sono nascosti qui dentro alcuni degli uomini più ricercati dall' Fbi, come Atef, il numero tre di Al Qaeda, morto venerdì sotto un bombardamento americano. Dentro la base, che si stende per una decina di chilometri quadrati, vivevano anche alcune famiglie dei seguaci di Osama - racconta un afghano che l' ha visitata qualche tempo fa - in case ggiati protetti come bunker e sorvegliati dai miliziani armati, una cinquantina in tutto; difficile dire quanti fossero complessivamente i residenti. Da Farm Hada potrebbero essere passati a rotazione migliaia di combattenti islamici, per prep ararsi militarmente e spiritualmente alla Jihad contro l' Occidente. All' interno degli edifici non mancava nulla: acqua corrente e luce, fornita da enormi generatori, apparecchiature satellitari, archivi e documenti. Oggi sono rimasti solamente mezz i militari, camion, pezzi di artiglieria e un numero impressionante di munizioni. E il contenitore del gas nervino. Poco lontano dalla zona in cui abbiamo trovato le fiale, sorgono le ville di Younis Khalis e dei suoi comandanti. Costruzioni nascoste dietro fila di mura. Si vedono bambini giocare davanti ai portoni e qualche camion passare lungo la strada. Lo stesso Osama ha conservato una residenza nella zona. Ci fermiamo a Dar Olum, l' ex «madrassa» dove venivano selezionati i giovani combatte nti, ragazzi preferibilmente orfani dai 15 ai 18 anni destinati agli attacchi kamikaze. domenica , 18 novembre 2001 Jalalabad «libera» resta una prigione avvolta dal burqa Donne sottomesse alle tradizioni dei pashtun «Il nome di mia moglie? Mai su un giornale». Chi viene da una famiglia agiata, chi ha studiato e chi è stato all' estero rifiuta il burqa. Chi arriva invece dai villaggi e dalle zone rurali, dai quartieri poveri, non penserebbe mai di farne a meno DAL NOSTRO INVIATO JALALABAD - Nascoste, invisibili, assenti: non si vedono donne a Jalalabad. La liberazione della città afghana dai talebani ha portato nelle strade migliaia di miliziani armati, bande ubriache di vittoria, pronte a contendersi il c ontrollo del territorio sino all' ultimo vicolo o all' ultima casa. Non ci sono donne tra chi fa la guerra, gestisce il potere, decide il futuro. In un' intera mattinata, appaiono tra le botteghe del suk solamente tre sagome avvolte dal burqa, dal pa sso silenzioso e discreto, coperte come sempre dietro la cortina di un poliestere. «Scoprirsi il viso? Non è il momento», farfuglia una delle tre, scivolando tra le bancarelle. «Il burqa è l' unica protezione che abbiamo», dice la seconda, mentre la terza acconsente. «In una situazione come questa, rischieremmo lo stupro». Fanno la spesa veloci, un po' di frutta, cotone per cucire, pezzi di pane. E si dileguano con la stessa andatura leggera con cui sono arrivate, strette una all' altra a difend ersi dal mondo di fuori. Non ci sono stati delitti a Jalalabad, com' è successo invece a Kabul dopo l' arrivo dell' Alleanza del Nord. Nessun proclama dei mujaheddin che inviti le donne afghane a tornare nei posti di lavoro e tra i banchi di scuola. Le milizie tribali - ancorate alle coriacee tradizioni pashtun - hanno altro a cui pensare. E non è certo il burqa, la segregazione femminile, la violazione dei diritti umani, il peccato che rimproverano ai talebani. Il velo integrale fa parte dei co stumi locali. La sottomissione delle donne è un' eredità secolare che le milizie coraniche hanno solo istituzionalizzato. «E la cultura fa la differenza - dice Karmi Nazri, proprietario di una scuola d' inglese a Jalalabad -. Chi viene da una famigli a agiata, chi ha studiato e chi è stato all' estero rifiuta il burqa. Chi arriva invece dai villaggi e dalle zone rurali, dai quartieri poveri, non penserebbe mai di farne a meno». I talebani non c' entrano, secondo lui. Anche prima del loro arrivo i n Afghanistan, la maggior parte delle donne pashtun si copriva il viso. «Cambierà qualcosa? Non certo adesso, con i guerriglieri in giro. Non c' è donna che può aver voglia di mostrarsi in una situazione come questa». Forse in futuro, a poco a poco, una volta che l' Afghanistan avrà preso un altro corso politico. «Ma mia moglie, no. Lei il burqa l' ha sempre portato e lo porterà sino alla fine dei suoi giorni». Come si chiama la moglie? Il professore d' inglese abbozza un sorriso imbarazzato: «N on mi pare il caso che il suo nome compaia sui giornali». Nient' altro da aggiungere. Anche Kamram Bashari, medico all' ospedale centrale di Jalalabad, si mostra esterrefatto all' idea che le donne della sua famiglia possano camminare a viso scoperto . «Non hanno mostrato la loro faccia nemmeno ai propri cugini. Sono quelle che lavorano per il governo, le professioniste, le dottoresse, che tra qualche mese forse alzeranno la testa, a rivendicare libertà mai godute». La cultura pashtun è dura da s radicare. Anche nel vicino Pakistan vigono le stesse regole: perfino nella buona borghesia, dove non c' è occasione che non venga celebrata con sontuosi banchetti, uomini e donne festeggiano in zone diverse, rigidamente separate. Ancor più nei campi profughi degli afghani: il burqa serve a mascherare la povertà, a nascondare la vergogna di chi chiede l' elemosina, a proteggersi dalla promiscuità. Era questo il significato originario dallo hijab, l' abito prescritto dal Corano: un riparo per il c orpo e per lo spirito, in una società invadente come quella beduina, per mettere una distanza tra sé e gli altri, e garantirsi un minimo d' intimità. A Peshawar, in Pakistan, s' incontrano donne ultrafondamentaliste, colte, laureate, capaci di parlar e in perfetto inglese, che teorizzano la differenza tra i sessi. «É segno di rispetto da parte degli uomini - dice una attivista del Jamiat Islami, uno dei principali partiti religiosi -. Serve a difenderci dagli sguardi indiscreti, a proteggersi da un eccesso di responsabilità. Non vogliamo diventare come voi occidentali, oberate di lavoro, costrette a mantenervi da sole, a trascurare la famiglia ed i figli». Persino le donne del Rawa, l' associazione rivoluzionaria femminile dell' Afghanistan, ammettono il velo: «Fa parte della tradizione». Quel che non accettano è che sia lo Stato ad imporlo, come nel caso dai talebani. A Jalalabad le donne aspettano. «Ci vorrà del tempo perché i costumi cambino», dice il dottor Kamran Bashari. Una vera stabilità politica chiarirà quale sarà il ruolo femminile in Afghanistan. sabato, 17 novembre 2001 Terroristi e talebani fuggono in montagna Dopo la caduta di Jalalabad gli uomini dello sceicco si nascondono nei tunnel a sud della città I miliziani coranici hanno portato via anche la cassa della Banca Centrale I covi sono stati costruiti dai mujaheddin per resistere all' invasione sovietica Terroristi e talebani fuggono in montagna Dopo la caduta di Jalalabad gli uomini dello sceicco si nascondono nei tunnel a sud della città DAL NOSTRO INVIATO JALALABAD (Afghanistan) - Si sono separati dalle famiglie piangendo. I militanti di Al Qaeda sulle camionette cariche di armi, casse e fagotti, diretti verso le montagne. Le mogli coperte dal burqa e i bambini in lacrime verso il confine con il Pakistan. «Una scena da non crederci - racconta Zingle Bad Shah, un infermiere di Jalalabad -. Fac eva quasi pena vederli». Gli uomini di Osama Bin Laden, gli spietati combattenti della congrega terroristica più pericolosa del pianeta, colti in un momento di debolezza, mentre abbandonavano le proprie case, incalzati dalle milizie tribali. Se ne so no andati a mezzogiorno di mercoledì, arabi, pakistani, ceceni, dopo che i talebani hanno accettato di lasciare Jalalabad ai capi clan delle province orientali dell' Afghanistan, liberando la città dalla loro velenosa presenza. «Vinti più di qualunqu e altro - dice ancora l' infermiere che abita a pochi metri dal loro compound. - Arroganti e violenti». Spariti, grazie a Dio. Alcuni nell' area tribale del Pakistan. Altri, più pericolosi, in un posto che si chiama Tora Bora, a 4 mila metri di altez za sulla Spingar Montain, la Montagna Bianca, 40 chilometri a sud di Jalalabad. Un rifugio sperimentato. Costruito dai vecchi mujaheddin per resistere ai sovietici, offre una base formata da una ragnatela di tunnel sotterranei, dove si sarebbero acca mpati assieme a gran parte delle milizie coraniche, fuggite anche loro portandosi dietro l' intera cassa della Banca Centrale. Gli americani, che negli anni ' 80 avevano contribuito coi loro finanziamenti a far nascere luoghi come questi, hanno tenta to di distruggere Tora Bora nel 1998. Ma le bombe l' hanno scalfito appena. «Il campo non ha mai smesso di funzionare - dice Alim Shah, uno dei comandanti pashtun che hanno preso il controllo di Jalalabad -. Gli uomini di Osama possono sopravvivere d entro ai tunnel per mesi». La rete di approvvigionamenti è garantita dal Pakistan. «È dalla frontiera che arrivano viveri e munizioni». Gli americani ci provano ancora. Il tonfo dei bombardamenti che fa tremare i vetri di Jalalabad rimbomba proprio d a lì, dalla roccaforte della Montagna Bianca. La rete era capillare, qui a Jalalabad. Da una parte c' erano gli arabi: algerini, egiziani, sauditi. I più potenti, con Atef come capo, il numero tre di Al Qaeda, che sarebbe stato ucciso dagli americani . Dall' altra i volontari pakistani. Il gruppo dei ceceni, tagiki, uzbeki. Quattromila persone, unite da una stessa fede: Al Qaeda, l' internazionale del terrore. In questa terra di confine, gli «stranieri» facevano parte della vita cittadina. Avevan o sposato ragazze afghane, comprate dai padri a suon di dollari. Avevano fatto figli. Le loro case e i loro campi di addestramento - segreti e impenetrabili fino a qualche giorno fa - appaiono all' improvviso accessibili a tutti: edifici svuotati e a bbandonati, scheletri insignificanti dietro muraglie di fango compresso e barriere di filo spinato. Zingle Bad Shah, l' infermiere che li ha visti partire, mostra uno dei loro quartieri. All' entrata, una parata di vecchi pezzi di artiglieria di marc a sovietica. I nuovi conquistatori, ragazzini dall' aria sfatta, accovacciati coi vestiti laceri e i pakoul in testa, sorvegliano le granate allineate sui gradini. Dentro, un mosaico di appartamenti, casette nuove dai tetti impagliati, vestiti gettat i alla rinfusa, libri, giocattoli. Su uno scaffale, volumi e riviste in tedesco. «La moglie era una donna arrivata dalla Germania - racconta l' infermiere -. Nessuno l' ha mai vista in faccia». Dietro le case, oltre una rete di canali, si trova invec e il centro di addestramento da cui passavano i volontari islamici per imparare a confezionare esplosivi, prima di essere spediti nelle basi operative come quella di Farm Hada, a 10 chilometri da Jalalabad. Anche qui stanze vuote, residuati bellici e cianfrusaglie. Ma qualcuno ha dimenticato un librone in arabo, un manuale del terrorismo. I fantasmi di Al Qaeda aleggiano sulla città. «Non tutti gli arabi se ne sono andati - racconta il giovane Mobares, un afghano vicino alla rete di Osama -. Tan ti si sono nascosti presso le famiglie delle loro mogli». Molti sono rimasti in clandestinità. E aspettano, assieme ai talebani che si sono mimetizzati tra i mujaheddin, di capire chi saranno i veri vincitori. Le tribù dell' Est non hanno ancora trov ato un accordo. «Jalalabad non è mai stata pericolosa come adesso - sussurra qualcuno -. Tra poco si comincerà a sparare». Le brigate di Osama potrebbero tornare. LA FUGA DEI TALEBANI LA CACCIA Il campo di addestramento riceve viv eri e munizioni dal vicino confine col Pakistan. Da qui potrebbe partire il contrattacco In questa zona di frontiera la rete di Bin Laden contava 4.000 uomini: tutti «stranieri» sposati a donne afghane. venerdi, 16 novembre 2001 Le milizie pashtun padrone di Jalalabad La città è stata liberata dai seguaci dell' ex re Zahir: «Siamo contrari al predominio dell' Alleanza del Nord» La carovana dei conquistatori scivola veloce lungo la pista deserta e terrosa Strade rischiarate da deboli lampioni mostrano bazar senza merce e uomini in armi Le milizie pashtun padrone di Jalalabad La città è stata liberata dai seguaci dell' ex re Zahir: «Siamo contrari al predominio dell' Alleanza del Nord» DAL NOSTRO INVIATO JALALABAD - Non c' è più dogana, non c' è più frontiera. Oltre il Khyber Pass, l' ingresso in Afghanistan è segnato da una fila di catapecchie vuote, che un tempo ospitavano un bazar di confine, chiuso tra montagne inaccessibili. I talebani sono spariti. Hanno lasciato la strada che porta a Jalalabad. Hanno consegnato la città, i suoi dintorni, l' intera regione alle tribù dell' est. Pashtun come loro, ma sotto altre bandiere. Non ci sono arabi sulla strada, volontari islamici, miliziani pakistani. Anche i sostenitori di Osama, che avevano minacciato jihad o morte, si sono ritirati verso altri territori. Scomparsi o forse inghiottiti negli anfratti imperscrutabili della terra di nessuno. La carovana dei conquistatori scivola veloce lungo la pista deserta e terrosa che rappresenta uno dei principali corridoi commercial i dell' Afghanistan. È formata da pullman, da camion, da pick-up. Trasporta capi clan, anziani, comandanti militari, tutti i membri della potente famiglia di Abdul Haq, l' ex leader della jihad contro i russi, ucciso tre settimane fa durante una miss ione in Afghanistan per conto degli americani. Tutti fedeli al re, il vecchio Zahir Shah esiliato a Roma, viaggiano con le immaginette del sovrano attaccate al cruscotto e i fucili tra le gambe. Sono in 2.000. Arrivati da Peshawar, retrovia della res istenza in Pakistan. Tornano a unirsi alle fazioni che hanno preso il controllo di Jalalabad. Premono per arrivare in tempo, prima che altri gruppi strappino di mano il loro feudo d' origine. Temono agguati sulla strada, colpi di coda dei guerrieri c oranici. Ma il viaggio procede tranquillo tra fortini di fango, accampamenti di profughi e i primi villaggi, dove la folla festeggia l' arrivo dei fratelli pashtun, con una parata di bazooka e lancia granate. «Welcome ai liberatori», gridano lungo la strada, enfatizzando la gioia del momento con tre, quattro, cinque terrificanti tiri di mortaio. «Sono i nuovi mujaheddin», esulta Rakim, il capo convoglio. Sgrana gli occhi azzurri, urla al walkie-talkie, li attende fuori dal pullman per salutare v olti sconosciuti, ripetendo estasiato: «Non sono mai stato così felice in vita mia». Un ingorgo di auto annuncia l' arrivo a Jalalabad, la nuova capitale dei pashtun. Seconda città del Paese, conquistata senza sparare un colpo e, soprattutto - dichia rano i capi tribali - senza l' intervento dell' Alleanza del Nord. La prima pietra per contrastare i signori della guerra che, con la copertura aerea americana, sono riusciti a riprendersi Kabul e l' Afghanistan settentrionale. È qui che il Paese si spacca. È qui che si segna lo spartiacque tra due gruppi di potere. Le etnie tagike, uzbeke, hazara che hanno fatto cadere il bastione dei fondamentalisti e adesso vogliono dettare le condizioni per il prossimo governo, e l' etnia dell' est che sosti ene il re, i consigli tribali, il ritorno alla tradizione. Jalalabad, principale snodo commerciale, città di confine, meta di ogni traffico illecito, resta al centro dello scontro. Strade rischiarate da deboli lampioni mostrano bazar senza merce, nas costi dietro il fumo dei barbecue. Migliaia di uomini armati, bazooka in spalla, missili anticarro sui pick-up, kalashnikov in mano, si aggirano inquieti coperti da pesanti scialli di lana. Schieramenti di guerriglieri appaiono negli alberghi, negli edifici pubblici, sugli scaloni che portano al palazzo del governatore, Abdul Kabir, l' uomo dei talebani che ha consegnato la città senza sparare un colpo. «Delegazioni», le chiamano, ed è quanto basta per dire che sono arrivati da fuori. Non si ved ono civili in giro, né tanto meno donne. Solo miliziani barbuti col turbante, in tutto simili ai guerrieri coranici che se ne sono andati via. L' oscurità copre ogni segno dei bombardamenti americani. La città è stata presa mercoledì da Younis Khalis, comandante storico dell' Hezb-i-islami, una delle fazioni che combatterono la guerra contro i russi. Ma già nessuno di ricorda di lui. «È solo un prestanome del clan di Abdul Haq», dicono. Conta la maniera come è stata presa Jalalabad. «Ness uno scontro, nessuna vittima - racconta uno dei comandanti, Mohammed Azrat, bardato come un guerriero medievale - c' è stato un meeting, si è discusso a lungo. Poi ieri notte sono entrati i nostri mujaheddin senza dover premere nemmeno un grilletto». Mezze verità. In città si è sparato, sussurrano altri. Ma non con i talebani. «Quelli sono scappati a Kandahar, nel centro del Paese - aggiunge il comandante -. E con loro gli arabi di Osama. Tutti via». A combattere sarebbero stati i pashtun contro altri pashtun. Tribù arrivate dal distretto di Nangarhar, Laghaman, Nuristan, tra i settemila e i diecimila mujaheddin, in bilico sulla guerra civile. La nuova Jalalabad, vociante e spettrale nelle ore della notte, è una città molto vicina al caos. «Problemi di sicurezza», li chiama Rakim, il capo convoglio arrivato da Peshawar, invitando a non andare in giro per le strade. Vorrebbe organizzare una conferenza stampa. Ma né lui, né i parenti di Abdul Haq, né i pakistani di un' organizzazione uma nitaria, stranamente presenti e attivi nel palazzo del governatore, hanno deciso che cosa raccontare ai giornalisti trasportati fin qui. Chi parla dietro le quinte, rivela una storia fatta di intrecci familiari e di appartenenze, all' interno di una stessa famiglia, a fronti diversi. Si litiga sulla nomina del prossimo governatore: quattro comandanti in lizza, quattro milizie, quattro fazioni. E una grande spaccatura tra chi vuole trasformare la città nell' avamposto dei pashtun, e chi vorrebbe invece trascinarla sotto la stella d' influenza dell' Alleanza del Nord. Anche il potente clan di Abdul Haq fa un gioco ambiguo: si dichiara indipendente, sostiene il re, ma uno dei fratelli del comandante ucciso, Haji Kadir, ex governatore di Jalala bad, favorito per la nomina, ha militato proprio con l' Alleanza del Nord. La trattativa continua. Passa da una Shura all' altra, consigli tribali sospesi sul vuoto di potere. Nella notte il rombo degli aerei americani accompagna l' eco di un bombard amento. Jalalabad è una città assediata più che liberata. L' anticamera forse di una guerra fratricida. giovedi, 15 novembre 2001 L' appello alle tribù dei capi monarchici Jalalabad, il cancello d' accesso all' Afghanistan presa da Younis Khalis, eroe della lotta ai russi Il clan di Abdul Haq cercherà oggi di entrare nella città per piantare la sua piccola bandiera L' appello alle tribù dei capi monarchici Jalalabad, il cancello d' accesso all' Afghanistan presa da Younis Khalis, eroe della lotta ai russi DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - I comandanti monarchici chiamano a raccolta le loro tribù. Decine, centinaia, migliaia di pashtun armati siedono nei giardini delle case di Peshawar, si accovacciano sulle moquette logore, si preparano all' attesa su vecchi divani di velluto. E' un via vai continuo, un confabulare, un incalzare di riunioni a porte chiuse, di consigli di guerra, di frasi a metà. «Domani lo saprete». «Domani vedrete». Jalalabad non può essere lasciata in mano a un solo gruppo. La sua conquista è merito di tutti, anche di quelli che non hanno partecipato. Il suo destino un problema comune, cosa nostra per i clan afghani che dalla frontiera gettano un occhio o danno una mano ai traffici di armi, droga, merci di contrabbando destinati a passare attraverso la città. Porta d' accesso all' Afghanistan, Jalalabad, nascosta a un' ora di macch ina dietro l' area tribale pakistana, dopo le montagne del Khyber Pass, oltre le coltivazioni di oppio che hanno arricchito le casse dei talebani, circondata dai vecchi campi d' addestramento di Osama Bin Laden, è stata il regno delle bande cecene ch e proteggevano lo sceicco barbuto. Oggi è il cancello per l' Afghanistan liberato. Non quello caduto sotto l' Alleanza del Nord. L' altro Afghanistan, il Paese che i pashtun votati alla causa di re Zahir Shah non vogliono cedere alle etnie nemiche. C hi l' ha presa davvero? «Younis Khalis», rispondono in casa di Abdul Haq, lo sfortunato comandante ucciso dagli arabi di Osama, durante una recente missione in Afghanistan per conto degli Usa. «Younis Khalis». Un nome che riemerge dai libri di storia . Era il leader dell' Hizb-i-Islami durante la resistenza contro i sovietici. Più onesto degli altri, dicono, se non altro per essersi rifiutato di unirsi ai mujaheddin nel 1992 durante il sacco di Kabul. La famiglia di Abdul Haq lo riconosce come pr oprio capo e si prepara, con centinaia di seguaci, a raggiungerlo a Jalalabad. «Non è stata una conquista, ma una negoziazione», dice Nasrullah Arsalai, fratello di Haq, tornato dalla Germania tre settimane fa. Younis Khalis avrebbe convinto Abdul Ka bir, governatore di Jalalabad, a cedere la città. «Non aveva altra scelta, la gente era stufa dei talebani». Gioco facile: Khalis viveva già a Jalalabad. Aveva buoni rapporti con le milizie fondamentaliste. Il governatore era stato tra i suoi soldati durante la Jihad. C' erano gli arabi, è vero. L' incubo dei comandanti pashtun che nelle ultime settimane fremevano per entrare in città: l' altro ieri si parlava di 4 mila miliziani, più 5 mila volontari pakistani. Spariti? «Forse sulle montagne». Forse sulla strada. Non importa. Il clan di Abdul Haq cercherà oggi di entrare in città per piantare la sua piccola bandiera. L' Alleanza del Nord deve rimanere fuori. Che se ne stia a Kabul. «Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare alle loro a zioni militari», sottolinea Nasrullah. «Discuteremo con loro del nuovo governo». Il re ci sarà? Abdul Haq si è sacrificato per Zahir Shah. Su Younis Khalis nessuna certezza. Chi ha preso veramente Jalalabad? In una seconda villa di Peshawar, altre tr ibù rivendicano la vittoria, i comandanti delle province dell' Est. I seguaci del Haji Mohammed Zaman, barba rossiccia e occhi chiari, tornato dall' esilio parigino per partecipare alla liberazione dell' Afghanistan. Da un mese si autoqualificano com e soldati del re, si dicono pronti a partire, disposti ad accettare l' aiuto americano. Adesso non si rassegnano a non essere arrivati in tempo. Con i kalashnikov e i walkie-talkie in mano, curvano le schiene su una mappa militare. «Stanotte entrerem o», annunciano tormentandosi le barbe. «Situazione confusa», sorride un osservatore. E' Pir Sayed Ishaq Gailani, nipote di Ahmed, leader monarchico. Anche lui, ex mujaheddin di cultura occidentale, appena arrivato da Roma dopo un incontro con il re, è interessato alla partita. Ma per il momento la guarda da lontano. «Le tribù dell' Est si stanno dando un gran da fare a cacciare i talebani. Oggi o domani sceglieranno nuovi leader». La strada è aperta, la situazione confusa. «L' Afghanistan si sta spaccando in due». Da una parte l' Alleanza del Nord, dall' altra i pashtun seguaci del re. giovedi , 15 novembre 2001 «Via il burqa, ma le nostre donne devono tenere il velo» Il leader dello schieramento monarchico auspica «un ritorno alla nostra cultura, senza eccessi» «Via il burqa, ma le nostre donne devono tenere il velo» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Né con il burqa né con la minigonna. La «liberazione» delle donne afghane, dopo la foga puritana dei talebani, avverrà nel rispetto dei costumi dell' Islam. Un cam biamento che potrà soddisfare tutti, anche quei moderati che non hanno partecipato alla conquista di Kabul, ma che sperano di entrare in futuro nel governo democratico dell' Afghanistan. «Un ritorno alla nostra cultura, senza eccessi e senza fondamen talismi», dice Pir Sayed Ahmed Gailani, il grande vecchio dello schieramento monarchico, emigrato in Pakistan dopo aver guidato una delle fazioni della Jihad durante l' invasione sovietica. Il leader pashtun è attivissimo in questi giorni nel promuov ere il ritorno del re e l' instaurazione della Loya Jirga come soluzione per l' Afghanistan, è anche capo di una setta sufi. Da esponente politico, religioso, militare ha visto tre generazioni femminili costrette a cambiare comportamenti e stili di v ita a ogni passaggio di regime. «Libertà assoluta sotto i comunisti: le ragazze che uscivano da sole, andavano a ballare come in qualsiasi Paese occidentale. Poi sono arrivati i mujaheddin. Per le donne afghane è stato durissimo: stupri, violenze, su icidi per sfuggire alle bande criminali. L' era dei talebani non ha lasciato scampo: bastava tirarsi su il burqa per essere bastonate dalla polizia religiosa. Tre condizioni che rispecchiano altrettante forme di estremismo». Qualcuna peggiore delle a ltre, o no? «In tutti e tre i casi, le afghane sono state vittime di modelli imposti dall' alto, che non rispettavano né i diritti umani né i principi corretti dell' Islam. L' unico momento in cui le donne hanno vissuto in pace con la tradizione e co n i loro diritti è stato durante la monarchia e negli anni che hanno preceduto l' invasione sovietica». Perché considera dannosa la libertà di cui godevano le ragazze durante il regime filo-comunista? «Perché non aveva niente a che vedere con le nost re credenze e con le nostre radici». Quali sono i diritti previsti per le donne islamiche? «Innanzitutto l' istruzione. Qualunque ragazza deve essere messa in condizione di frequentare la scuola, diplomarsi o laurearsi se vuole. Poi, il diritto al la voro: è giusto che le donne tornino a esercitare le proprie professioni, che possano sedere fianco a fianco con gli uomini negli uffici». E' tempo di buttar via il velo integrale? «Il burqa non fa parte della nostra tradizione. E' un abito d' importa zione che arriva da certe culture indiane. Se una donna vuole indossarlo, lo faccia pure. Ma il governo non può renderlo obbligatorio». Niente a che vedere con l' Islam? «No, il Corano prevede lo hjab, che è qualcosa di molto diverso. Un mantello che copre il corpo lasciando scoperte solo le mani, i piedi, la faccia. E' un indumento che offre dei vantaggi, come la shawal kamise usata dagli uomini: non c' è bisogno di portare nient' altro sotto, al contrario del burqa o del chador». Spariti i tal ebani, saranno ammessi abiti e costumi occidentali? «Non ne vedo la necessità. Credo sia meglio che le donne afghane continuino a vestire e a comportarsi secondo il loro stile. Nessuno di noi è abituato a vedere décolleté o altri parti del corpo esib ite o scoperte». Abiti a parte, non crede che le donne afghane debbano cominciare a godere di una vera parità con gli uomini? «Gli uomini devono cambiare la loro mentalità: più grave del burqa è la mancanza di rispetto che i fondamentalisti mostrano nei confronti delle proprie moglie, figlie o sorelle. Bisogna stabilire rapporti corretti tra i due sessi». Corretti e paritari? «Cominciamo a riaprire le scuole, a far tornare le donne al lavoro. Negli uffici, negli ospedali, nei mercati. E' giusto che ciascuna riprenda il suo ruolo, che impari una professione. Sotto i talebani, la popolazione afghana è scivolata nell' ignoranza e nella miseria». Un governo che si ispira ai principi dell' Islam ha il diritto di decidere sulle questioni morali? «No, se parliamo dei bandi decretati dai talebani. Non possono essere gli editti dei mullah a sancire i comportamenti femminili, a decidere in nome della legge coranica che cosa si deve o non si deve fare. Non è questo che prescrive l' Islam. mercoledi, 14 novembre 2001 ALLA QUARTA VOLTA GIOIA SENZA ILLUSIONI Era il paradiso degli hippy, la tappa obbligata dei giovani che negli anni Settanta si avventuravano sulle piste esotiche dell' Asia centrale. Le ragazze occidentali arrivavano a Kabul in minigonna, gli uomini con i capelli lunghi e stracci variopinti addosso. Si accampavano a Chicken Street per fumare hashish, comprare vecchi argenti o souvenir d' epoca. Poi, il 28 aprile 1978, il colpo di Stato marxista. Venti di guerra cominciano a soffiare sulla capitale afghana, attraversata da maestosi boulevard, costellata da edifici sontuosi, affollata di antichi bazar, intrigante e misteriosa anche nei suoi quartieri più poveri, tra le case costruite col fango e le baracche della perife ria. Mosca si prepara a invadere l' Afghanistan. Le truppe sovietiche entrano a Kabul il 24 dicembre 1979. Gli oppositori islamici organizzano la resistenza dal Pakistan, con l' appoggio degli americani. Comincia la guerra, ma la capitale non viene t occata. Per dieci anni Kabul si salva dalla distruzione. Nascono nuovi quartieri, casermoni del socialismo reale, ville e residenze per i boss della nomenklatura. La città continua a vivere in un' atmosfera surreale, mentre i mujaheddin combattono ne i villaggi, nelle montagne, negli altri centri del Paese. I russi si ritirano nel 1989. Kabul resiste tre anni sotto il governo filosovietico di Najibullah. Ma la pace è una chimera. Nell' aprile 1992 i guerriglieri della Jihad entrano in città. Comi nciano a scontrarsi gli uni con gli altri. Il primo che trasforma la capitale in un campo di battaglia è Gulbuddin Hekmatyar. Non c' è palazzo, edificio, abitazione che si salvi dalle granate. Non c' è strada che non venga cosparsa di mine. Kabul si trasforma in una landa spettrale, una geologia di macerie, un mosaico di prime linee, dove la gente vive senza acqua, senza luce, barricata dietro montagne di sacchi anti granata. I talebani arrivano per la prima volta nel 1995. Sconfiggono tutti gli avversari, tranne uno: il comandante Massud. Il «leone del Panshir» li ricaccia indietro. Ancora bombe su Kabul. Ma il bazar continua a funzionare, le bancarelle a esporre merci d' importazione. Nelle botteghe si trova frutta, verdura, crema Nivea e persino Nutella. Il 26 settembre 1996 i guerrieri coranici conquistano la città. Non si spara più. Kabul, nuovo laboratorio della sharia, la legge coranica, diventa plumbea come un lager. «Meglio che le bombe dei mujaheddin», ripetono gli abitanti. Rimangono solo i poveri, quelli che non sono riusciti a fuggire. Mendicanti e diseredati, talmente afflitti da non stupirsi nemmeno, cinque anni dopo, assediati per la quarta volta, dei bombardamenti americani. Ieri, all' arrivo dei mujaheddin, hanno festeggiato per le strade di Kabul. Ma forse senza troppe illusioni. mercoledi, 14 novembre 2001 «Toglieremo il burqa, ma sarà un altro incubo» Le attiviste afghane, rifugiate in Pakistan: «La nostra lotta continua, i mujaheddin sono criminali come i talebani» «Toglieremo il burqa, ma sarà un altro incubo» Le attiviste afghane, rifugiate in Pakistan: «La nostra lotta continua, i mujaheddin sono criminali come i talebani» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - «Sorelle dell' Afghanistan», la schiavitù è finita. «Tor nate a lavorare negli uffici, a studiare nelle scuole, recuperate i vostri diritti, d' accordo con i principi dell' Islam e della nostra tradizione». Sorelle dell' Afghanistan - dicono i mujaheddin - gettate via il burqa, mostrate il vostro viso, usc ite per le strade. Il Medioevo è passato, i talebani sono spariti. Dimenticate gli editti dei mullah, il mondo delle ombre, l' angoscia della punizione. Non ci saranno più scorribande della polizia religiosa, «sacre verghe» a bastonare le vostre schi ene, minacce di lapidazione contro le fedifraghe, cortine nere a oscurare le vostre finestre. L' Alleanza del Nord promette un futuro radioso. Dirama comunicati. Invita le donne a riprendere il proprio posto. Lascia che gli uomini si radano la barba, che la musica ritorni nelle strade, che la vita ricominci senza l' ossessione della sharia. Ma c' è chi non si lascia incantare dalle sirene della liberazione. Questa è comunque una guerra, vinta dai nemici di ieri. E' un nuovo bagno di sangue. E' l ' incognita del caos. «Non è la Kabul che volevamo, tanto meno il futuro che speravamo per la nostra città». Shikeba, 25 anni, attivista del Rawa, l' associazione rivoluzionaria femminile dell' Afghanistan, ha lasciato il suo Paese ad agosto del ' 96 , due mesi prima che i talebani entrassero nella capitale. «Ricordo ancora gli anni in cui i mujaheddin governavano a Kabul. Ricordo le bombe, i saccheggi, gli stupri. Che volete ci importi del burqa? Sarà un altro incubo». Combattevano giorno e nott e i signori di Kabul. Uno contro l' altro, a tirarsi granate tra le case della gente. «Criminali come i talebani. Non credete che i mujaheddin fossero migliori. La guerra tra le fazioni ha lasciato un' intera generazione senza istruzione e senza cult ura. Sono stati loro i primi a distruggere le scuole, devastare l' università, seminare la povertà». Shikeba vive in Pakistan con la famiglia. Milita tra le file del Rawa da quando aveva 15 anni. Sono stati i combattimenti tra i mujaheddin e i taleba ni, oltre alla repressione contro le attiviste del suo movimento, a trasformarla in una profuga. La ragazza ha passato la giornata al telefono, cercando di parlare con le amiche rimaste a Kabul. Sempre la solita voce irritante e metallica. «Salam Ale kum, le linee sono momentaneamente interrotte». «Impossibile parlare, sapere che cosa sta succedendo davvero». Le notizie arrivate da Mazar-i-Sharif non la rallegrano: «Abbiamo parlato con membri della nostra organizzazione. E' vero, hanno visto donn e togliersi il burqa, gli uomini rasarsi. Ma ci raccontano anche che la gente ha paura. Il ritorno dell' Alleanza del Nord segna una nuova catastrofe per il nostro Paese». Tutti i membri del Rawa, un' organizzazione femminista nata nel ' 77, la pensa no come lei. Cresciute nei campi profughi del Pakistan, le piccole eroine della dissidenza laica credono che solo il ritorno di re Zahir Shah e l' instaurazione della Loja Jirga possa garantire la pace. Sperano in un intervento dell' Onu, confortate dalle parole pronunciate ieri da Kofi Annan: «Affrontare la condizione della donna sarà una priorità per qualunque ruolo rivestito dalle Nazioni Unite in Afghanistan». Vivono e lavorano in clandestinità, controllate dalla polizia e dai servizi segret i. In questi anni, coperte dal burqa, con telecamere nascoste sotto il velo, sono entrate e uscite dall' Afghanistan per documentare e denunciare i crimini commessi dai talebani. Ma, anche, per aiutare e sostenere la popolazione. Hanno creato scuole informali nelle case, hanno portato cibo, hanno assistito le profughe nei campi oltre il confine. Combattono, dicono, contro ogni forma di fondamentalismo islamico. Quello dei Talebani, naturalmente. Ma allo stesso modo quello dell' Alleanza. «E' sta to il leggendario comandante Massud il primo a imporre il velo alle donne - racconta Refit, un' altra attivista del Rawa -. E' con lui che è cominciata la schiavitù». Nessun rispetto, nessuna garanzia. «Quando i mujaheddin sono entrati a Kabul nel ' 92, le ragazze cresciute sotto il regime filo sovietico di Najibullah erano abituate a vestire all' Occidentale, a uscire da sole, a frequentare gli amici. Sono state trattate come puttane. I guerriglieri sembravano bestie selvagge. Entravano nelle c ase con i kalashnikov e costringevano i padri a consegnare le loro figlie. Gli stupri erano all' ordine del giorno. Decine di ragazze si sono suicidate per evitare di essere violentate». Tutto confermato in un rapporto pubblicato da Amnesty In ternational nel ' 95, l' ultimo anno in cui i mujaheddin sono rimasti al potere: storie raccapriccianti di donne incinte sventrate ai check point, spose coatte di comandanti militari, vedove lapidate per aver ripreso marito. Le attiviste del Rawa esc ludono che si trattasse di un effetto della guerra. E forse esagerano. Il regime di Massud, per chi ha visitato Kabul in quegli anni, era certamente più tollerante rispetto a quello dei talebani. Ma loro insistono: «La gente ha vissuto anni di terror e». I guerrieri coranici avrebbero solo chiuso il cerchio dell' oscurantismo. «Hanno messo fine a ogni forma di libertà. Hanno perseguitato sistematicamente le donne, hanno lasciato che il Paese sprofondasse nella miseria - continua Shikeba - ma la d ifferenza con i mujaheddin è minima. Non basta permettere alle donne di buttar via il burqa per convincerci a tornare. La nostra lotta continua, finché l' Afghanistan non sarà veramente liberato. martedi, 13 novembre 2001 «Non siamo battuti Li aspettiamo tra i nostri monti» I talebani si preparano a lasciare le città «Potremmo resistere anche dieci anni» «Non siamo battuti Li aspettiamo tra i nostri monti» I talebani si preparano a lasciare le città «Potremmo resistere anche dieci anni» DA UNO DEI NOSTRI INVIATI ISLAMABAD - I talebani si preparano a lasciare le principali città dell' Afghanistan. Dop o la caduta di Mazar-i-Sharif, la perdita di Kunan, l' avanzata su Herat e Kabul, le milizie integraliste entrano in una seconda fase della guerra, che vedrà i combattenti di Allah arroccarsi sulle montagne, scavare trincee nei deserti, allestire nuo ve linee difensive nelle aree più inaccessibili del Paese. Non è una sconfitta, dicono i loro fiancheggiatori. Solamente una «ritirata strategica», per ricompattare le file della jihad resuscitando le stesse tecniche di guerriglia utilizzate contro g li invasori britannici nell' Ottocento e contro le truppe sovietiche negli anni Ottanta. La nuova strategia viene illustrata al Corriere dai membri di due organizzazioni pakistane - vicine tanto al mullah Omar, il capo supremo dei talebani, quanto a Osama Bin Laden - attivamente coinvolte nella «guerra santa» contro l' Occidente. Il primo è Hussain Hamad Deeshani, comandante militare dell' Herakat-ul-Jihad Islami, un gruppo a cui appartengono diversi «terroristi» apparsi sulle liste nere dell' F bi. Tornato dall' Afghanistan qualche giorno fa, si trova a Islamabad di passaggio, in attesa di ripartire per il fronte. «La resa di Mazar-i-Sharif è stata concordata dai talebani assieme ai capi dell' Alleanza del Nord - sostiene -. E' una ritirata che ci permette di mettere in salvo uomini e armi per poter contrattaccare in un secondo momento». Anche la «consegna» di Kabul, secondo lui, non sarebbe lontana: i talebani starebbero solo prendendo tempo, in attesa di consolidare le posizioni dife nsive sulle montagne. Sarebbero preparati a cedere tutte le città, «compresa Kandahar», la capitale morale delle milizie coraniche, per arroccarsi alla periferia e sferrare da lì attacchi micidiali. «I bombardamenti statunitensi hanno causato danni m olto gravi ai talebani - riconosce Hussain Hamad Deeshani -. Ma tutti noi che operiamo in Afghanistan siamo in grado di resistere alla macchia per altri dieci anni. La stessa Alleanza del Nord finirà per passare dalla nostra parte». Il caos nel futur o del Paese? O le ultime battute di una propaganda sempre meno convincente? L' Herakat-ul-Jihad Islami ha perso un' ottantina di uomini nei raid americani, ma il comandante va avanti come un predicatore: «Sapete quanti sono stati i morti tra i taleba ni, gli arabi e i pakistani? Cinquecento miliziani, non di più. Che volete che sia?». Pilastro della futura guerriglia, per un' armata non convenzionale come quella del mullah Omar, restano le legioni straniere. Assieme ai volontari dell' Herakat-ul- Jihad Islami, operano in Afghanistan altre due associazione pakistane nate dallo stesso ceppo, durante gli anni dell' invasione sovietica: l' Herakat-ul-Mujaheddin e l' Esercito di Maometto, entrambe messe all' indice da George Bush per attività terr oristiche. Al loro fianco, arabi di ogni nazionalità, non necessariamente inquadrati dentro Al Qaeda, la rete di Osama Bin Laden. «Se fino all' 11 settembre il mullah Omar poteva contare sull' aiuto di 12 mila arabi, oggi il numero di volontari è cre sciuto enormemente. Arrivano da tutto il mondo, Occidente compreso. Abbiamo un ex militare americano, convertito all' Islam, che ha combattuto in Cecenia e adesso si trova con i nostri uomini. Ci sono volontari di nazionalità tedesca e persino italiana - racconta un attivista dell' Herakat-ul-Mujaheddin - Alcuni sono immigrati, altri no. Occidentali a tutti gli effetti». Il suo nome di copertura è Janghir, ha 31 anni e una barba più lunga di quella di Osama. La sua iniziazione è avvenuta da ragazzino durante la jihad contro i russi, il perfezionamento nell' arte della guerra nel campo di addestramento di Khost, la centrale terroristica afghana bombardata dagli americani nel 1998. «A ciascun gruppo è affidato il controllo di una parte di territorio. Ma il comando resta ai talebani, sotto la direzione di Jaluddin Haqqani, capo delle operazioni di terra», spiega. La resistenza sulle montagne non fa paura a nessuno. «Siamo abituati a mangiare per anni pane secco imbevuto nell' acqua o a dormire dentro una trincea». L' esodo dalle città preannuncia una guerra di logoramento. Ma per quanto Janghir richiami alla memoria i tempi della jihad, si tratterebbe di una resistenza solitaria simile a quella dei ceceni contro Mosca più che a quella dei mujaheddin degli anni Ottanta. Al momento non c' è nessuna superpotenza alle spalle dei talebani. Nessun Paese disposto a sostenere una nuova guerriglia. Ci sono i «martiri», però. «Combattenti come me addestrati a immolarsi. L' ordine p otrebbe arrivare in qualunque momento. Gli attentati dell' 11 settembre non erano giustificati, perché non c' erano condizioni di guerra - dice Janghir -. Ma da quando gli americani hanno cominciato a bombardare, colpire il nemico diventa un atto leg ittimo». L' attivista dell' Herakat-ul-Mujaheddin lancia un avvertimento: «State attenti tutti, anche voi italiani. Ricordatevi che nel momento in cui le vostre truppe metteranno piede in Afghanistan, diventerete i nostri bersagli». sabato , 10 novembre 2001 «Lunga vita a Osama»: la polizia spara e uccide quattro manifestantiGli scontri in una città del Punjab: la folla cercava di bloccare un treno In Pakistan poche migliaia di persone hanno aderito alla protesta anti-americana. Arrestati molti estremisti islamici «Lunga vita a Osama»: la polizia spara e uccide quattro manifestanti DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Le manifestazioni anti-americane, convocate dai partiti della Jihad, non scalfiscono la politica del generale Pervez Musharraf. Neanche quattro dimostranti uccisi dalla polizia nel Punjab, in un venerdì di sfida, sciopero e preghiera, intaccano l' immagine monolitica che il governo del Pakistan vuole offrire agli alleati occidentali. La protesta, guidata dai 35 partiti religiosi che formano il «Consiglio di difesa per l' Afghanistan», esplode a Rawalpindi, a Peshawar, a Quetta, a Karachi, ma resta marginale. Sempre meno gente d isposta a seguirla. Poche migliaia e senza troppa grinta. E' solo a Shadon Lund, una città del Punjab a 150 chilometri da Multan, che si arriva allo scontro. Quattro mila manifestanti tentano di bloccare il treno che da Lahore va verso Quetta. La pol izia spara sulla folla. «Tre dimostranti uccisi sul colpo, una quarta morta durante il trasporto in ospedale, altre cinque ferite», elenca il ministro degli Interni Moinuddin Haider. Minacciando: «Non siamo disposti a sopportare niente che danneggi l a vita pubblica». Tolleranza zero. Musharraf ha già annunciato che quando tornerà dagli Stati Uniti, le manifestazioni saranno definitivamente interdette. A Shadon Lund, esponenti del Jamiat Ulema Islam, uno dei principali partiti fondamentalisti, di chiarano di aver preso in ostaggio quattro poliziotti. Ma il governo non reagisce. Preferisce pubblicizzare gli arresti: centinaia di estremisti ammanettati a scopo «preventivo», altri durante le proteste. A cominciare dai leader religiosi: Fazlur Re hman, capo del Jamiat Ulema Islam, rimesso in detenzione per l' ennesima volta, e Qasi Hussein Ahmed, numero uno del Jamiat Islami, arrestato per sedizione dopo aver chiesto la rimozione del generale Pervez Musharraf. A Peshawar la folla grida: «Osam a governerà, lunga vita a Osama». Ma nei vicoli del centro, bastano un paio di candelotti lacrimogeni a disperdere gli estremisti. Anche lo sciopero riesce a metà. «Stamattina i negozi erano tutti aperti. Appena questi finiscono la protesta alziamo n uovamente le saracinesche», confessa Niaz Alì, bottegaio del bazar. I leader sfilano su un camion sventolando vecchie bandiere. Ma nel quartier generale di un altro partito religioso, il Sipah-e-Sahabu, al quinto piano di un palazzo pericolante, ci s ono solo i rappresentanti della sezione giovanile: «Vogliamo protestare contro le violazioni dei diritti umani commesse in Afghanistan». Nella linea dura adottata dal governo c' è una pericolosa zona d' ombra. I volontari armati che continuano a part ire a migliaia per l' Afghanistan. Reclutati da organizzazioni diverse da quelle che scendono in piazza, passano il confine senza che nessuno li fermi. Combattono in prima linea con i talebani, fiancheggiano la brigata araba di Osama Bin Laden. Forse il Pakistan non è così monolitico come il suo presidente vorrebbe far credere. giovedi , 08 novembre 2001 Cento uomini-bomba contro le forze alleateUn giornale pakistano svela la minaccia «I kamikaze sono legati a gruppi palestinesi»Cento uomini-bomba contro le forze alleate Un giornale pakistano svela la minaccia «I kamikaze sono legati a gruppi palestinesi» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - L' internazionale della jihad continua a fare seguaci. Per rafforzare le armate dei taleban i, sarebbero arrivati in Afghanistan, oltre a migliaia di combattenti islamici, anche un centinaio di «martiri», votati agli attentati kamikaze contro le truppe occidentali. Li chiamano «feddayn», come i guerriglieri palestinesi degli anni Settanta. Portano divise nere, blu o verdi, con versi del Corano sul petto, imbracciano mitragliatrici tedesche o sovietiche, hanno libero accesso presso le installazioni militari. Formano squadroni della morte, addestrati per le imboscate, abili ad acquattars i carichi di esplosivo dentro i palazzi di città, sui passi di montagna o negli anfratti di una trincea. «Non si sa da quali Paesi vengono - dice Hamid, un giornalista del quotidiano pakistano Frontier Post che ha pubblicato la notizia -. Ma il loro stile ricorda quello dei combattenti palestinesi». Stile, e non solo. Li coordinerebbe un marocchino, vicino al palestinese Heshem Menqarah, membro delle forze di sicurezza di Al Fatah, l' organizzazione di Yasser Arafat. Non sarebbe la prima volta c he i Territori palestinesi offrono volontari per la causa afghana, mescolati nelle file dell' internazionale islamica a ceceni, yemeniti, sauditi, sudanesi, algerini. Lo stesso Abdul Yosuf Azzam, maestro spirituale di Osama Bin Laden, era palestinese di Jenin. Fu l' uomo che creò a Peshawar in Pakistan, durante l' invasione sovietica, il Beit ul Ansar, l' ufficio per il reclutamento dei mujaheddin in tutto il mondo. Ucciso assieme a due figli in un attentato nel 1989, Azzam ha lasciato un a schiera di eredi. I più fedeli stanno in Pakistan, come i membri dell' Herakat ul Mujaheddin, una delle organizzazioni terroristiche messe al bando dal presidente americano George W. Bush. Prima dell' 11 settembre combattevano in Kashmir contro gli indiani. Oggi raccolgono guerriglieri di varie nazionalità da spedire in Afghanistan. Uno degli uffici, dove avverrebbe il reclutamento, si nasconde in una stradina di campagna alla periferia di Peshawar. Il portone si apre solo un attimo, su un cor tile ingombro di casse, coperte da teli di plastica. Un uomo sulla trentina, dal viso allungato, lunghi riccioli castani fuori dal turbante, barba fluente si sporge con aria minacciosa. «Via da qui, immediatamente. O salterete in aria, voi e la vostr a macchina». Alle sue spalle, due guardie caricano i kalashnikov. Accetta invece di parlare, sotto copertura di anonimato, uno dei responsabili incontrato a Rawalpindi: «Continuiamo ad addestrare decine di volontari da ogni parte del mondo - dice -. Ma i talebani chiedono gente che sappia veramente combattere». Come altre organizzazioni specializzate nella guerriglia in Kashmir, l' Herakat ul Mujaheddin ha già spedito a Kabul i suoi miliziani migliori: una trentina sono rimasti uccisi un paio di settimane fa sotto i bombardamenti americani. Dal Pakistan continuano ad arrivare anche i volontari del Tehrik Nefa-i-Shariah, il Movimento per l' applicazione della sharia (la legge coranica), un' organizzazione ultra fondamentalista che ha concent rato sulla frontiera oltre 10 mila combattenti. Diverse migliaia sono già al fronte. E' la prima linea, l' ossessione del governo di Kabul. I 40 mila soldati talebani non bastano. Il mullah Omar ha preferito affidare il controllo delle zone più calde , oltre che ai nuovi volontari, agli arabi di Osama Bin Laden. Ed è stato lo sceicco del terrore a scegliere gli uomini giusti nei punti cruciali. Il quotidiano pakistano Dawn cita: Shawqi Islamboli, fratello di Khalid Islamboli, l' attentatore che u ccise il presidente egiziano Anwar Sadat, a nord di Kabul; Abu Janab nella provincia orientale di Nangarhar; Abdul Hadi Iraqi, ex ufficiale iracheno esperto di esplosivi, nella città settentrionale di Toloqan. A coordinare l' offensiva di terra, c' è la 55esima brigata, il nucleo più duro delle forze di Osama. Efficienti, allenati, spietati. Sono i «terroristi» ai quali George W. Bush vuole dare la caccia. Gente che non ha niente da perdere. martedi, 06 novembre 2001 Karzai, la primula rossa del re, sfugge ai talebaniEx mujaheddin, 46 anni, prima del mullah Omar la sua famiglia «regnava» su Kandahar Per il regime «è stato giustiziato». Ma suo fratello in Pakistan dice: «E' vivo, ci chiama ogni giorno»Karzai, la primula rossa del re, sfugge ai talebani DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - La telefonata arriva puntuale almeno una volta al giorno. Mentre i talebani annunciano di averlo ucciso, Ahmid Karzai, il comandante del fronte filo-monarchico in missi one speciale in Afghanistan, continua a chiamare da un satellitare la famiglia a Quetta, in Pa kistan. L' ultimo contatto ieri sera alle 8. «Karzai sta bene - conferma il fratello Ahmed al Corriere -. È ancora in Afghanistan, libero di muoversi e di portare a termine il suo compito. Ha con sé tutti gli uomini con i quali è partito. Nessuno è stato catturato o ucciso». Misteri di una guerra invisibile, combattuta anche con ex mu jaheddin spediti da Washington nelle sabbie mobili afghane a fomenta re la ribellione contro il regime integralista. Chi mente? Chi dice la verità? Stando alla versione di Ariana, agenzia di stampa vicina ai talebani, Ahmid Karzai, catturato giovedì scorso con altri 25 infiltrati nella provincia di Oruzgan, sarebbe st ato giustiziato ieri assieme a un cittadino statunitense. La grancassa del regime mantiene però toni sommessi. Nessun dettaglio sull' identità del secondo uomo. Nessun particolare sull' esecuzione. Il comandante avrebbe subìto lo stesso trattamento r iservato ad Abdul Haq, l' eroe della resistenza anti-sovietica ucciso una decina di giorni fa: eliminato come agente degli americani. Ma quel filo telefonico tra le montagne di Oruzgan e le retrovie di Quetta indebolisce la tesi di Kabul. A sentire l a voce di Ahmid Karzai non è stato solo il fratello, ma anche gli ascoltatori della Bbc in lingua pashtun. Sabato notte in un' intervista, il comandante ha riferito che i suoi sforzi per convincere la popolazione a ribellarsi ai talebani stanno otten endo successo e che «moltissima gente è stufa del regime». Il leader dell' insurrezione, sebbene braccato, sembra deciso a portare a termine il suo compito. «Ho grandi cose da fare in Afghanistan». Grandi imprese e grandi rischi. Miscela perfetta per accreditarsi come nuova stella della guerra di «liberazione». L' investitura è doppia. Hamid Karzai, 46 anni, entrato in Afghanistan con la copertura degli Stati Uniti e la benedizione di re Zahir Shah, si propone di liberare il Paese dagli arabi di Osama Bin Laden, e di prepararlo a un governo post-talebano, basato sulla «Loja Jirga», il Consiglio supremo della tradizione monarchica. I rapporti con i suoi sponsor sono di lunga data. Il padre, Abdul Ahad Karzai, capo dei Popalzai, la stessa tri bù pash tun del sovrano, fu ministro e senatore del regno. Ucciso nel ' 99 a Quetta, ha lasciato al figlio la guida del suo clan. Ahmid si era già conquistato una discreta fama negli anni Ottanta combattendo contro i sovietici, poi come vice- ministr o degli Esteri nel governo dei mu jaheddin e, a partire dal 1993, come leader politico in esilio a Quetta. L' assassinio del padre- si sospetta, per mano dei talebani - l' ha spinto ad impegnarsi ancora di più nella resistenza contro il regime degli studenti coranici. A lungo è stato inascoltato. «Ho sempre detto agli americani che il nostro Paese ha perso la sovranità e l' indipendenza - si lamentava tempo fa - così come ho sempre denunciato la presenza dei terroristi. Ma nessuno se ne voleva o ccupare: era qualcosa che riguardava solo gli afghani». Capace di portare con la stessa disinvoltura la cravatta e gli abiti tradizionali pashtun, Karzai ha viaggiato molto in Europa e negli Stati Uniti, dove vivono 5 dei suoi fratelli. L' hanno vist o discutere a Washington su come organizzare i capi tribali e altrettanto a Roma, presso la corte in esilio di re Zahir Shah. «E' stato in Italia l' 8 settembre - conferma il fratello Ahmed - a parlare con il re». Un politico più che un guerrigliero: «E' quella la sua passione, il suo impegno numero uno». E' a Kandahar, dominio di famiglia diventato dal 1994 in poi feudo del mullah Omar, l' emiro dei talebani, che Karzai dovrebbe operare. E' qui che riallaccerebbe gli antichi rapporti familiari per convincere i capi tribali alla defezione. Una grande missione su un pericoloso crinale. Vita o morte, per l' uomo che vuole farsi eroe. domenica , 04 novembre 2001 Ma nei cinema pakistani trionfano Stallone e Schwarzenegger«Sanno lottare, sanno combattere, sanno uccidere» Il pubblico «di frontiera» chiede azione, sangue e intrighi Ma nei cinema pakistani trionfano Stallone e Schwarzenegger DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Gli eroi hanno il fisico taurino di Jean Claude Van Damme, la mascella feroce di Arnold Schwarzenegger, la forza bestiale di Sylvester Stallone. Poco importa ch e siano attori occidentali, protagonisti di film americani. Al Falak Seer, una delle principali sale cinematografiche di Peshawar, le locandine parlano chiaro: conta che portino un mitra in mano, una cartucciera sul petto, una bandana legata in front e. «Sanno lottare, sanno combattere, sanno uccidere», dice Abdullah Ahmed, 20 anni, militare in libera uscita. «Sono i migliori - ridacchia un compagno -. Quasi più forti dei nostri attori». Azione, sangue, intrighi. E' quello che basta al pubblico d el Pakistan. Non c' è propaganda anti-americana che tenga, solidarietà con i «fratelli» afghani, bombardati dai B-52 statunitensi, che faccia cambiare idea agli spettatori. «Il cinema è un mondo a parte - sentenzia Abdullah Ahmed -. Non vedo nessun r apporto tra un bel film e i missili lanciati su Kabul». Lo show-business non conosce frontiera, né tanto meno scontro di civiltà. Nonostante la campagna militare americana sull' Afghanistan, l' industria di Hollywood continua a rifornire tutti i Paes i musulmani, dal Libano alla Siria, dal Pakistan alla Malesia. Non è la fetta di mercato più consistente. Rappresenta solo il 10% del «box office», ma i guru del botteghino pronosticano affari in espansione. Gli incidenti di percorso, come quelli di Quetta, la capitale del Baluchistan, dove gli integralisti hanno bruciato tre cinema che trasmettevano pellicole americane, significano poco. «Quetta è abitata al 75 per cento da afghani - commenta Mohammed Ismail, uno degli impiegati del Falak Seer di Peshawar. - Da noi, è diverso. Abbiamo visto gli integralisti e i mullah sfilare davanti al cinema, senza che arrivasse nemmeno una pietra». La facciata del Falak Seer, un edificio cadente decorato da colonne e fregi orientali, costruito dai gover natori britannici negli anni ' 40, mostra al momento il truculento cartellone di un film in urdu, «Potere e poltrona», un poliziesco a base di innocenti in catene che ululano al cielo la loro rabbia, con i polsi sanguinanti, davanti ai mitra e agli s guardi spietati dei loro aguzzini. E' uno dei tanti musical prodotti negli studi di Lahore, in concorrenza con l' industria di Bollywood, l' Hollywood di Bombay, messa al bando dal governo pachistano come riflesso dei pessimi rapporti con l' India. M a la programmazione delle prossime settimane torna sui lungometraggi americani. Nell' ordine: «Universal Soldier» con Van Damme, «Commando» con Arnold Schwarzenegger, «Demolition man» con Sylvester Stallone. Se Van Damme, ex campione di arti marziali , è l' idolo locale di un pubblico composto prevalentemente da giovani sotto i trent' anni, di bassissima estrazione sociale e pochissima cultura, a sbancare i botteghini è stato però Leonardo Di Caprio con Titanic. «Quattro settimane di programmazio ne - precisa il direttore del cinema, Zaur Din. - Più di un milione di spettatori». Affluenza tale che per la prima volta si sono viste in sala anche le donne, le studentesse dei college in visita speciale. Poca fortuna sembrano avere invece le attri ci straniere. All' entrata del Falak Seer, un gruppetto di ragazzi ricorda solo il nome di Julia Roberts. E la faccia di «quell' altra», «la protagonista di Desperado». «Bella, certo - dice Asmat Guri, studente universitario - . Però questi film pien i di sesso fanno male ai giovani». E' la voce più severa: «Ho sentito dire che Hollywood sta producendo un film su Osama Bin Laden. Spero che non lo portino qui. Osama è il nostro eroe e non vogliamo che venga insultato». Meglio la produzione di Laho re? I film Usa offrono alcuni vantaggi: «Per ragioni di distribuzione sono più economici delle pellicole locali», dice il direttore del Falak Seer. Ma alla fine, a Peshawar, solo 5 cinema su 13 si avventurano in questo business. E anche il calendario del Falak Seer mostra 12 produzioni hollywoodiane contro 30 pachistane. «E' un problema di lingua - dice ancora lo studente Asmat Guri -. I film americani non sono tradotti, così molti preferiscono quelli in urdu». Ragione pratica o scontro di culture? sabato , 03 novembre 2001 I talebani braccano l' inviato del monarca Caccia sulle montagne a Hamid Karzai, entrato nel Paese per fomentare una sollevazioneIl Pentagono, sempre meno convinto di spingere l' Alleanza del Nord verso Kabul, sembra puntare su altre fazioni I talebani braccano l' inviato del monarca Caccia sulle montagne a Hamid Karzai, entrato nel Paese per fomentare una sollevazione DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - I fronti si moltiplicano per i talebani. Oltre ai bombardamenti aerei americani e agli attacchi dell' Alleanza del Nord, le milizie integraliste devono respingere i partigiani dell' ex re Zahir Shah, sponsorizzati dagli Stati U niti per sobillare la rivolta dentro l' Afghanistan. Dopo Abdul Haq, l' ex leader della Jihad catturato e ucciso una settimana fa, c' è un altro comandante in missione segreta nel Paese, braccato dalle milizie coraniche, ricercato con un centinaio di uomini, inseguito per le valli e le montagne del distretto di Oruzgan. È Hamid Karzai, 46 anni, combattente durante la guerra contro i russi, viceministro degli Esteri nel governo dei mujaheddin alla caduta del regime filosovietico di Najibullah, nu ova promessa dell' insurrezione. I talebani gli danno la caccia da giorni in una delle regioni più inaccessibili dell' Afghanistan, chiedendosi ancora come sia riuscito ad arrivare fin là. Per giungere alla sua base, nell' area di Dehrawad, i milizia ni del mullah Omar hanno marciato per nove ore tra i crepacci ocra di un paesaggio lunare. Hanno combattuto. Si sono scontrati con i suoi uomini. Hanno voluto fare credere di averlo catturato, addirittura ucciso, come Abdul Haq. Ma all' alba di ieri, il «morto» è resuscitato. Alle 6.30 Hamid Karzai in persona ha telefonato al fratello Ahmed, che si trova a Quetta, in Pakistan: «C' è stato uno scontro pesante - ha confermato -. Ma stiamo tutti bene, solo uno dei nostri è stato leggermente ferito» . Un avversario più temibile del previsto? L' Afghanistan Islamic Press, l' agenzia che fa da megafono al regime, ha insistito per tutta la giornata: due uomini sarebbero morti, altri 25 catturati rischierebbero l' impiccagione come agenti americani. Poi Kabul ha dovuto smentire: «Gli oppositori sono sfuggiti alla caccia», ha dichiarato un portavoce dei talebani, Mohammed Tajeb Agha. Il comandante avrebbe anzi catturato una dozzina di studenti coranici. La missione di Karzai si colora di giallo, come quella tragica e sfortunata di Abdul Haq. Fa parte di uno stesso piano d' attacco? Segna l' inizio di una nuova strategia americana? Il Pentagono, sempre meno convinto di spingere l' Alleanza del Nord con le sue litigiose etnie alla conquista d i Kabul, già da tempo sembra puntare su altre fazioni. Secondo il ministro dell' informazione dei talebani, Qari Fazil Rabi, ci sono elicotteri statunitensi a offrire copertura aerea agli infiltrati. «Hanno sparato sui nostri soldati mentre attaccava no gli oppositori». E ancora: «Hanno lanciato 600 fucili ai ribelli». «Li hanno scaricati al centro dell' Afghanistan, in una regione impossibile da raggiungere se non in volo». Propaganda, secondo Qayum, altro fratello del comandante, residente negl i Stati Uniti: «Vogliono spacciare Karzai per una marionetta di Washington». Un copione molto simile a quello che ha accompagnato la fine di Abdul Haq. In quel caso si è parlato di Apache chiamati in soccorso, di uomini Cia presenti tra gli oppositor i, di misteriose valigie piene di dollari per comprare i talebani locali. Un intrigo parzialmente confermato dal Pentagono: era un Predator, un aereo spia dotato di missili Hellfire, a essere stato inutilmente mandato sul posto. Lo scenario comincia a ricordare i tempi della Jihad, le troppe fazioni sponsorizzate dalla Cia contro l' invasore sovietico, le retrovie pachistane gremite di combattenti, le infiltrazioni di mujaheddin alle frontiere. Con una variante: il ruolo di Zahir Shah, l' ex mon arca esiliato a Roma, attorno al quale si intrecciano le alleanze che dovrebbero portare alla formazione di un futuro governo con l' instaurazione della Loya Jirga, l' antico consiglio supremo multietnico e trasversale. Anche Hamid Karzai, come Abdul Haq, è un esponente pashtun. È uno degli uomini a cui il sovrano ha affidato il compito di creare il suo nuovo esercito. Le similitudini tra il comandante vivo e quello assassinato sono tante: entrambi facevano affari a Dubai, entrambi sono stati ri chiamati dagli Emirati per organizzare la resistenza. Ma i legami tra Zahir Shah e Karzai sono anche più stretti di quelli con Abdul Haq. È un intreccio di ricordi personali, comunanze politiche, appartenenze tribali. Comparso a Peshawar un paio di s ettimane fa, sarebbe entrato in Afghanistan dal Beluchistan, in contemporanea con Abdul Haq. Ma con una missione diversa: se il primo doveva cercare di far passare dalla propria parte i talebani moderati, Karzai cerca consensi all' interno della sua tribù per scardinare il potere del mullah Omar e della sua nomenklatura. venerdi , 02 novembre 2001 Ma «i migliori» sono già coi talebaniI più giovani hanno passato il confine ieri e sono stati presi in consegna dagli uomini del mullah Omar MILLE VOLONTARI PER LA JIHAD Ma «i migliori» sono già coi talebani DAL NOSTRO INVIATO MINGAORE (Pakistan) - Sono partiti i migliori, come avevano chiesto i talebani. I più giovani, i più addestrati, i combattenti capaci di usare l' artiglieria pesant e e la contraerea per contrastare i cacciabombardieri angloamericani. Dopo una settimana di attesa, mille volontari pakistani sono stati autorizzati ieri dalle milizie coraniche a passare il confine con l' Afghanistan. Sono partiti con un arsenale fo rmato da missili, lanciagranate, kalashnikov, eludendo i controlli di frontiera sui sentieri del Nawa Pass. Dall' altra parte, nella provincia di Kunar, i soldati del mullah Omar hanno preparato 50 camion per trasportarli negli accampamenti. «I musul mani di tutto il mondo sono con noi - ha detto il loro leader, il maulana Sufi Mohammed -. Se non combatteremo oggi in Afghanistan, domani l' America sarà libera di attaccare qualunque Paese islamico». Osama Bin Laden può dirsi contento. Propr io lo sceicco del terrore, attraverso Al Jazira, la televisione del Qatar, aveva invitato i «fratelli» pakistani a ribellarsi al governo, alleato con gli americani, per schierarsi contro la «crociata cristiana» di George Bush. I mille volontari sono la prima «brigata della jihad» ufficialmente coinvolta nello scontro con l' Occidente. La testa di ponte per altri 9 mila pashtun, che restano in armi nell' area tribale, aspettando l' ordine per passare. L' avanguardia di un nuovo esercito, reclutat o nelle retrovie del Pakistan dal Tehrik Nefaz-i-Sharia Mohammedi, il Movimento per l' applicazione della sharia (la legge islamica), che fa molto temere per la stabilità della regione. Il quartiere generale dei volontari si trova a tre ore di macchi na da Peshawar, tra le montagne di Swat, nel cuore più radicale dell' integralismo pakistano. In una madrassa di Mingaore, una città bazar dalle coloratissime architetture orientali, il maulana Fazal-i-Haq, presidente del movimento, autoelogia la sua campagna per la jihad. «I reclutamenti sono cominciati subito dopo l' attacco americano sull' Afghanistan. Chiunque volesse iscriversi, doveva specificare che arma aveva a disposizione e quanto denaro era disposto a versare per il proprio mantenimen to durante la jihad». Sono stati raccolti 20 milioni di rupie, oltre 700 milioni di lire, sufficienti a tenere in piedi il nuovo esercito per almeno sei mesi. Sono arrivate donazioni da ogni parte, compresi 100 chili d' oro regalati dalle donne. In q uanto alle armi, ci sarebbe di tutto. Persino i famosi Stinger venduti dagli Usa ai mujaheddin durante la guerra contro i sovietici. «Abbiamo selezionato solo coloro che avevano già esperienza in prima linea» dice. L' ulteriore scrematura sare bbe stata fatta dai talebani: «Solo volontari capaci di usare l' artiglieria pesante» avrebbero detto gli emissari del mullah Omar durante gli incontri preparatori con i capi del movimento. «Molti volontari dovranno aspettare ancora - aggiunge il mau lana. - Saranno chiamati solo quando le truppe occidentali attaccheranno sul terreno». A vederla nelle immagini scattate dai fotografi locali questa armata alla quale nessun occidentale ha potuto finora avvicinarsi sembra un esercito resuscitato da u n incubo della storia. Bambini, adulti, vecchi dalle barbe bianche impugnano moschetti d' inizio secolo, asce, spade fino ai lanciagranate di fabbricazione sovietica: sono destinati in gran parte a bivaccare a Bajour a 5 chilometri dalla frontiera. E ' stato consegnato loro un intero villaggio, Lagharai, dove si preparano - se necessario - a restare tutto l' inverno. Poco importa che il presidente Pervez Musharraf in altre parti del Paese tenti di frenare gli integralisti, cercando nuove a lleanze sul fronte laico. O che intensifichi le pressioni sul regime di Kabul affinché respinga i volontari pakistani. Il maulana Fazal-i-Haq ricorda che gli attivisti del Movimento per l' implementazione della sharia nel 1994, dopo il fallito tentat ivo del governo di imporre una legge speciale sull' area, sono riusciti con una rivolta popolare a prendere il controllo di aeroporti, stazioni di polizia, edifici istituzionali. Ma forse è solo un gioco delle parti. Musharraf, secondo alcuni, sta la sciando mano libera alla brigata della jihad per alzare il suo prezzo con gli americani. Alla vigilia della sua visita a Washington, agiterebbe il fantasma dell' instabilità per ottenere di più dagli alleati. martedi, 30 ottobre 2001 Ci tolgono la luce e ci ingiuriano perché siamo cattolici» Nella casa-ghetto dove abitano i Latif: padre, madre e cinque figlie, unici cristiani in un quartiere integralista di Peshawar UNA FAMIGLIA ASSEDIATA «Ci tolgono la luce e ci ingiuriano perché siamo cattolici» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Un pappagallo spelacchiato gracchia in un angolo: «Thanks Jesus», grazie Gesù. Le immagini del Cristo, riprodotte con i colori brillanti dell' aerografo, tappezzano ogni muro. Altarini e lumini sono sparsi per la casa, tra letti, tappeti, povere, cianfrusaglie. Michael Latif, 56 anni, dattilografo presso il ministero dell' Interno, una moglie e cinque figlie, non fa mistero della sua fede: «Sono l' unico cattolico in un quartiere musulmano». Ma in una città come Peshawar, capitale dell' integralismo islamico nel nord-ovest del Pakistan, equivale a portarsi in fronte una lettera scarlatta. «I nostri vicini fanno di tutto per scacc iarci. E' uno stillicidio quotidiano. Un giorno ci tagliano la luce, un altro il gas. Un altro ancora intasano le fognature. E non manca notte che qualcuno non bussi alla porta gridando per poi scappare via». La sua via crucis è cominciata cinque ann i fa, quando ha deciso di spostarsi da un' area mista per venire ad abitare in un complesso di palazzine gialle, dai muri scrostati, dove gli appartamenti di proprietà del governo federale vengono affittati a zero rupie. «La casa mi piaceva, è grande abbastanza per ospitare tutta la famiglia. Abbiamo una terrazza. E credevo che i vantaggi avrebbero superato i fastidi di vivere circondati dagli islamici». Si sbagliava. Le tre camere si sono trasformate in un piccolo ghetto, guardato con odio e so spetto dai vicini. Le rappresaglie si sono intensificate dopo l' 11 settembre, il giorno degli attacchi terroristici agli Stati Uniti, la data che ha visto nascere nuove barricate tra religioni e civiltà. «In Pakistan noi cattolici siamo sempre stati visti come degli infedeli, ma adesso è peggio: ci considerano occidentali». L' ultimo avvertimento è arrivato domenica, dopo la strage di cristiani alla chiesa di Bahawalpur, nel Punjab. «Alle cinque del pomeriggio ci hanno tolto di nuovo la luce». Paura? Michael Latif ne ha: «Ma non abbandoneremo per questo la strada tracciata da Cristo», dice con enfasi. Non è solo nella sua battaglia. Nella stanza della preghiera, una camera ingombra di tappeti, ci sono anche le cinque figlie, ferventi focol arine. A piedi nudi secondo la tradizione musulmana, a capo scoperto secondo l' usanza cattolica. Snowbar è la maggiore. Ha 25 anni e una laurea in giurisprudenza. «Gli anni scolastici sono stati un incubo. In classe ero l' unica donna in mezzo a stu denti musulmani. Tutti, a cominciare dagli insegnanti, erano convinti di potersi prendere ogni tipo di libertà. "La vostra religione vi autorizza a commettere l' adulterio", mi dicevano». Molestie anche nel quartiere: «Ogni volta che nostro padre esc e - aggiunge la sorella, Saddaf, 23 anni, studentessa di medicina - vengono a bussare alla porta, a gridarci sconcezze». La differenza principale tra loro e le musulmane è il velo. «Quelle si coprono dalla testa ai piedi con il chador - continua Sadd af -. Hanno l' ossessione di non mostrare il loro viso. A noi basta un fazzoletto sui capelli. E se non vivessimo in Pakistan, faremmo a meno anche di quello». In casa portano comunque vestiti tradizionali. Il padre la schewal kamice pakistana, le ra gazze abiti lunghi con pantaloni fino alle caviglie. Ma sarebbero felici di mangiare carne di maiale, se ne trovassero sul mercato. Di bere il buon vino che viene servito nella parrocchia di Peshawar durante la comunione domenicale. Usanze diverse, n omi diversi. Come Michael. Tutti i cattolici portano traccia di un battesimo sin dalla registrazione all' anagrafe. Si chiamano William, George, John, uniti a cognomi musulmani. Molti Mesieh, versione locale di Messia. Latif spiega: «Siamo cattolici da almeno due generazioni. Lo era mio nonno e lo era mio padre. Loro, come quasi tutti i cristiani del Pakistan, arrivano dall' India, dove sono stati convertiti dai missionari durante il periodo britannico. Io invece sono nato a Peshawar». Sono ex h indu i cattolici pakistani, ex intoccabili. I più poveri dei poveri. La loro origine ha lasciato un marchio sulla comunità. «La maggior parte vive nella miseria più assoluta: sguatteri e camerieri. E' difficile trovare un lavoro diverso». Segrete le nuove conversioni. Tradire Allah per Gesù, secondo la legge, comporta la pena di morte. Prima del golpe del 1999, con il quale il presidente Pervez Musharraf è arrivato al potere, i cattolici pakistani avevano quattro seggi in Parlamento. Oggi hanno un ministro, S.K. Tressler, con mandato sullo sport e la gioventù, impegnato nella promozione del dialogo interconfessionale. Ma nemmeno il capo dello Stato nel suo tentativo di laicizzazione del Pakistan, ha potuto cambiare le regole che mettono nel l' angolo i cattolici. La strage di Bahawalpur è stata la prova. «D' ora in poi, cammineremo a testa ancora più bassa», dice Michael Latif. martedi, 30 ottobre 2001 REATI ATTENTATI Strage in chiesa, in diecimila ai funerali Strage in chiesa, in diecimila ai funerali DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Qualcuno ha gridato «Vendetta» davanti alle salme. Altri hanno circondato la chiesa della strage, cantando «il sangue dei nostri martiri porterà alla rivoluzione». Altri ancora hanno pianto chiedendo giustizia. Diecimila persone hanno celebrato ieri a Bahawalpur, città del Punjab, i funerali dei cristiani uccisi domenica da sei uomini mascherati nella chiesa di St. Dominic. Quindici cadaveri, è il conto finale, più il corpo del poliziotto musulmano che montava la guardia all' edificio. Negozi e scuole hanno chiuso in segno di lutto, mentre la polizia formava un cordone protettivo attorno alla minoranza cristiana. Agenti dispiegati attorno alla chiesa, alle moschee e og ni altro luogo sacro della città, hanno impedito proteste e rivolte. Nessuno ha ancora rivendicato la strage. Ma le frasi pronunciate dagli uomini del commando, «Allah Akbar», o anche «l' Afghanistan e il Pakistan saranno la tomba dei cristiani», las ciano pensare a una rappresaglia degli integralisti islamici contro l' attacco angloamericano ai talebani. Durante la notte sono stati arrestati 100 attivisti. I rapporti tra la maggioranza musulmana e la minoranza cristiana, che rappresenta l' 1% de lla popolazione del Pakistan, non sono mai stati facili. Ma è la prima volta in 54 anni di storia del Paese che si arriva a un eccidio. lunedi, 29 ottobre 2001 Pakistan, venti assassinati in chiesaSei uomini aprono il fuoco sui fedeli protestanti invocando Allah: «E' soltanto l' inizio» La suora: «Sapevamo che ci avrebbero attaccati, ma nessuno è stato in grado di difenderci»Pakistan, venti assassinati in chiesa Sei uomini aprono il fuoco sui fedeli protestanti invocando Allah: «E' soltanto l' inizio» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - L' invocazione di rito: «Allah Akbar», Dio è grande. Poi gli spari. Raffiche sui fedeli ing inocchiati per la preghiera. Mitragliate contro le mura. Ancora un grido: «L' Afghanistan e il Pakistan saranno la tomba dei cristiani». Sono le nove del mattino quando sei uomini armati entrano in una chiesa di Bahawalpur, città del Punjab nel Pakis tan orientale, facendo strage davanti all' altare. Arrivano a bordo di tre moto, con passi pesanti e borse in mano, dalle quali tirano fuori kalashnikov e proiettili. La chiesa diventa un mattatoio. «Non è che l' inizio», urlano invasati. I cento dis perati cercano riparo. Si sdraiano per terra, si nascondono dietro l' altare. Ma i corpi cadono già l' uno sull' altro. Sedici fedeli muoiono sul colpo, tra i quali quattro donne, quattro bambini, un celebrante. Altre quattro persone spirano all' osp edale. Sei rimangono gravemente ferite. «Non è che l' inizio», ripetono gli uomini mascherati. Sangue sui paramenti sacri, sui banchi. Un altro cadavere sulla porta della chiesa: uno dei due poliziotti musulmani di guardia all' edificio. E' la prima volta che la comunità cristiana pakistana, per quanto perseguitata, subisce un attacco così sanguinario. Nella regione del Punjab, come in altre aree del Paese, finora c' erano state solo lotte fratricide, sunniti contro sciiti, centinaia di morti ne lle moschee. Contro i cristiani saccheggi, roghi, distruzioni di chiese, mai una carneficina come questa. Negli ultimi giorni però qualcosa sta cambiando. L' aumentare dei bombardamenti anglo-americani sull' Afghanistan fomenta l' odio anti-occidenta le. Volontari islamici si ammassano alla frontiera, per andare a combattere a fianco dei talebani. Molte aree sono fuori controllo. Ieri è esploso anche un ordigno su un autobus a 10 chilometri da Quetta, nel Belucistan: due morti e 25 feriti. Forse una vendetta tra gruppi tribali. Ma lo stesso presidente Pervez Musharraf sembra fatichi a frenare violenze e proteste. Saranno i cristiani i nuovi obiettivi della Jihad? A Bahawalpur, padre Rukes racconta: «La chiesa si è trasformata in un cimitero. Un incubo per chi era venuto a pregare Dio». E una suora, Naseen George, accusa: «Sin da quando è cominciata la guerra in Afghanistan sapevamo che saremmo stati attaccati. Avevamo chiesto protezione alla polizia, ma nessuno è stato capace di difende rci». I religiosi avevano ricevuto telefonate e lettere di minaccia, firmate dal Jamiat Ulema Islam, uno dei principali partiti integralisti, lo stesso organizza manifestazioni di protesta contro gli Usa, reclutamenti e donazioni per la Jihad. A Baha walpur St. Dominic è l' unica chiesa in mezzo a centinaia di moschee, frequentata da 7 mila fedeli, l' unica ad accogliere sia cattolici sia protestanti. Il commando puntava probabilmente a colpire i primi, più numerosi. Ma per un cambio di orario la strage è avvenuta durante la celebrazione protestante. «Un atto diabolico, un tragico gesto di intolleranza», scrive il Papa in un telegramma di condoglianze. Il generale Musharraf assicura che si farà personalmente carico dell' inchiesta. «Consegne remo i colpevoli alla giustizia». Molti musulmani si schierano con i cristiani e proclamano uno sciopero generale di due giorni. La guerra di religione fa paura anche a loro. O forse temono la guerra in casa. lunedi, 29 ottobre 2001 Nel villaggio assediato dei cattolici: «Ci hanno abbandonato» PERSECUZIONE RELIGIOSA Nel villaggio assediato dei cattolici: «Ci hanno abbandonato DAL NOSTRO INVIATO YOSEFABAD (Pakistan) - «L' unica soluzione sarebbe il muro», dice Wilson John, studente di informatica, indicando il confine tra i due villaggi, q uello cattolico (il suo) e quello musulmano. «L' abbiamo chiesto alle autorità, ma dicono che costa troppo». A Yosefabad, cinquemila abitanti persi a mezz' ora di strada da Peshawar, la segregazione è una condanna, ma anche una scelta. «Apparteniamo a due mondi diversi - continua lo studente -. I nostri bambini non giocheranno mai con quelli degli islamici, i nostri amici non staranno mai da quella parte». Prima vengono le baracche dei musulmani, la moschea di Subanabad, alcuni depositi dell' es ercito. Poi c' è il deserto, un orizzonte di sabbia costellato da fortini di fango, dove sono nate, accatastate l' una sull' altra, le casette di Yosefabad. «Certo che abbiamo paura, dopo quello che è successo nella chiesa di Bahawalpur - continua il ragazzo -. I musulmani sono tutti armati, gli unici che non portano fucili siamo noi cattolici». Nelle ultime settimane, dopo gli appelli alla Jihad degli estremisti islamici, la paura è diventata ansia. «Ogni famiglia ha messo a disposizione un vol ontario. Abbiamo formato squadre di 15-20 persone che ogni notte si danno il cambio per pattugliare il villaggio». Sono poco meno di un milione e mezzo i cattolici del Pakistan, una minoranza di origine indiana, formata da ex intoccabili convertiti a l vangelo per sfuggire al sistema delle caste. Accerchiati da 140 milioni di islamici, vivono nel «Paese dei puri» svolgendo i lavori più umili. Sguatteri e camerieri. «Studiare informatica è un privilegio», dice Wilson John. La chiesa è un cubo di p ietra grigia: solo una piccola e discreta croce rossa, sulla facciata, la distingue dal resto delle case. Oggi, domenica, tutto il villaggio aspetta la messa. E' Padre William, parroco della Chiesa St. Michael di Peshawar, a celebrarla. Il sac erdote arriva con una vecchia berlina. «Da quando è cominciata la guerra in Afghanistan - dice - a noi religiosi sono arrivate strane lettere. Come questa». Porge un foglio indirizzato a lui, in qualità di direttore della scuola di St. Michael: «Avet e chiuso la scuola per una settimana dopo l' attacco americano. Se la riaprirete, la bombarderemo». Il messaggio porta la firma dell' Iqalabi, un gruppo del Jamiat Ulema Islam. Anche i preti della chiesa di Bahawalpur avevano ricevuto una lettera sim ile. Sono davvero gli attivisti del partito religioso più importante del Pakistan a minacciare la vita dei cattolici? Il parroco scrolla le spalle. Il suo telefono è sotto controllo, i suoi gesti spiati. «Credo che la strage di Bahawalpur sia collega ta ai bombardamenti sull' Afghanistan. E alla "crociata" di Bush. Crociata è una parola delicata, in un momento come questo può assumere significati molto pericolosi». Guerra tra religioni? I cattolici hanno finora sperimentato i rigori di istituzion i, pesantemente condizionati dalla sharia, il codice islamico. La legge contro la blasfemia, adottata nel 1986, prevede anche la pena di morte per chiunque venga accusato di offendere Allah e il suo profeta Maometto. Bastano due testimoni musulmani a formulare l' accusa. Tre anni fa, dopo la condanna di un cattolico, Ayub Masih, un vescovo si è suicidato per protesta davanti alla corte. Altri due imputati sono stati assolti, ma sono stati assassinati i due avvocati che li avevano difesi. Attualm ente 2.500 cristiani si trovano nelle prigioni del Pakistan accusati di blasfemia. Padre William scuote la testa: «La strage di Bahawalpur potrebbe essere solo l' inizio». E' l' ora della messa. «Poi tutti a casa», dice lo studente d' informatica. Di notte solo le ronde rimangono a pattugliare il villaggio. domenica , 28 ottobre 2001 Verso il confine, armati di asce e bazooka. Sono civili trasformati in combattenti Battaglioni di soldati vestiti di stracci ASPIRANTI MARTIRI Verso il confine, armati di asce e bazooka DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Impossibile contarli. Arrivano a migliaia dai villaggi, dalle campagne, dalle città del Pakistan. Viaggiano su camion variopinti, autobus senza porte, pick up attrezzati come arsenali. Brandiscono pistole, kalashnikov, bazooka, lanciagranate. Esibiscono pezzi d' artiglieria pesante. Non c' è arma che manchi alla carovana di Allah. Persino asce e bastoni, portati in dotazione per la santabarbara della Jihad . A Temergarah, nel cuore dell' integralismo islamico, quattro ore di macchina a nord di Peshawar, due di meno dalla frontiera con l' Afghanistan, i volontari della guerra santa mostrano per la prima volta oltre ai muscoli anche i fucili. Oltre alla rabbia, la determinazione. Sono civili trasformati in combattenti. Battaglioni di soldati vestiti di stracci. Teste coperte dai turbanti pashtun. Visi feroci sotto le barbe d' ordinanza. Non è la solita parata propagandistica, organizzata dai partiti religiosi. Dopo settimane di appelli alla fratellanza islamica e di minacce all' Occidente, le nuove reclute, tutte pakistane, sono pronte a partire davvero. A superare il confine, per unirsi ai Talebani nella lotta contro il nemico americano. Dieci mila, dice qualcuno. Forse di meno, forse di più. Non sono i numeri che contano. E' il passaggio dei loro convogli per le strade del Pakistan a impressionare. E' il fatto che non ci sia nessuno a fermarli. Né la polizia, né i corpi speciali. Né l' ap parato di sicurezza del presidente Pervez Musharraf. A Temergarah le regole sono saltate. Il politicamente corretto non funziona. Tutto quello che dichiara il governo - pieno supporto alla campagna militare americana in Afghanistan - viene sme ntito da questa folla in armi che si mobilita, oltre una frontiera ufficialmente sbarrata, per combattere in nome di Allah. E' un mullah, un fuoriuscito del partito religioso Jamiat Islam, a trascinare le folle. Ad ogni appello, nuove reclute. «Parte cipare alla Jihad contro gli aggressori è un obbligo per ogni fedele - dice il leader -. E' una lezione esemplare per tutti coloro che non sono musulmani». Il suo vivaio si chiama Tehrik Nefaz-i-Shariah Muhammadi, «Movimento per il consolidamento del la sharia di Maometto». E' un gruppo fondamentalista che si è fatto conoscere per i boicottaggi alle elezioni considerate anti-islamiche e che sogna di trasformare il Pakistan in uno Stato governato dalla legge coranica. I suoi attivisti si preparava no da settimane alla grande partenza. Si raggruppano nei cinque campi allestiti al centro di Temergarah, tra bancarelle e baracchini decorati da foto di Osama. Chiedono le dimissioni del presidente Musharraf. Urlano slogan. Agitano i fucili. La notte è stata dura. Passata al freddo in attesa di ordini, con il sostegno dei mullah che dalla moschea distribuivano tè verde, cibo e coperte. «Posso vivere o morire, non mi importa - dice Hussain Khan, un muratore di 18 anni, in una mano il kalashinikov , nell' altra una tazza di tè -. Sarò un uomo fortunato perché avrò combattuto al servizio dell' Islam». Al mattino, parte la marcia. La carovana si mette in moto, con il mullah Sufi Mohammed in testa. Un vecchio salta sull' ultimo pick up: «Ho 70 an ni e non potevo immaginare una felicità più grande di andare incontro alla morte come martire d' Allah». Il convoglio raggiunge l' area tribale di Bajuar, a otto chilometri dalla frontiera con l' Afghanistan. «I Talebani ci aspettano - dicono i capi -. E' il mullah Omar in persona ad averci chiamati». Ma forse è una favola. Diecimila persone in arrivo sono diecimila bocche da nutrire, diecimila ospiti da mettere al riparo. I Talebani hanno chiesto più volte di frenare la corsa al reclutamento. C hissà. I leader sostengono di avere ritardato l' ingresso in Afghanistan per via della selezione. Scrupolosa: in trincea solo i giovani e i forti. Gli altri a casa, lodati comunque per la loro disponibilità. Terra senza legge, il Nord-Ovest del Pakis tan. Il ministro degli Interni Moimuddin Haider minaccia di arrestare chiunque passerà la frontiera. Ma il confine con l' Afghanistan corre per 2.500 chilometri. Varchi clandestini, montagne e sentieri hanno sempre reso la «Durand line», la linea di spartizione tracciata dai britannici, una demarcazione illusoria. Il Pakistan è sempre stato un serbatoio di combattenti per l' Afghanistan. Oggi è la trincea dove si scontrano due civiltà. Altri uomini armati bloccano la Karakoram High way, la via d ella seta in direzione della Cina, il corridoio attraverso il quale Marco Polo rivelò all' Occidente le meraviglie del lontano Oriente. Oggi è l' autostrada per i commerci dell' Asia. I militanti di Allah hanno chiuso il passaggio sabato , 27 ottobre 2001 Giustiziato dai talebani leader dell' opposizioneAbdul Haq era entrato in Afghanistan per conto dell' ex re. Gli elicotteri Usa avrebbero tentato di salvarlo. L' eroe della resistenza e le sue quattordici ferite Giustiziato dai talebani leader dell' opposizione Abdul Haq era entrato in Afghanistan per conto dell' ex re. Gli elicotteri Usa avrebbero tentato di salvarlo DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Era l' uomo dalle mille vite. Il mujaheddin sopravvissuto all a trincea. L' eroe dal piede perso su un sentiero minato. L' esule fuggito a Dubai. L' imprenditore diventato miliardario. Abdul Haq, comandante storico della resistenza antisovietica, era tornato in Pakistan a fine settembre, con un incarico molto p articolare: coordinare la rivolta delle tribù pashtun contro i talebani e preparare il ritorno del re in Afghanistan. La missione si è trasformata in una trappola. L' uomo dalle mille risorse, rispedito in prima linea dagli americani, è stato impicca to ieri pomeriggio in una caserma alla periferia di Kabul. Aveva 43 anni Abdul Haq, barba bianca, 100 chili addosso, una protesi al piede destro. I suoi modi erano affabili, la sua villa alla periferia di Peshawar sempre aperta ai giornalisti. «Ci so no diversi talebani pronti alla defezione - aveva detto durante l' intervista al Corriere una settimana fa -. Ma non è ancora il momento per intervenire». Mentiva? Il 21 ottobre il comandante ha passato il confine a cavallo, attraverso l' area tribal e con sette uomini di scorta. A Peshawar lo si sapeva. E si mormorava: «Ha preso le armi? Sta tentando di comprare i talebani?». Ieri la versione degli studenti coranici: Abdul Haq è stato catturato con un borsa piena di dollari e due telefoni satell itari ad Azra, nel distretto orientale di Logar. I signori di Kabul divulgano la loro versione: il comandante, accerchiato, avrebbe tentato di chiamare in aiuto gli americani. Pochi minuti dopo, ecco gli Apaches volteggiare in cielo. Si spara dall' a lto. Si risponde da terra. Sette feriti, tre talebani e quattro civili. Poi il prigioniero viene trascinato altrove con la sua scorta. Una corte di ulema, i giureconsulti dell' Islam, condannano a morte lui e un collaboratore come «agenti degli ameri cani». In un hotel di Peshawar, il fratello del comandante, Haji Mohammed, altro veterano della Jihad, dà altre spiegazioni: «Abdul Haq era partito in missione di pace, voleva incontrare la sua gente, i capi tribali delle province dell' est». Nessun satellitare, nessuna valigia piena di dollari. Il vecchio non sa ancora dell' impiccagione, lancia a un appello ai talebani perché lo rilascino. Poche ore dopo, nella villa dai pavimenti di marmo è un altro fratello, Daud Arsala, appena tornato dagli Stati Uniti, a scrollare le spalle: «Abdul ha sempre avuto dei contatti con i talebani. Questa era la sua seconda missione». Era stato scelto anche per questo, l' uomo dalle mille vite. Per le sue amicizie, per la famiglia alla quale appartiene, sig nori del distretto orientale di Niangharar, per la rete di relazioni che il suo clan si era assicurato. Era tornato da Dubai, dove viveva dopo che gli avevano assassinato la moglie e il figlio, con l' assenso di Washington e su chiamata del re. «Stia mo cercando di creare una struttura politica attorno all' ex sovrano sulla quale basare poi una struttura militare», aveva detto nell' intervista. «Prima di tutto dobbiamo negoziare». Aveva un piano: una grande rivolta nazionale. Oggi l' entou rage del re si dice scioccato. Ma dall' Afghanistan incalzano solo dichiarazioni di guerra. L' ultimo appello viene dal mullah Omar. Il leader supremo chiede ai musulmani di tutto il mondo tre giorni di mobilitazione a favore dei talebani. L' uomo dalle mille vite ha sbagliato il momento: non è tempo di negoziare. AFIZULLAH AMIN Il 16 settembre 1979 il presidente afghano Mohamed Nur Taraki viene ucciso e al suo posto sale al potere Afizullah Amin, numero due del regime . La sua presidenza dura solo cento giorni: il 27 dicembre inizia l' invasione dell' Armata Rossa e Amin, sgradito all' Unione Sovietica, viene processato e giustiziato. Marxista ortodosso, era inviso a Mosca perché ritenuto troppo coriaceo, troppo d uro con i ribelli islamici, in una parola troppo stalinista MUHAMMAD NAJIBULLAH Filosovietico, divenne presidente dell' Afghanistan nel 1987 e mantenne il potere anche dopo il ritiro dell' Armata Rossa (1989) fino al 1992, quando i mujaheddin presero Kabul. Anziché scappare, restò segregato in un ufficio dell' Onu della capitale che divenne il suo rifugio-prigione. Quando nel 1996 i talebani entrarono a Kabul, Najibullah fu catturato, giustiziato e il suo cadavere fu impiccato nello stadio di ca lcio della capitale AHMED SHAH MASSUD Figlio di un colonnello tagiko e laureato in ingegneria al Politecnico di Kabul, in seguito all' invasione sovietica Massud si diede alla resistenza, guadagnandosi il soprannome di «leone del Panshir». Entrato a Kabul nel 1992 alla testa dei suoi mujaheddin, ne fu ricacciato dai talebani nel ' 96. Da allora ha continuato a combattere contro gli studenti coranici fino al 9 settembre, quando è rimasto ucciso in un attentato JABAL SARAJ (Afghanistan) - La notiz ia della tragica fine di Abdul Haq mi raggiunge proprio qui, in questa polverosa borgata quasi all' imbocco della valle del Panshir, e a una sessantina di chilometri da Kabul, che è diventata il quartier generale dell' Alleanza del Nord da sei anni i n lotta contro i talebani. Non ho bisogno di consultare appunti o i tagli di giornale per ricordare quest' ultimo martire e quest' ultima vittima dei fanatici seguaci del mullah Omar. Dopo Ahmad Sha Massud, eliminato da due kamikaze arabi il 9 settem bre scorso, Abdul Haq era uno dei comandanti mujaheddin che più ho stimato e che da tempo avevo collocato nella galleria degli eroi della guerra afghana. L' avevo incontrato nell' estate del ' 79, sei mesi prima dell' invasione sovietica, a Peshawar, la farraginosa città pakistana sulla frontiera con l' Afghanistan, dov' erano acquartierate le «sette sorelle», cioè i sette partiti islamici afghani che avevano dichiarato guerra al regime filosovietico di Kabul e che poi per dieci anni avrebbero c ombattuto le truppe dell' Armata Rossa, costringendole al ritiro nel febbraio dell' 89. Abdul Haq faceva parte dello Hezb-i-Islami, un piccolo gruppo che aveva rotto i ponti col partito omonimo, fortissimo, guidato dal superfalco della Jihad (la guer ra santa) Gulbuddin Hekmatyar: il capo di questa frazione secessionista, numericamente modesta ma audace ed efficientissima nella lotta armata, era un' anziano leader islamico, Yunis Khalés, laconico e fatto di filo di ferro, la barba rossa fluente, sempre col vecchio Enfield a tracolla. L' ultima vittima dei talebani aveva cominciato molto presto la sua personale Jihad contro il regime scaturito, nel ' 78, dalla cosiddetta «Rivoluzione d' Aprile», che portò al potere il triumvirato comunista Ka rmal-Taraki-Amin. Abdul Haq frequentava ancora i banchi di scuola di Jalalabad da dove contava di trasferirsi alla facoltà di Agraria. «La mia ribellione scattò molto presto - mi raccontò un giorno nel suo rifugio montano di Tizine, 30 chilometri a S ud-Est di Kabul -. Mi ricordo di un insegnante che approfittava di ogni lezione, fosse lingua o matematica, per inculcarci idee socialiste». E' ancora poco più che adolescente quando si tuffa nella lotta clandestina. Viene arrestato un paio di volte dalla polizia del regime, la Khalq. «Mi minacciarono anche di mettermi al muro - continuò a raccontarmi senza toni eroici -. Poi però dicevano: "E' ancora troppo piccolo, è un moccioso, non ci sarebbe neanche gusto". E mi davano uno scappellotto e mi cacciavano via. Fu un grosso sbaglio. Non sapevano, allora, che da grande gli avrei dato molto fastidio. Proprio come sto facendo ora». Abdul Haq non ha più tempo per la scuola e non sogna più un diploma come agronomo. Impara a fabbricare esplosivi, a maneggiare il fucile, a far pratica di agguati e di imboscate. Dice che i suoi cosiddetti «corsi universitari» li ha fatti prima nella sua terra, la provincia di Nangarhar (la stessa del suo capo, Yunis Khalés), poi in quella di Paktya, infine att orno e dentro Kabul. Paga caro il suo apprendistato di guerrigliero. Ha cicatrici su tutto il corpo, è stato ferito al naso, alla schiena, alla testa, al petto: «Quattordici in tutto», precisò quel giorno nel suo rifugio. Ma già allora aveva sotto il suo controllo 5 mila mujaheddin, ben addestrati e disciplinati e con un discreto equipaggiamento, che si dedicavano di preferenza alla guerriglia urbana. «Ma sono operazioni di estrema difficoltà - spiegava nei momenti di relax -. I ri schi sono doppi o tripli. Kabul, poi, è una fortezza, protetta da una triplice cinta umana con 35 mila soldati russi e afghani e una catena serrata di posti di blocco». Era molto robusto Abdul Haq. Spalle e braccia da lottatore, gambe come tronchi d' albero. Piuttosto schivo come carattere, misurava le parole e muoveva poco la testa sul collo taurino. Ma aveva lo sguardo dei buoni. Era riuscito a creare dentro la capitale un' organizzazione underground ben oliata e scaltra, una rete di informato ri camaleonti, pescati tra solerti burocrati e funzionari governativi che facevano il doppio gioco, impiegati modello di giorno, agenti sovversivi di notte. Nel giro di due-tre anni, Abdul Haq era diventato il re dei dinamitardi e dei guastatori. Se la città piombava nel buio per settimane e il telefono non funzionava; se bruciavano i depositi di carburante e i distributori di benzina, se c' era un blackout alla tv; se mancava la farina per il pane; se scoppiava una bomba durante il convegno dei marxisti parchamiti; se un giorno veniva rapito un illustre scienziato sovietico (Orimyuk, poi eliminato)... potevate star certi che dietro tutti questi «inconvenienti» c' era lui, sempre lui, Abdul Haq. «Il mio obiettivo - mi disse una volta quando lo andai a trovare, cosa che facevo spesso, nella sua villetta a due piani color ciclamino, vicino all' università di Peshawar - è sempre quello di colpire i russi là dove gli fa più male. Questa guerra che ci hanno imposto deve costar loro sempre p iù cara, in rubli e vite umane. Gli abbiamo distrutto strutture industriali e militari per miliardi di dollari». E' stato una minaccia vivente per le caserme di polizia, per le guarnigioni, per le fabbriche, i ministeri, le centrali elettriche come q uella di Sarobi, i mulini e i silos, la sede della radio e della televisione, l' ambasciata sovietica, il quartiere residenziale dei russi a Mikrorayon, che ogni sera si chiedevano, prima di spegnere la luce sul comodino: «Che farà stanotte quel demo nio di Abdul Haq?». Gli «sciuravì», i russi, cercarono anche di comprarlo. Era l' inizio dell' 83. Gli proposero una tregua, come avevano già fatto col leone del Panshir, Massud, strofinandogli sotto il naso una montagna di banconote. «Mi offrirono v entisette milioni di afghani - mi raccontò una volta - perché lasciassi perdere Kabul per qualche tempo. Erano infastiditi soprattutto dai nostri attacchi alle centrali elettriche e ai piloni della luce. Declinai l' offerta, naturalmente. E poi, quei soldi non valevano nulla, li stampavano a tonnellate. Ma io già avevo in mente un progetto che li avrebbe messi in braghe di tela...». L' attacco al deposito di Kargha fu il suo capolavoro. Il deposito, 18 chilometri ad ovest di Kabul, nella Paghman Valley, era un superarsenale e conteneva nidiate di missili terra-aria Sam 2 e uno stock micidiale di armi e munizioni che i russi provvedevano a rabboccare ogni mese. Esplose la notte del 27 agosto dell' 86, un botto tremendo che mandò in frantumi tutti i vetri delle finestre della capitale, mentre il cielo era avvampato di rosso, come per l' eruzione improvvisa di un vulcano. I ragazzi di Abdul Haq lo avevano colpito con una grandinata di missili terra-terra 107 mm. provocando un rogo inferna le. Erano stati in molti ad attribuirsi il colpo, «quel» colpo. E lui li lasciava dire e sorrideva, divertito. L' ultima volta che l' ho visto, a Peshawar, fu dopo che aveva perso un piede (il destro, mi pare), saltando su una mina. Era di ritorno da lla Germania, dove lo avevano operato. Disse, con un sorriso in quel suo faccione largo e gentile, «per camminare me ne basta uno». Ettore Mo venerdi , 26 ottobre 2001 I capi antitalebani: «Fermare i raid»L' appello dei leader delle tribù afghane riuniti a Peshawar: «Evitare un vuoto politico a Kabul»I capi antitalebani: «Fermare i raid» L' appello dei leader delle tribù afghane riuniti a Peshawar: «Evitare un vuoto politico a Kabul» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Ogni viso racconta un clan, una tribù, un' idea politica diversa. Mille e cinquecent o persone, strette sui gradoni di una platea, in un ondeggiare di turbanti di seta, scialli variopinti, barbe fluenti, concludono il primo incontro dell' Assemblea per la pace e l' Unità nazionale dell' Afghanistan tentando di pianificare il futuro d i un Paese devastato da vent' anni di guerra e colpito da settimane di bombardamenti americani. Ma non basta un memorandum finale a garantire l' ottimismo. Nella Nishtar Hall di Peshawar, profughi e oppositori afghani si ritrovano con gli stessi dubb i che in questi giorni attanagliano tanto l' amministrazione Usa, quanto le potenze regionali, dall' Iran alla Russia, dal Pakistan alla Cina. Che cosa ne sarà dell' Afghanistan, una volta caduto il regime dei talebani? E' davvero così semplice crear e un nuovo governo che si regga su un leader di facciata, come l' ex monarca Zahir Shah? L' organizzatore della Conferenza, Pir Sayed Ahmed Gailani, il grande vecchio del fronte monarchico, l' ex capo di un gruppo mujaheddin che da anni spera nella r estaurazione della corona, è costretto al realismo. Troppi protagonisti sulla scena, troppe etnie in lotta tra loro per poter credere in un futuro di pace e stabilità. «Le operazioni militari portate avanti dagli Stati Uniti e dalle forze alleate - r ecita leggendo la risoluzione finale - potrebbero causare la caduta dei talebani, ma creeranno un vuoto politico». Un altro bagno di sangue. Un buco nero che rischia di essere riempito da «un particolare gruppo». Gailani non lo dice esplicitamente, m a tutti sanno che il nemico è l' Alleanza del Nord, quell' accozzaglia di fazioni che dal ' 94 combatte contro i talebani. E' lo stesso timore degli Stati Uniti, che stanno infatti tentando di rallentare l' avanzata dei guerriglieri su Kabul. I bomba rdamenti devono finire al più presto, su questo l' Assemblea concorda. Bisogna preparare il terreno per una soluzione politica, proteggere la popolazione e prevenire altre distruzioni. Disarmare Kabul, se necessario, trasformando la capitale in una z ona franca. La risoluzione insiste sulla Loya Jirga, il Consiglio supremo in vigore sotto la monarchia, «istituzione che fa parte della tradizione e della politica della nostra nazione», con un aiuto esterno. Quello dell' Onu con una forza di pace. Q uello dell' Organizzazione degli Stati islamici affinché l' Afghanistan non si smembri, come è successo nei primi anni Novanta, nei feudi dei signori della guerra. Gailani continua a credere nel re, nella sua capacità di imporre una «politica moderat a e bilanciata», ma sottolinea che l' equilibrio nascerà anche dalle quote di potere distribuite ai gruppi etnici, primo tra tutti quello maggioritario pashtun contro i tagiki, gli uzbeki, gli hazara dell' Alleanza del Nord. Il grande vecchio, auster o nell' abito tradizionale di maestro sufi, avrebbe voluto che a questa conferenza partecipassero gli studenti coranici, anche loro di etnia pashtun. L' aveva sperato fino all' ultimo. Ma nessuno dei leader si è presentato. I tre talebani che hanno r aggiunto Peshawar preferiscono restare in incognito. Qasi Amin Waqad, un ex leader della Jihad contro i sovietici, propone una grande marcia su Jalalabad in Afghanistan. Può sembrare demagogia, ma per l' Assemblea degli espatriati significa riallacci are un filo con chi sta dall' altra parte. Si insinua un dubbio: forse il governo degli integralisti, non è stato il peggiore che l' Afghanistan abbia avuto. Ha calpestato i diritti umani, è vero. Ma la vera macchia, quella che ha spinto gli Usa a mu oversi, è un' altra. Gailani non cita Osama, né la sua brigata di arabi. Chiede però «con toni decisi» che «gli stranieri smettano di approfittare dell' ospitalità degli afghani e lascino subito il Paese». E' la condizione numero uno per salvare l' A fghanistan. Dall' altra parte arrivano però solo proteste. In contemporanea alla chiusura del meeting i partiti pakistani filotalebani si riuniscono in una moschea di Peshawar con l' intento di marciare contro la Conferenza per la pace e l' Unità naz ionale. La polizia li blinda. A fine mattinata non sono più di un centinaio, ma al centro del bazar rimangono i baracchini con le foto di Osama e i banchetti per raccogliere soldi a sostegno della Jihad. Non basta il pugno duro del presidente Pervez Musharraf a zittire gli estremisti. Tra il Pakistan integralista e l' Afghanistan dei talebani il corridoio rimane aperto. Una trentina di volontari pakistani sono stati uccisi a Kabul durante un raid americano. Ieri in occasione dei funerali di una delle vittime, hanno sfilato in 2 mila per le strade di Karachi, urlando slogan antiamericani. Tra polizia e manifestanti si è sfiorato lo scontro. Poi è apparso il fratello del morto a celebrare il sacrificio del martire. Nella Nishtar Hall Gailani ricorda che non è una Jihad quella che si combatte in Afghanistan. Solo una guerra civile, ma rischia di lasciare un grande vuoto. giovedi , 25 ottobre 2001 I capi tribù lanciano l' Alleanza del SudNasce in Pakistan una nuova opposizione ai talebani: «Salveremo noi l' Afghanistan»I capi tribù lanciano l' Alleanza del Sud Nasce in Pakistan una nuova opposizione ai talebani: «Salveremo noi l' Afghanistan» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Pir Sayed Ahmed Gailani, immobile nell' abito nero dai galloni dorati, l' espressione ieratica , uno zuccotto d' astrakan in testa, troneggia come un cardinale sul palco montato nella Nishtar Hall di Peshawar. E' un ex capo mujaheddin, imparentato con il re dell' Afghanistan, discendente di Maometto, leader di una setta sufi. L' uomo con il ca risma adatto a rappacificare le litigiose anime dell' etnia pashtun. Un migliaio di capi tribali, esponenti politici, vecchi comandanti dai turbanti di seta, le barbe colorate di henné, i visi bruniti dai tratti orientali, non gli tolgono gli occhi d i dosso. «Fratelli, l' Afghanistan oscilla tra la vita e la morte - dice Gailani con tono profondo -. Uniamo le nostre mani. Facciamo uno sforzo per fermare le operazioni militari e procedere alla ricostruzione del nostro Paese». La platea si alza in piedi. Braccia in alto, dita che si intrecciano. Un urlo comune: «Uniamo le nostre forze». Nasce così nei territori del nord-ovest pakistano, durante una grande assemblea corale che si concluderà oggi, l' Alleanza del Sud: un nuovo fronte, formato d a dissidenti ed espatriati afghani, che dovrebbe spianare la strada al ritorno di re Zahir Shah in Afghanistan e alla prossima leadership di Kabul. Il governo pakistano ha offerto la sede per la conferenza. Gli Stati Uniti hanno dato l' assenso. Tra i personaggi che affollano la sala mancano gli ospiti più importanti. Gailani è appena stato a Roma a garantire fedeltà all' ex sovrano, ma la promessa delegazione del re non si è presentata. La platea è delusa. «Tutta questa gente è venuta qui solo per incontrare i messaggeri del monarca», borbotta qualcuno. L' Alleanza del Nord, il vero fronte combattente dell' opposizione, ha mandato un solo esponente. Ufficialmente disertano pure i talebani «moderati», anche loro invitati alla conferenza: ci sono solo un paio di funzionari di basso rango, nascosti tra la folla. Ma per Gailani è comunque un successo: «Non pensavamo di poter mettere assieme i membri di tante fazioni - dice il figlio Ahmed -. Sono presenti tutti i segmenti dell' opposizion e afghana». E' questa la sfida del «pir» Gailani, l' «uomo pio» delle gerarchie islamiche: lanciare un appello all' unità che comprenda anche esponenti delle milizie di Allah. La platea si spacca: «I talebani non hanno soddisfatto le aspettative dell a gente», dice Qazi Mohammed Amin Waqad, uno dei leader storici della jihad contro i russi. «Se ne tornino nelle scuole coraniche», aggiunge l' esponente di un altro partito. Asad Ullah, uno dei talebani in incognito, ascolta senza scomporsi: «Sono v enuto qui di mia iniziativa, ma questo non significa che ci sia una spaccatura all' interno del nostro movimento. I talebani sono uniti e per niente disposti a cedere il potere a re Zahir Shah». Se l' ex sovrano vuole tornare in Afghanistan - è la po sizione degli integralisti - lo faccia, ma sotto la legge coranica. L' altro nodo è il ruolo dell' Alleanza del Nord, rappresentata da uzbeki, tagiki, hazara. Il re, secondo notizie arrivate da Roma nei giorni scorsi, avrebbe già preparato un suo gab inetto, formato da 120 membri: 50 scelti da lui, 50 dall' Alleanza, il resto di etnia pashtun. Gailani padre tace. Mentre il figlio sbotta: «Non se ne parla nemmeno. E' impensabile che l' Alleanza prenda una quota così ampia». L' assemblea di Peshawa r, dominata dai pashtun, ha un' altra agenda: stop ai bombardamenti americani sull' Afghanistan, formazione di un governo di tecnici in cui vengano rappresentate tutte le componenti dell' opposizione, preparazione di una nuova Costituzione in linea c on la religione islamica. Pir Sayed Ahmed Gailani insiste sulla «loja jirga», l' antico consiglio degli anziani, e chiede che a guerra finita intervenga una forza Onu. E ha anche un programma di lotta: «Gli studenti coranici che condividono le nostre idee dovrebbero avvicinarsi a noi». E' questo l' incarico dell' Alleanza del Sud: far pressione sui comandanti locali, spingere alla defezione, preparare una rivolta dal basso. Delegati al compito due vecchie glorie della jihad: Abdul Haq e Haji Moh amed Zaman. Il primo non si vede alla conferenza di Peshawar. Sarebbe appunto in Afghanistan, a Jalalabad, a preparare il terreno per le diserzioni. L' altro partecipa e si schiera con l' assemblea. Piccole trame del «grande gioco»? Dietro gli sforzi di Pir Sayed Ahmed Gailani c' è il tentativo di far largo alla componente pashtun che rappresenta quasi la metà degli afghani. Ma sul futuro governo del re, pesano altri attori. L' Iran, per esempio, contrario ai talebani. La Russia, vicina all' All eanza del Nord, altrettanto ostile agli integralisti. Il Pakistan sta dalla parte opposta. Vuole salvare i talebani, di cui è stato sponsor per anni, mentre preferirebbe veder scomparire i guerriglieri del Nord. Nelle ultime 48 ore è però successo qu alcosa che imbarazza profondamente il governo di Islamabad davanti all' alleato statunitense: durante un raid americano su Kabul sono stati uccisi guerriglieri pakistani che combattevano con gli integralisti. Sono i miliziani dell' Herakat el Mujahed din, una delle associazioni messe al bando da George Bush. Qualcuno ieri mattina ha tentato di far passare i cadaveri di sei di loro dal confine di Torkham, vicino a Peshawar, ma i doganieri li hanno rifiutati. I corpi sono arrivati comunque, attrave rso l' area tribale. E in serata, a Rawalpindi, si preparavano già i funerali dei «martiri di Allah». mercoledi, 24 ottobre 2001 GUERRA «Non possiamo distribuire aiuti mentre attaccano» L' APPELLO DI MEDECINS SANS FRONTIERES «Non possiamo distribuire aiuti mentre attaccano» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - «Non vogliamo credere che siano i civili l' obiettivo di questa guerra. Ma siamo molto preoccupati. Ogni giorno vediamo peggiorare le condizioni di sicurezza all' interno dell' Afghanistan». Diderik Zan Helsema, portavoce di Médecins sans frontières (Medici senza frontiere) in Pakistan, commenta i bombardamenti sull' ospedale di Herat, denunciando la mancanza di regole e di gara nzia per chi svolge attività umanitaria. «Siamo abituati a lavorare in guerra, ma qui gli spazi d' intervento continuano a ridursi. Non possiamo distribuire cibo e medicinali assieme alle bombe». Le organizzazioni umanitarie hanno chiesto un cessate il fuoco. Vi siete uniti all' appello? «Capiamo i motivi, ma abbiamo deciso di non fermare la richiesta. Un mese di tregua non è sufficiente ad assicurare assistenza umanitaria in tutto il Paese». Senza interferenze? «Se qualcuno pretende di c ondizionare o controllare gli aiuti, rischiamo di perdere la fiducia della gente». Nei giorni scorsi sono state bombardate le sedi di agenzie umanitarie. E' un errore? O i talebani hanno spostato armi pesanti vicino a strutture civili, trasformandole in bersagli? «La situazione è molto caotica. Siamo stati avvertiti del rischio che i talebani spostassero le armi pesanti vicino alle strutture umanitarie. Ma non abbiamo prove. Sappiamo solo che alcuni dei nostri depositi sono stati sigillati. Se s iano stati i talebani o altri, gli arabi per esempio, è difficile dirlo. Ma non è questo che ci preoccupa: siamo disposti a correre rischi, ma abbiamo bisogno di garanzie». martedi, 23 ottobre 2001 Il Pakistan fa muro: «Niente profughi»Ancora scontri tra guardie di frontiera e afghani che tentano di superare il filo spinato. Islamabad rifiuta di aprire i confini e di registrare la presenza delle migliaia di rifugiati illegaliIl Pakistan fa muro: «Niente profughi» Ancora scontri tra guardie di frontiera e afghani che tentano di superare il filo spinato DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - L' Onu denuncia: «Duecentosessanta famiglie arrivate nel campo di Jalozai». Le autorità pak istane negano: «Nessun profugo nuovo da queste parti». Sembra una commedia dell' assurdo ed è invece uno scontro politico. Ore 12 del mattino, periferia di Peshawar. Il peggiore dei mondi possibili, il campo di Jalozai, una distesa di teloni di plast ica, tende costruite con stracci, acquitrini maleodoranti, fogne a cielo aperto, è custodito dai soliti poliziotti in divisa. Da settimane continuano ad arrivare centinaia di persone in fuga dall' Afghanistan. Ma per entrare, qui come in altri campi, ci vuole un' autorizzazione speciale, difficile da ottenere. Ogni notizia viene filtrata all' entrata. «Nessun profugo nuovo», insistono i responsabili del campo. E i dati dell' Onu sui rifugiati? Gli afghani che si incontrano in città? Non esistono , non ci sono. E se ci sono, non figurano come tali. All' Afghan Refu gees Commissariate, l' organismo locale che da oltre vent' anni sorveglia i campi, non ci sono funzionari autorizzati a parlare con la stampa. L' unico che lo fa, chiede l' anonima to: «L' Alto commissariato Onu continua a dire che 1000 afgani passano la frontiera ogni giorno. Dove sono? Dove vanno? Entrano illegalmente, e pertanto non possono essere considerati profughi». Ancora la commedia dell' assurdo. Poi l' uomo ammette: «Sì, qualcuno arriva in Pakistan, ma non più di 20 o 30 famiglie al giorno». Il problema è un altro: «Abbiamo due milioni di vecchi rifugiati in questa zona, quelli arrivati dal 1979 in poi, gestiamo 48 campi e siamo al limite. Non possiamo permetter e nessuna altra entrata». A 16 giorni dall' inizio dei bombardamenti angloamericani sull' Afghanistan, le frontiere pakistane continuano a rimanere chiuse. A Peshawar funziona. Chi vuole entrare, può farlo comunque attraverso le aree tribali, amminis trate dai capi locali, senza alcun controllo da parte del governo federale. Più giù, a Chaman, la terra di nessuno si apre in pieno deserto. Quelli che scappano da Kandahar sono da giorni intrappolati sotto il sole, chiusi tra le milizie integraliste e le guardie di frontiera. Quindicimila persone, secondo l' Unhcr. Ieri sono passati in mille, buttandosi contro il filo spinato, sfondando la frontiera, tirando sassi. I talebani hanno tentato di fermarli a bastonate, le guardie pakistane sparando in aria, ripetendo gli stessi scontri del giorno prima, durante i quali sono rimaste ferite cinque persone. Ma a fine giornata, il portavoce del ministro degli Esteri Riaz Muhammed Khan ribadiva: «La scelta giusta è tenere chiuse le frontiere. Il Pak istan non può permettersi un flusso massiccio di nuovi rifugiati». I rappresentanti del governo ripetono la stessa musica: l' Onu deve occuparsi di distribuire gli aiuti all' interno dell' Afghanistan per impedire alla gente di fuggire. E le bombe? L ' emergenza continua a essere negata. A Peshawar molti dei nuovi arrivati scompaiono nelle case di Hayat Abad, il quartiere afghano, ospitati da parenti e amici. Nessuno li registra, nessuno li scheda, nessuno li vede. Altri si accampano dove possono . A ridosso di Nasir Bagh, un altro insediamento creato dai vecchi rifugiati, tra case di fango, mercati puzzolenti, canali di scarico, ce ne sono un migliaia che hanno trovato alloggio in un fazzoletto di terra, nascosto dietro un cancello e una mur aglia terrosa. Lo spazio appartiene a un proprietario terriero dell' area tribale. Per restare lì, gli afghani pagano 200 rupie al mese, quasi ottomila lire, un piccolo capitale da queste parti. L' emergenza umanitaria passa al libero mercato. martedi, 23 ottobre 2001 Dal chirurgo ai volontari: gli italiani in prima linea FRONTE UMANITARIO Dal chirurgo ai volontari: gli italiani in prima linea DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Qualche settimana fa lo si vedeva con il passo nervoso di sempre, nella hall del Pearl Continental di Peshawar a cercare il modo per rientrare in A fghanistan. Dopo la chiusura del suo ospedale di Kabul, per mano della polizia religiosa dei talebani, dopo lo scoppio della crisi con gli Stati Uniti, tutte le strade sembravano chiuse. Poi ce l' ha fatta. Gino Strada, il chirurgo italiano di Emerge ncy, è tornato. Stavolta sulla linea del fuoco, nel suo primo ospedale, costruito ad Anabah all' ingresso della valle del Panshir, nei territori controllati dall' Alleanza del Nord. Ha ancora il passo nervoso, ma ogni mattina respira aria di guerra. Proiettili e schegge da estrarre. Feriti da mina da operare. Mu ja hed din da rianimare. Tra gli italiani coinvolti nelle attività umanitarie della regione, Gino Strada è il più conosciuto. Il volto mediatico dell' emergenza. Si sono raccolti fondi p er i suoi ospedali. Si sono lanciate campagne per sostenere le sue attività. Una sorta di console del nostro governo. Ma ci sono altri, una decina o poco più, che in questa crisi giocano ruoli chiave. Alberto Cairo, per esempio. Un piemontese dal vol to scavato, barba brizzolata, occhialini di metallo. Il suo centro di Kabul, un laboratorio dove si producono protesi per i mutilati di guerra, è diventato in pochi anni una delle strutture più efficienti della città. Nemmeno i talebani, generalmente diffidenti verso gli operatori umanitari, hanno mai avuto da ridire sul lavoro di questo fisioterapista dal carattere schivo, arrivato in Afghanistan 12 anni fa come funzionario del Comitato della Croce Rossa internazionale. L' hanno lasciato fare, affidando alle sue mani i moncherini dei loro parenti, degli ufficiali, dei civili che incappavano sulle mine abbandonate nel Paese. Un asceta, Cairo. Dodici ore di lavoro al giorno, serate in casa, nessuna apparizione nel club degli espatriati. «Più afghano degli afghani», dicono gli amici. Più contrariato di chiunque altro, quando gli è stato ordinato di lasciare Kabul. Oggi si trova a Faisabad, anche lui nelle aree controllate dall' opposizione, a fabbricare protesi in un nuovo laboratorio de lla Croce Rossa. Ad Islamabad ha lasciato un collega, Mario Musa, il portavoce dell' organizzazione, impeccabile nei suoi gilet di taglio locale, ciuffo alla Di Caprio sulla fronte. Nato a Como 32 anni fa, Musa è passato da Jaffna, nello Sri Lanka de i Tamil, al Congo Brazzaville durante la guerra civile, prima di arrivare in Afghanistan. A Kabul si occupava di «comunicazione». «Avevano ottenuto uno spazio su Radio Sharia, la radio dei mullah, per far passare messaggi in difesa dei diritti umani» . Tra una fatwa e l' altra, si era inventato persino una soap opera «didattica» ambientata in un villaggio afghano. In Pakistan, rilascia interviste: savoir faire e volto perfetto per la tivù. Rambo e burocrati, star e cervelli. Tra gli italiani si i ntrecciano vocazioni diverse. Antonio Donini è per esempio la vera eminenza dell' emergenza. Nato a Trento 55 anni fa, cresciuto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, dovunque lo portasse il padre, direttore dell' istituto italiano di cultura, Donini coordina tutte le attività umanitarie dell' Onu per l' Afghanistan. Vive a Islamabad, parla italiano con accento inglese, ha sempre un sorriso sornione sotto i baffi e un collegamento costante con New York. Con lui lavora una donna: Letizia Rossano, 34 anni, trasferita in Pakistan due anni e mezzo fa con figlia e marito. Un altro italiano ai vertici è Filippo Grandi, responsabile dell' Alto commissariato per i rifugiati nella regione. Gli anni scorsi l' avevano visto a Goma, nell' ex Zaire, a gestire l' emergenza seguita al genocidio ruandese. Poi è passato al quartier generale, come assistente di Sadako Ogata. Oggi è di nuovo in prima linea, sempre in viaggio tra Pakistan e Iran, i due Paesi sui quali rischiano di riversarsi ma ree di nuovi rifugiati. Pochi i volontari delle organizzazioni non governative. Giorgio Tarditi, 29 anni, responsabile dei progetti di Coopi, è arrivato sei mesi fa in Afghanistan, dopo essere passato per il Congo, il Ruan da e il Kosovo. Oggi ha lasciato gli staff locali a gestire i programmi sanitari e si è trasferito a Peshawar, dove lavora alla costruzione dei nuovi campi profughi. Bombe o non bombe, anche lui vorrebbe tornare in Afghanistan. Gli aiuti ONU In Afghanistan operano due agenzie dell' Onu: l' Unicef (il Fondo delle Nazioni Unite per l' infanzia) e l' Unhcr (l' Alto commissariato Onu per i rifugiati). Il Pam (Programma alimentare mondiale) provvede a distribuire cibo alla popolazione CARITAS L' organizzaz ione umanitaria cattolica si occupa in Afghanistan soprattutto dell' assistenza ai profughi CROCE ROSSA Raccoglie e porta aiuti per l' assistenza sanitaria, ma anche per procurare tende e alimenti ai profughi BAMBINI Degli aiuti all' infanzia si occu pano in particolare le organizzazioni non governative «Save the children» e «Terre des hommes» lunedi, 22 ottobre 2001 Il megafono del mullah chiama alle armi Il megafono del mullah chiama alle armi DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Sangue, soldi, braccia per la Jihad. «Venite fratelli, versate il vostro contributo e Allah vi ricompenserà». Sulle arterie principali di Peshawar, megafoni e striscioni suonano la grancassa della mobilitazione. La macchina propagandistica dei mullah pakistani ha montato campi di reclutamento, baracchini e ospedali a cielo aperto per registrare donazioni e disponibilità. Un primo punto di raccolta è a ridosso del Jinnah Park, i giardini pubblici intestati al padre della nazione. Sono un paio di banchetti, presieduti da zelanti attivisti con il turbante nero, dove si promettono arruolamenti per chi vuole combattere con i talebani. Basta dare nome, indirizzo, numero di tele fono. «E la chiamata arriverà». Scribacchini barbuti prendono nota su un quadernone da scuola elementare. «Per oggi siamo a 300». Avanti un altro. «Ecco, i nostri volontari per l' Afghanistan». Attaccate alle assi di legno immagini di mitra, spade de ll' Islam, foto di martiri kashmiri dai corpi straziati. Sfaccendati e poveri straccioni sporgono il naso a spiare chi partirà. Agenti politici si accarezzano il gilet. Venditori ambulanti si trascinano in spalla fondine di pistola e gilet mimetici. Si fa avanti un aspirante combattente, felice di potersi autodenunciare. Si chiama Nasir Ahmed, è un afghano di 20 anni dalla faccia lunga e triste, emigrato a Peshawar lo scorso inverno per vendere vestiti al bazaar. Racconta: «Ho già combattuto con i talebani, nel 1996, quando abbiamo conquistato Kabul. Da lì vengo e lì voglio tornare per difendere il mio Paese dagli americani». Altri danno soldi, poche rupie a testa, a fine giornata non sono nemmeno cento dollari, un mucchietto di banconote s u un telo blu, ma «è il gesto che vale» dicono i mullah. I partiti religiosi, come il Jamiat Ulema Islam, contano sulle associazioni giovanili per tenere alta la propaganda filo talebani. Studenti religiosi e soprattutto studenti laici per dimostrare che è il popolo intero a volere la Jihad. Ma le trincee afghane, passaporto per i paradisi di Allah, sono ancora lontane. «Il nostro obiettivo è reclutare 50 mila guerriglieri - dice Obeid Kureish, un pakistano di 22 anni che si occupa degli arruola menti -. Quando avremo raggiunto questa cifra chiuderemo le iscrizioni». Traguardo vicino: ne avrebbero registrati 40 mila. Lavoro assiduo, ma forse inutile. I primi 2 mila combattenti mandati in Afghanistan, sono stati rispediti indietro. «I taleban i non li hanno voluti. Hanno problemi a sostenere i propri soldati, per poterne mantenere altri. Ma ci hanno assicurato che quando comincerà la vera invasione di terra delle truppe americane ci chiederanno aiuto». Gli agit-prop procedono comunque: ce rcano forze giovani da mandare sul terreno. Età degli iscritti: dai 22 anni ai 30. Professione: studenti, commercianti, pochi sarebbero i nullafacenti. «Li abbiamo divisi in tre categorie. La prima comprende quelli che hanno già combattuto in Kashmir e in Afghanistan. Saranno organizzati in commandos e mandati in prima linea. Ci sono poi i soldati semplici, con minore esperienza, e per finire i ragazzi che non hanno mai partecipato a nessuna guerra. All' inizio rimarranno nelle retrovie, man man o impareranno dai più anziani». Se l' appello dovesse scattare, assicura l' arruolatore, basteranno 24 ore a spedire i volontari oltre frontiera. «Il distretto di Peshawar è stato diviso in nove zone e ogni zona con un suo capo, capace di trasmettere immediatamente l' ordine di mobilitazione». Partiranno a mani nude: kalashnikov e bazooka saranno consegnati al di là del confine. Patto di sangue con i talebani? Sulla strada di Ayat Abad, la township degli afghani, davanti alla facciata di una gra nde moschea in costruzione, ecco aprirsi un' improvvisata corsia d' ospedale. Sui lettini di legno e rafia, disposti a quadrato ai bordi della strada, si rilassano una mezza dozzina di donatori di plasma, con la manica ancora sollevata e un batuffolo di cotone a tamponare la puntura. «Dono il mio sangue ai fratelli musulmani - dice con una certa enfasi Omar Bareshi, autoqualificatosi come presidente di un' associazione di studenti laici -. E' per Osama, è per i feriti, è per la nostra madre patr ia». C' è anche un' ambulanza parcheggiata tra bancarelle di frutta, un medico - il dottor Aklhaq Ahmad - e degli infermieri che si passano da una mano all' altra sacche di sangue. Quindici donatori alle 11 del mattino. Aghi e siringhe buttati dove c apita, tra mosche e rifiuti. «Il sangue viene analizzato contro l' Hiv, l' epatite, altre malattie - assicura il medico -, e poi consegnato al consolato afghano che lo recapiterà ai talebani». Forse questo arriverà prima dei combattenti. I megafoni i nsistono: «Fratelli musulmani date il vostro contributo e Allah vi ricompenserà». domenica , 21 ottobre 2001 E nella retrovia di Peshawar si prepara il dopoguerra a suon di dollariAlberizzi Massimo, IL GRANDE GIOCO DEGLI «OPPOSITORI» E nella retrovia di Peshawar si prepara il dopoguerra a suon di dollari DAI NOSTRI INVIATI PESHAWAR - E' il ritorno degli ex mujaheddin, dei capi guerriglia, dei vecchi comandanti pronti a riprendere le armi per ent rare nel «grande gioco» in cui si deciderà il futuro dell' Afghanistan. Nelle retrovie di Peshawar, alla frontiera pakistana, riappaiono - come negli anni Ottanta - gruppi e fazioni decisi ad approfittare della campagna militare americana per affossa re il regime dei talebani, ma soprattutto per garantirsi un ruolo in un prossimo governo del Paese. E' un nuovo fronte in maggioranza pashtun, nutrito di esuli e oppositori, che si differenzia dall' Alleanza del Nord con il suo mosaico di litigiose e tnie. Uno schieramento con un unico referente: re Zahir Shah, l' ex monarca esiliato a Roma, attorno al quale si continuano a tessere le alleanze più varie. L' ultimo leader tornato sulla ribalta di Peshawar si chiama Haji Mohammed Zaman. Ha 44 anni, due mogli, dieci figli e un passato sulle trincee antisovietiche. E' rientrato da Parigi per rifondare l' esercito del re, mettendo assieme i vecchi capi militari della sua provincia, quella di Nangarhar nell' Est dell' Afghanistan, e altri seguaci nelle regioni di Kunan, Nooristan, Laghman, dove i talebani sono più deboli. «Ho contatti con 160 comandanti, tutti disposti a combattere contro gli integralisti - spiega, accovacciato su un tappeto -. Abbiamo appena raggiunto un accordo per unificar e le differenti fazioni. Ma prima di passare alle armi ci proponiamo un altro obiettivo: parlare con i talebani, chiedere loro che si arrendano». Il progetto è nato a Roma, a fine settembre, durante la riunione nella quale re Zahir Shah ha incontrato esponenti dell' opposizione afghana assieme ad alcuni membri dell' Alleanza del Nord. «Il patto è chiaro: creare un primo gabinetto che comprenda esponenti di vari gruppi». Non è la loya jirga di cui si parla tanto, l' antico consiglio supremo, ma l ' abbozzo di un futuro governo trasversale. Amici e nemici, tutti attorno a un tavolo? Il re negozia con l' Alleanza del Nord, mentre i pashtun sgomitano per avere la loro parte. E anche i talebani, perché no? La novità, nel gioco delle alleanze, è p roprio questa: individuare le ali «moderate» con cui poter trattare e alle quali offrire future responsabilità. Il ministro degli esteri Muttawakil? Il capo delle operazioni militari Jaluddin Haqqani? A Peshawar si hanno idee diverse sul ruolo dei fo ndamentalisti. Zaman non si perde in dettagli: «A Kabul ci sono migliaia di studenti coranici pronti a rovesciare il regime». Riunioni pubbliche, contatti segreti, trame all' ombra degli americani. A Peshawar passa di tutto in questi giorni. M a ancora una volta si aspetta che siano gli Stati Uniti a legittimare azioni «parallele» contro il regime di Kabul. Denaro e armi, in altre parole. Ogni gruppo cerca di accaparrarsi la sua parte. Per il momento, è solo un' attesa: «Ho incontrato sia esponenti del congresso americano sia del Pentagono - dice Mohammed Zaman -. Tante promesse, ma non abbiamo ancora ricevuto un soldo». Qualcosa sarebbe invece già arrivato nelle mani di un altro veterano della Jihad, il comandante Abdul Haq, eroe di guerra con un piede perso in battaglia, residenza e affari miliardari a Dubai. Anche lui recluta combattenti, tratta con i dissidenti, prepara la fronda ai talebani. Il suo piano d' intervento, una rivolta nazionale fomentata dal basso, è stato tradi to dai bombardamenti statunitensi: «Stavamo procedendo velocemente», dice. Abdul Haq nega di aspirare alla carica di primo ministro, così come di aver ricevuto soldi dall' America: «Hanno detto che sono stato pagato da Washington, dall' intelligence pakistana, dall' Iran. La verità è che non ho visto un centesimo, mentre le bombe occidentali sui talebani rischiano di creare nuovi consensi attorno al regime». Anche lui è amico del re. Anche lui è convinto che bisogna creare una struttura politica sulla quale fondare un nuovo esercito. Ma l' ordine è di aspettare. La rete degli oppositori è fittissima. Amici, nemici, non ha importanza. Tutti assieme in attesa del banchetto finale. Gruppi e fazioni, con la benedizione di anziani e capi tribali , intensificano le attività diplomatiche sulla rotta Roma-Peshawar. Ancora il re. Dopo la delegazione inviata da Zahir Shah in Pakistan nei giorni scorsi, oggi sono gli afghani a muoversi. Un gruppo di monarchici arriva in Italia a trattare con il ve cchio sovrano. Massimo A. Alberizzi domenica , 21 ottobre 2001 «I profughi sono già decine di migliaia per i Paesi donatori restano fantasmi» LA PORTAVOCE DELL' ONU «I profughi sono già decine di migliaia per i Paesi donatori restano fantasmi» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - I profughi afghani continuano a riversarsi alle frontiere. Anche ieri migliaia di anziani, donne, bambini in fuga dai bombardamenti anglo-americani hanno passato il confine clandestinamente, entrando in Pakistan dal Beluchistan o dalle aree tribali attorno a Peshawar. Fantasmi senza status e senza nome. Ufficialmente non esistono. Tanto il governo del Pakistan quant o i donatori internazionali si rifiutano di riconoscere che l' emergenza umanitaria è già cominciata. «Le frontiere restano chiuse. Ogni giorno chiediamo che vengano aperte, che si proceda alla registrazione dei nuovi arrivati, alla distribuzione deg li aiuti - dice Corinne Perthuis, portavoce dell' Unhcr, l' Alto commissariato Onu per i rifugiati a Peshawar -. Ma non siamo ancora stati autorizzati a intervenire». Rimangono abbandonati a se stessi? «Non solo. L' esodo ha fatto fiorire traffici e corruzione. C' è chi si occupa degli spostamenti, dei trasporti, dei passaggi di frontiera. Tutto a danno dei rifugiati». Quanti sono i nuovi arrivati? «Il ministro degli Interni del Pakistan stima 2 mila arrivi al giorno. Dall' inizio della c risi, 60 mila persone avrebbero passato il confine, ma si tratta di una proiezione aritmetica. L' unica certezza è che non possiamo più considerarli profughi invisibili. Sono sotto gli occhi di tutti». Che cosa fa l' Unhcr per aiutarli? «Abbiamo comi nciato a muoverci una settimana fa. Non ci importa che vengano riconosciuti come rifugiati. Stiamo preparando una strategia che ci permetta comunque di soccorrerli». In che modo? «Abbiamo diviso la regione di Peshawar in nove aree. In ciascuna, i nos tri team stanno verificando quante persone sono arrivate veramente dall' Afghanistan. E da qui partiremo, per preparare i primi interventi sanitari. Poi passeremo alla scolarizzazione e alla distribuzione degli aiuti». Significa che fino ad ora non è stata prevista nessuna assistenza? «I nostri programmi umanitari in Pakistan sono stati sospesi sei anni fa, quando il governo ha decretato che i vecchi profughi afghani si erano ormai integrati». L' anno scorso ci sono stati nuovi arrivi. Come siet e intervenuti? «Con programmi d' emergenza e niente di più. Ma tutto si è fermato». Ogni giorno davanti ai vostri cancelli ci sono decine di persone che consegnano delle lettere. Chiedono assistenza? «Spesso sono vecchi profughi che si spaccia no per nuovi e sperano di ottenere qualcosa. Per evitare problemi abbiamo deciso che i prossimi interventi andranno a tutti gli afghani indipendentemente dalla loro data d' arrivo». Dove vivranno i nuovi profughi? «Si distribuiscono in parte nei vecc hi campi, in parte presso le famiglie. Possiamo solo sperare che le strutture esistenti riescano ad assorbirli». Il governo ha previsto nuovi campi nell' area tribale. Quando saranno pronti? «Continuiamo a ispezionare i siti, ma è una follia. Bisogna passare decine di check point, superare ogni giorno nuovi ostacoli burocratici. L' area tribale è una regione fuori controllo: dovremmo creare campi profughi a due passi dal confine afghano, con i talebani arroccati sulle montagne». Il governo vi ch iede di operare all' interno dell' Afghanistan. Riuscite a fare qualcosa? «L' ultimo dipendente dell' Unhcr rimasto in Afghanistan, un locale, ha lasciato Jalalabad ieri con la famiglia. La città è ormai deserta, come Kandahar e Kabul. Il Programma a limentare dell' Onu manda camion con gli aiuti, ma li consegna al governo». E gli appelli lanciati ai donatori? «Non hanno funzionato. Abbiamo chiesto 50 milioni di dollari (oltre 100 miliardi di lire) per assistere 300 mila persone. Ne abbiamo ricev uti 12. I donatori, Stati Uniti in testa, continuano a dire che la nostra stima (un milioni di rifugiati pronti a passare la frontiera) è gonfiata. Per la comunità internazionale l' emergenza non esiste». sabato , 20 ottobre 2001 Civili in fuga sotto i bombardamenti A migliaia diretti verso il Pakistan. Le organizzazioni umanitarie temono il collasso PESHAWAR - Nasreen mostra le ciabatte di plastica. «E' con queste che sono scappata da Kabul. A volto scoperto. Non avevo neanche il chador addosso». In fuga sotto le bombe, trascinando i figli per mano. «Siamo saltati su un taxi, il primo che è pass ato. Via dall' Afghanistan, il più lontano possibile dalla guerra». Nasreen ha 40 anni, ne dimostra venti di più. Il viso cotto dal sole, quattro stracci addosso. «Siamo morti di fame, non abbiamo più soldi, dateci qualcosa per carità». Altre braccia si tendono tra la folla. Altri volti di donne stravolte dalla rabbia, bambini appesi al collo, ragazzini febbricitanti. «Kandahar è distrutta, la mia casa è crollata - urla un' altra donna -. Ci sono morti dappertutto. E che cosa fa il Pakistan? Non fa nulla per noi». Grida, ressa e spintoni contro un cancello. Fila dietro la porta di un ambulatorio. Sulle sterrate di Hayat Abat, il quartiere dei fuoriusciti afghani alla periferia di Peshawar, un centinaio di famiglie chiedono cibo e medicine a i volontari dell' Afghanistan Women Council, un' organizzazione umanitaria che si occupa dell' assistenza ai profughi. «Facciamo quello che possiamo - dice la presidente Fatana Gailani -. Ma la situazione è disperata. Ogni giorno arrivano nuovi rifug iati e non c' è nessuna struttura pronta ad accoglierli». Nessun campo allestito. Nessun aiuto ufficiale per chi passa la frontiera. Chi viene dall' Afghanistan, in fuga dai bombardamenti angloamericani, si accampa dove può. I disperati nella melma d i Jalozai, una distesa di tende di plastica e fogne a cielo aperto. I più fortunati nelle case di amici e parenti, gli ex rifugiati di vent' anni di guerre. «Qualcosa deve cambiare - dice Fatana Gailani -. E' il momento che tutti comincino a lavorare seriamente». L' emergenza è cominciata davvero. Lo ammettono le agenzie umanitarie: «E' il giorno peggiore dall' inizio dei bombardamenti», dichiara Ron Redmond, portavoce dell' Onu in Pakistan. Diecimila persone hanno passato la frontiera nell' ult ima settimana, 3.500 solamente ieri. «Il flusso è continuo, la situazione caotica». Il panico collettivo. I profughi arrivati da Kandahar raccontano di aver visto cadaveri lungo le strade, gente morire negli ospedali per mancanza di medicine, bambini stremati dalla fame. E passa solo chi paga: 3 mila rupie a testa, 50 dollari, una somma enorme per qualunque afghano. Ci sono stati scontri alla frontiera: i profughi contro le guardie, resse per forzare i cancelli. Le agenzie umanitarie prevedono u n milione e mezzo di persone. Il portavoce dell' Onu è ottimista: «L' arrivo dei profughi sarà accolto con nuove regole dal governo pakistano». Quel confine di Chaman, a sud nel Beluchistan, l' altro di Torkham a un' ora di strada di Peshawar, chiusi o aperti a secondo degli umori dei doganieri, si trasformeranno in punti d' ingresso ufficiali? «Aspettiamo l' autorizzazione per portare acqua e cibo ai nuovi profughi», dice Redmond. Ma il governo del Pakistan, con 2 milioni e mezzo di rifugiati i n casa, prende tempo: teme che la nuova marea di afghani destabilizzi il Paese. Apre le frontiere solo per i feriti. Chiede alle organizzazioni umanitarie di occuparsi degli sfollati rimasti all' interno dell' Afghanistan e di lasciar perdere gli alt ri. La richiesta ha già creato una crisi politica con le organizzazioni non governative (Ong): «I nostri autisti hanno paura a guidare all' interno del Paese, visto gli errori così frequenti nei bombardamenti americani», dice Justin Forsyth, portavoc e della britannica Oxfam. Le Ong propongono di sospendere i raid. Da Londra contrattaccano: «L' unico modo per evitare una crisi umanitaria è rimuovere i talebani dal potere», dice Clare Short, ministro britannico agli Aiuti internazionali. Pronta la risposta dal fronte della carità: «Il ministro è influenzato dai suoi padrini politici», contesta la portavoce di Oxfam, ricordando che diverse aree dell' Afghanistan saranno presto bloccate dalla neve. «Dobbiamo distribuire 70 mila tonnellate di ci bo e i bombardamenti non ci permettono di farlo». Il caos nella gestione del caos. lunedi, 15 ottobre 2001 Attraverso le sbarre del confine i medici pakistani raccolgono i feritiLa fondazione, di ispirazione laica, si occupa anche di accogliere e sfamare i profughi. Tra i ricoverati, una ragazzina di 17 anni, traumatizzata dai bombardamenti che le hanno ucciso il padreI parenti li accompagnano come possono fino alla frontiera. Di lì le ambulanze dei volontari li trasportano negli ospedali Attraverso le sbarre del confine i medici pakistani raccolgono i feriti DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Dal cancello di Torkham v edono gli aerei militari sorvolare la frontiera. Nel buio possono immaginare l' eco dei bombardamenti sopra Jalalabad, a un' ora di macchina dal confine. Ma è al mattino che medici e infermieri pakistani, accampati davanti alla dogana tra le montagne del Khyber Pass, cominciano ad aspettare i feriti che arrivano dall' Afghanistan. In una settimana ne hanno raccolti una decina, trasportati dai parenti fino alle inferriate a bordo di taxi, pulmini, auto sgangherate. Li caricano sulle ambulanze per partire a sirene spiegate, walkie-talkie alla mano, verso gli ospedali di Peshawar. Sono un centinaio di volontari dislocati con 16 ambulanze in tre punti di confine. Lavorano per l' Edhi, una fondazione caritatevole d' ispirazione laica, entrata l' anno scorso nel Guinness dei primati proprio per le sue ambulanze: 600 in tutto il Pakistan. «Non appena è scoppiata la crisi - racconta il coordinatore Sanaullah Khan Tareen, 63 anni, occhialini di metallo su un viso ben rasato, gilet rosso e cappello con visiera - abbiamo spostato l' unità-disastri da Islamabad a Peshawar». Non è la catastrofe umanitaria che si temeva nelle retrovie pakistane: medici e infermieri si erano preparati ad accogliere centinaia di persone. Ma in questa guerr a volutamente invisibile, combattuta al di là di un confine ufficialmente blindato, i numeri contano poco. «Abbiamo soccorso un uomo con le gambe tranciate da una scheggia, una donna con il polmone destro squarciato, altri con le ossa fracassate sott o le macerie». Sanaullah Khan Tareen è un ex ufficiale dell' esercito. «L' aver passato tanti anni a sparare, mi ha insegnato anche a curare la gente», commenta con un' ironia amara. «Nessuno sa che cosa succede veramente in Afghanistan. Ci arrivano notizie di gente in fuga, interi villaggi che si spostano, famiglie nascoste sulle montagne. Se gli americani intensificheranno i bombardamenti a sud, sono sicuro che l' emergenza scatterà davvero». L' uomo conosce bene le retrovie, sin dai tempi del la Jihad. Ma il problema adesso è il blocco alla frontiera. La sua organizzazione, creata nel 1948 da Abdullah Sattar Idhi, un filantropo di Karachi che ancor oggi controlla personalmente le operazioni umanitarie a sud, nel punto di confine di Chaman , ha portato soccorsi in Turchia durante il terremoto, in Bosnia, Kosovo, Somalia durante la guerra. «Ci occupiamo anche di sfamare migliaia di profughi afghani che ogni giorno passano la frontiera illegalmente - dice Sanaullah, mostrando un deposito pieno di sacchi di riso -. Ma in cima alle nostre preoccupazioni restano i feriti». Invisibili o meno. All' Hakhabat Hospital, ce n' è uno: Dod Mohammed, un uomo di sessant' anni immobilizzato su un letto. «La casa gli è crollata addosso e una scheg gia l' ha trafitto al collo», racconta un parente prima che le infermiere impongano il silenzio. Qualche giorno fa, nello stesso ospedale è arrivato Mohammed Raza, anche lui colpito al collo, dopo aver visto morire un figlio e un fratello sotto i mis sili americani. Al Khyber Hospital, un giovane medico pakistano, Tariq Jabbar Khan, è tornato dall' Irlanda per mettere a punto un piano d' emergenza: «Abbiamo riservato cinquecento posti letto alle vittime afghane. Forse troppi, ma ci aspettavamo un a situazione come quella scattata durante la Jihad». Ha ricoverato solo due persone, una ragazzina di 17 anni, Ferida, e un vecchio di 70, traumatizzati dai bombardamenti. Gli altri? «Mistero». La ragazza si trova nel reparto psichiatria, raggomitola ta sotto un lenzuolo a fiori. Si vede solo una ciocca di capelli e un fisico stremato da una precedente tubercolosi. C' è la madre accanto a lei, avvolta in un velo bianco: «Mio marito è morto sotto le macerie. Farida quando l' ha visto è rimasta imp ietrita. Si è portata le mani alle spalle, come rattrappite, e di colpo si è accasciata sul pavimento». E' successo mercoledì scorso. Da allora la ragazza non ha più parlato. Le è rimasto uno sguardo assente. Occhi persi tra i fuochi di quella notte. L' amaro destino di un popolo in fuga PROFUGHI Più di 20 anni dopo il ritiro dell' esercito sovietico dal Paese, quella afghana è la più grande comunità al mondo di profughi provenienti da una stessa nazione. Secondo l' Alto Comm issariato per i rifugiati dell' Onu più di 3,5 milioni di afghani risiedono già in Pakistan (2 milioni) e in Iran (1,5 milioni). Benché entrambi i Paesi abbiano chiuso le frontiere con l' Afghanistan, si calcola che dall' 11 settembre 15-20 mila prof ughi abbiano passato illegalmente il confine con il Pakistan FERITI Da domenica scorsa, quando sono iniziati i bombardamenti americani, alle migliaia di profughi si sono aggiunte anche alcune decine di feriti, che medici e infermieri pakistani aspett ano stando accampati con le loro ambulanze alla frontiera sabato , 13 ottobre 2001 Pakistan, la preghiera diventa rivoltaInni a Bin Laden, scontri e morti. Nelle moschee raccolti fondi per la guerra santaPakistan, la preghiera diventa rivolta Inni a Osama, scontri e morti. Nelle moschee raccolti fondi per la guerra santa DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Megafoni e bastoni non bastano per la jihad. I fratelli talebani hanno bisogno di fondi. Ed ecco che davanti alla Moschea di Madni, ultimo oratorio della militanza islamica nel suk di Peshawar, i mullah pakistani montano banchetti per raccogliere gli oboli dei contribuenti alla guerra santa. Qualche giorno fa registravano le reclute da inviare in Af ghanistan. Tiravano sassi contro la polizia. Ma oggi il centro della città è chiuso da posti di blocco, sacchetti di sabbia, filo spinato. I dimostranti sono circondati da file di poliziotti, sorvegliati a terra dalle truppe speciali, in cielo dagli aerei militari, tenuti a bada con blindati e mitragliatori. Gli attivisti dei partiti religiosi arrivano a bordo di camion decorati come carretti siciliani, ciascuno con le proprie milizie, armate di bastoni e bandiere. Marciano a squadre, passi pesa nti sull' asfalto, il nome di Osama ritmato a ogni incitamento dei mullah, mille-due mila persone scagliate contro «Bush-Blair- Musharraf». A Peshawar, le misure di sicurezza imposte dal regime sembrano funzionare. Il venerdì di protesta e preghiera, ulteriore test per la tenuta del governo pakistano in questi giorni di tensione crescente e minacce di golpe, si conclude pacificamente. Gli agenti fermano in tempo i sobillatori. Come Sufi Mohammed, leader religioso del Malakand, uno dei distretti dove il fondamentalismo ha preso il sopravvento. «Era in città, ma gli hanno impedito di arrivare alla moschea», protesta Abdul Jalil, numero due del Jamiat Ulema Islam. A Quetta è diverso. La rivolta degenera in scontri con la polizia. Quattro morti per terra. A Karachi è una giornata di assalti: sassaiole dai dimostranti, lacrimogeni dalla polizia, due autobus, tre macchine e due moto bruciate. I manifestanti prendono di mira un fast food di una catena americana, fanno irruzione, appiccano le fiamme. Il corteo si conclude con tre feriti. Nelle aree tribali partono colpi tra manifestanti e polizia, mentre nei villaggi e nelle campagne si lavora nell' ombra. Nei giorni scorsi migliaia di studenti coranici sarebbero partiti da Chassada, rocc aforte dell' integralismo a un' ora di macchina da Peshawar. Da Haqqani, la scuola coranica che ha formato i quadri dei talebani, si leva invece una voce inaspettatamente pacata: «Non toccate gli stranieri», dice il maulana Sami ul Aq, leader religio so agli arresti domiciliari. Giorni agitati per il Pakistan. Il presidente Pervez Musharraf celebra l' inizio del suo terzo anno al potere - dopo il golpe del 12 ottobre 1999 con il quale destituì Nawaz Sharif - rafforzando le misure di sicurezza in tutto il Paese. I suoi ordini sono perentori: «Le moschee non saranno usate come piattaforme per agitazioni politiche». I toni decisi: «Ci sono alcuni elementi che stanno tentando di distruggere l' ordine, ma non sarà permesso a nessuno di pre ndere la legge nelle proprie mani». Dà mano libera nell' applicazione delle leggi anti-terrorismo, minaccia di mandare l' esercito in piazza. Ma la corte che lo circonda non è la stessa che due anni fa lo portò al potere. Il capo dei servizi segreti, il generale Mahmood Ahmad, licenziato nei giorni scorsi, secondo l' Fbi potrebbe essere coinvolto negli attentati terroristici. Il vice capo di Stato maggiore Muzarraf Hussain Husmani, sarebbe stato fatto fuori dopo che si era opposto all' utilizzo delle basi militari pakistane da parte delle truppe Usa. Lo scontro è violento, le voci di golpe incalzanti. Due le ipotesi: colpo di mano degli integralisti o colpo di Stato dei militari. C' è però l' ambasciatrice statunitense a stroncare ogni vell eità. Faccia a faccia con i generali, la signora Wendy Chamberlin ricorda che, con gli americani in zona, qualunque mossa contro Musharraf è sconsigliata. I mullah non si arrendono. Sebbene le folle sulle piazze non siano oceaniche, come vorrebbero f ar credere, lunedì protesteranno ancora: serrata generale, annunciano, contro la visita di Colin Powell a Islamabad. venerdi , 12 ottobre 2001 I misteri di Omar e famiglia, protetti dal silenzio e dalla burqa Profughi arrivati in Pakistan riferiscono che nei raid sarebbero morti il patrigno e il figlio di dieci anni del mullah I misteri di Omar e famiglia, protetti dal silenzio e dalla burqa DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Comandanti, consiglieri, guardie d el corpo. Erano questi gli ospiti che frequentavano la villa di Kandahar, dove il mullah Omar viveva e riceveva i suoi amici, prima che un missile americano sventrasse l' edificio. Mai una sagoma femminile, un' ombra oltre le mura che potesse rivelar e ad estranei qualche segreto sulla vita privata del leader dei talebani. Solo Land Cruiser dai vetri neri parcheggiate all' interno e una corte di uomini armati. Sull' emiro che, per la prima volta dai tempi del Saladino, ha dichiarato la Jihad all' Occidente, cala un nuovo mistero. Chi c' era dentro la casa al momento dell' attacco? Chi sono i due parenti che sarebbero rimasti uccisi? Il mullah Omar sarebbe uscito in tempo, pochi minuti prima che cominciassero i bombardamenti. Alcuni profughi arrivati in Pakistan raccontano che sarebbe morto il patrigno del mullah (lo zio che ha sposato la madre rimasta vedova), e un figlio di dieci anni. Il resto della famiglia? Nella cultura musulmana chiedere troppo sugli affari personali di qualcuno n on è mai segno di buona educazione. Ancor meno se si tratta di un leader che ha costruito la sua fama sulla discrezione e il silenzio. Si può dire qualcosa sulla casa: una grande residenza, mediamente lussuosa, non troppo moderna, protetta da una mur aglia tra la polvere e le sterpaglie di Kandahar. Poco sul resto. Non si sa nemmeno che faccia abbia il mullah Omar. Secondo il quotidiano pakistano The News, le due immagini circolate nelle ultime settimane, che ritraggono un uomo barbuto, dai tratt i regolari e la corporatura slanciata, sarebbero fasulle. L' unica foto esistente del comandante supremo dei Talebani si troverebbe sulla sua carta d' identità. In quanto alla famiglia, si conoscono le origini: povera gente, contadini senza terra del la tribù degli Hotak, gruppo dell' etnia pashtun. Omar nasce nel 1959 nel villaggio di Nodeh, vicino Kandahar. Perde il padre da ragazzo e, in cerca di lavoro per mantenere i parenti, si sposta a Singesar, altro villaggio della zona. Non ha tempo per studiare, il futuro mullah. L' invasione sovietica lo porta tra le file dei mujaheddin. Alla fine della Jihad diventa mullah e apre una sua madrassa. La guerra lo coglie di nuovo, contro il regime filosovietico di Najibullah e ancora nel 1994 con la nascita dei talebani. Tra una battaglia e l' altra sposa tre donne, di cui una si dice «bella come una principessa da Mille e una notte». Una delle tre, o forse la quarta, secondo voci ripetutamente smentite, sarebbe la giovanissima figlia di Osama Bin Laden. Prolifico, ma senza eccessi, il mullah. Il giornalista pakistano Ahmed Rashid, l' unico che abbia tracciato una sua biografia, gli attribuisce cinque figli. E le mogli? Altri comandanti le hanno messe in salvo in Pakistan. Su quelle dell' emiro, nessuna indicazione. Fantasmi senza nome, sotto le pieghe della burqa. mercoledi, 10 ottobre 2001 «Musharraf prende ordini da Washington. Ma non riuscirà a fermare la protesta» IL GENERALE HAMID GUL «Musharraf prende ordini da Washington Ma non riuscirà a fermare la protesta» DAL NOSTRO INVIATO RAWALPINDI (Pakistan) - Ha un piccolo trofeo esposto in salotto: un frammento del muro di Berlino, arrivato dalla Germania come ric onoscimento «all' uomo che ha dato la prima picconata all' impero sovietico». Il generale Hamid Gul, capo dell' intelligence militare pakistana durante l' invasione russa in Afghanistan, si vanta ancora dell' appoggio dato ai combattenti della jihad: «Se il mondo è stato liberato dai comunisti, il merito è dei mujaheddin». Il generale - un' elegante residenza sulla strada per Rawalpindi - ha lasciato l' esercito nel 1992, ma la sua influenza sugli affari afghani continua a pesare. Vicino ai tale bani e agli «arabi» di Osama Bin Laden, guarda con simpatia la nuova «guerra santa» che parte nelle strade del Pakistan. Anche ieri, gli integralisti islamici hanno fronteggiato forze di polizia e truppe paramilitari. A Quetta cinque persone, tra cui un ragazzo di 13 anni, sono rimaste uccise dagli agenti. In una cittadina vicina, assalto alla centrale della polizia. A Chaman, sulla frontiera, hanno sfilato 2 mila persone, a Karachi 5 mila. Manifestazioni a Lahore e a Peshawar. «Aspettatevi nuov e violenze, e non solo in Pakistan - dice il generale -. Se i bombardamenti americani sull' Afghanistan continueranno la protesta dilagherà in tutto il mondo musulmano». Il governo pakistano sta reagendo con durezza. Non crede che sia in grado di fermarla? «Il presidente Musharraf avrebbe dovuto fermare gli Usa. I gruppi islamici non vogliono sfidare l' esercito, ma i sentimenti anti-americani sono molto forti. Se vuole mantenere la poltrona, Musharraf deve scegliere una politica più vici na agli umori della gente». Perché ha cambiato i vertici dell' esercito e dei servizi segreti? «Musharraf sostiene che si tratta di un avvicendamento di routine. Ma è perché l' America vuole che gli islamici stiano fuori dall' esercito». Si parla già di un nuovo governo per l' Afghanistan. Chi verrà «salvato» tra i leader dei talebani? «Gli americani potranno mettere un loro governo a Kabul, ma non riusciranno a controllare il resto del Paese. Ritorneranno i vecchi signori della guerra. Non sarà Zahir Shah, il re in esilio, a garantire pace e stabilità. Non lo vuole l' Alleanza del Nord e non lo vogliono nemmeno gli afghani. Un leader c' è già ed è il mullah Omar: un uomo coraggioso e rispettato dalla sua gente». martedi, 09 ottobre 2001 Scontri con gli estremisti islamici, morti e feriti LA PIAZZA IN RIVOLTA Scontri con gli estremisti islamici, morti e feriti DA UNO DEI NOSTRI INVIATI PESHAWAR (Pakistan) - Stavolta sono pietre. Arrivano assieme alle urla, contro i poliziotti schierati con scudi e bastoni attorno al Namk Mandi, il «me rcato del sale», nei labirinti polverosi di Peshawar. Sono copertoni bruciati, colonne di fumo tra i palazzi fatiscenti, una bandiera americana data alle fiamme. Gli agenti caricano, partono i lacrimogeni. Ogni dieci minuti rimbombano colpi. Ogni vol ta nuvole di gas. «Arrivano i talebani», grida la folla. «Mullah Omar, siamo tutti con te». Lo sguardo di Osama ammicca beffardo dalle magliette in vendita sui marciapiedi. Centinaia di dimostranti, partiti dalla scuole coraniche, dalle moschee, dall e sedi dei partiti fondamentalisti per protestare contro i bombardamenti anglo-americani sull' Afghanistan, corrono per il centro della città, finché il canto del muezzin non preannuncia la preghiera del mezzogiorno. Tensione in tutto il Pakis tan. Non è come nei giorni scorsi, quando i cortei si limitavano a recitare cori di slogan contro il presidente Pervez Musharraf e la sua alleanza con Washington. I missili lanciati sull' Afghanistan rischiano adesso di far precipitare lo scontro pol itico tra governo e integralisti. Sette feriti, riferiscono nel pomeriggio in un ospedale di Peshawar. Una telecamera rotta, pugni e spintoni, raccontano i giornalisti di una tivù giapponese. A Quetta, la città del Beluchistan dalla quale partirono s ette anni fa i primi «studenti coranici» alla conquista dell' Afghanistan, la manifestazione è ancora più violenta. Anche qui ci sarebbero un morto e decine di feriti. Migliaia di fiancheggiatori dei talebani si scontrano con la polizia. Attaccano un ufficio dell' Unicef e un palazzo dell' Alto commissariato per i rifugiati nella zona dell' aeroporto. «Un nostro edificio è stato parzialmente bruciato - conferma il portavoce dell' Unicef Gordon Weiss - ma gli staff umanitari sono al sicuro». In c ittà vetrine rotte e assalto a un cinema che espone locandine di film americani. Contro gli stranieri un ulema locale ha emesso addirittura una «fatwa», un editto religioso. Nei villaggi vicino alla frontiera le truppe paramilitari stanno per perdere il controllo della folla. A Karachi, le strade sono bloccate dai manifestanti, mentre a Islamabad 3 mila studenti organizzano un sit-in davanti all' American Center. «Chi è amico degli Usa è un traditore», ripetono all' unisono. In testa ai cortei s filano i volti severi dei maulana, i «grandi maestri» dell' Islam. Sono loro, i quadri del Jamiat Ulema Islam, a minacciare da settimane la guerra santa contro gli Usa. Assieme agli altri partiti religiosi non superano il 9% dei consensi. Alle elezio ni politiche del 1997, le ultime prima del colpo di Stato del generale Musharraf del 1999, il leader Fazrul Rehman si era addirittura visto strappare voti da Musarat Shahin, una procace attricetta di serie b. Ma l' influenza dei fondamentalisti, radi cata in 7 mila e 500 madrasse sparse per il Paese, fa sempre paura. Il governo li ha messi in guardia ordinando gli arresti domiciliari di Rehman e di un altro leader, Sami Ul Haq. I loro toni sono cambiati. Non parlano più di guerriglieri da mandare in Afghanistan. «Chi vuole andare vada da solo», dice un mullah. Solo di nuove, interminabili proteste. A Peshawar continuano a volare sassi. «Che vogliono questi?», commenta un commerciante. «Non contano niente. I pakistani stanno con il governo». Ma il fumo dei lacrimogeni si porta via in un colpo di tosse le sue ultime parole. lunedi, 08 ottobre 2001 Estremisti islamici in piazza in Pakistan. «Noi ci batteremo a fianco dei talebani» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - La voce del maulana risuona sotto gli archi dipinti di bianco e di beige della moschea: «Fratelli, il governo del Pakistan sta svendendo la nostra terra, le nostre tradizioni, il sangue degli afghani». Riecheggia come un sermone nei vicoli fangosi del suk di Peshawar, tra il fumo dei barbecue e gli scarichi delle motociclette. «Fratelli, siate pronti a qualunque sacrificio». Ma il giorno della rabbia, della mobilitazione generale contro gli arresti domiciliari di Fa zlur Rehman, il leader del Jamiat Ulema Islam, megafono politico della guerra santa, si spegne a metà pomeriggio con una veloce passerella di bandiere bianche e nere, sventolate da poche centinaia di dimostranti appena fuori dal bazaar. L' attacco am ericano sull' Afghanistan non è ancora cominciato. E i capi religiosi, sotto pressione del presidente Pervez Musharraf, si trincerano dietro minacce di rito: «Quando il momento arriverà, saremo pronti a combattere con i talebani», dice Attana Rehaman , il fratello dell' arrestato, sprofondato a gambe incrociate in una mole di grasso. Il momento arriva alle 9,30 di sera. Prime bombe su Kabul, comunica la Cnn. La reazione è immediata. I mullah escono dalle loro case, riaprono la moschea. Duecento p ersone sono nel cortile. Visi scuri, parole concitate. Non si tratta della solita parata. «Questo è un atto terroristico, un gesto disumano e brutale», grida Abdul Jalil, vicesegretario regionale del Jamiat Ulema Islam. «Domani protesta di piazza in tutte le città del Pakistan, Inshallah». Partiranno i reclutamenti nelle scuole coraniche? Nuove schiere di mujaheddin passeranno la frontiera in aiuto dei talebani? A sorpresa il governo libera Fazlur Rehman. L' uomo che in queste settimane ha organ izzato decine di cortei anti- americani può raggiungere i suoi accoliti per decidere le prossime mosse. «Domani, vi faremo sapere», ripete il numero due del partito. La folla si riversa fuori dalla moschea. E' il secondo corteo della giornata. «Lunga vita a Osama». «L' America è il nostro nemico». Le strade del centro, sonnolente fino a qualche minuto prima, adesso rimbombano di slogan. E' il quartiere dell' università il più affollato: un migliaio di studenti escono dagli alloggi e si radunano all' esterno. La polizia circonda la zona. Qualcuno tira pietre contro gli agenti. Nelle botteghe ancore aperte gracchiano le radioline, decine di persone si assiepano davanti agli schermi della tv. «L' Afghanistan sarà la tomba degli americani», bla tera un vecchio. «Perché bombardano gente innocente?», si chiede uno studente. E' un coro di frasi già udite, ma stavolta il «nemico» ha colpito davvero. Nei tavolini all' aperto, ai crocicchi dei bazaar si disegnano scenari a largo raggio: «Gli Usa hanno dichiarato guerra a tutto il mondo musulmano», dice Mohammed Khan, un commerciante. «Cominciano con l' Afghanistan per attaccare l' Iran, il Pakistan, la Cina. Vogliono imporre il loro potere su tutta l' Asia». Nei quartieri dei fuoriusc iti afghani, si sfiora la rissa: i pashtun con i talebani, gli altri - i dissidenti - con l' America. «Finalmente cadrà il regime - commenta un monarchico. - Finalmente potrà tornare il nostro re». La notte di Peshawar diventa sinistra. La polizia mo nta i primi posti di blocco attorno alla città. Protetto anche il consolato americano, l' ex «centrale» della Cia durante l' invasione sovietica. L' allerta scatta nei principali ospedali: nei reparti d' emergenza, allestiti nei giorni scorsi, i medi ci si preparano al peggio. Profughi, feriti, malati. Una marea di gente in fuga potrebbe riversarsi alle frontiere. Un milione di persone, come teme l' Onu. Forse di più. Peshawar, l' ex città delle trame e degli intrighi, diventerà la nuova retrovia dell' Afghanistan, come fu negli anni Ottanta durante la Jihad contro i russi? Molto dipenderà dal Jamiat Ulema Islami e dagli altri partiti religiosi. La loro influenza sulle scuole coraniche e su gran parte della popolazione di etnia pashtun è for te. Come la capacità di mobilitazione. Dalla loro parte, starebbero ancora gli stessi esponenti dell' esercito e dei servizi segreti che in passato hanno appoggiato i talebani. Ma oggi la politica del presidente Musharraf è cambiata. Il suo appoggio agli Usa sottrae terreno ai gruppi fondamentalisti. Se qualche anno fa era possibile chiudere le madrasse e spedire migliaia di studenti oltre frontiera a combattere con i talebani, adesso ogni operazione di questo tipo deve essere gestita per canali clandestini. Il Pakistan rimane in bilico. «Speriamo in una fine rapida delle operazioni militari - ha dichiarato ieri il ministero degli Esteri in un comunicato ufficiale -. Sono state prese tutte le precauzioni per ridurre al minimo il male inflit to al popolo afghano che soffre da 20 anni a causa della guerra». mercoledi, 03 ottobre 2001 «Solo sei settimane di tempo per soccorrere i profughi» «Solo sei settimane di tempo per soccorrere i profughi» DA UNO DEI NOSTRI INVIATI PESHAWAR (Pakistan) - I primi camion sono arrivati a Kabul: 200 tonnellate di cibo inviate dal Programma alimentare dell' Onu attraverso la frontiera pakistana. Altri s ono partiti dal Tagikistan verso le aree controllate dall' opposizione, altri ancora dal Turkemenistan e dall' Iran. L' agenzia umanitaria promette 50 mila tonnellate di aiuti al mese all' Afghanistan per il prossimo semestre, mentre l' Unicef ha già mandato teli di plastica e coperte, utilizzando 800 asini per trasportare vestiti, cibo, acqua attraverso il passo di Shah Saleem al confine del Pakistan. La macchina dei soccorsi si è messa in moto. L' altro ieri è arrivata a Islamabad il sottosegr etario agli Esteri Margherita Boniver, per garantire l' impegno dell' Italia nella crisi umanitaria. Il personale delle agenzie Onu ha chiesto ai Talebani di poter rientrare in Afghanistan. Ma restano solo sei settimane di tempo per raggiungere 5 mil ioni e mezzo di persone considerate a rischio. Dopo arriveranno le gelate. Le strade diventeranno impraticabili. Molte aree saranno tagliate fuori dai soccorsi. L' incertezza è generale: ogni intervento si svolge al buio in un Paese isolato da fronti ere chiuse, senza comunicazioni, con l' ipoteca di un attacco militare americano che potrebbe riversare alle frontiere un milione e mezzo di profughi. «Il problema per il momento è all' interno del Paese - dice Antonio Donini, responsabile a Islamaba d del coordinamento umanitario per l' Afghanistan -. Con l' avvicinarsi dell' inverno e la paura della guerra, si stanno intensificando gli spostamenti di popolazione verso i villaggi di origine. Aumenterà certamente il numero di convogli umanitari, ma dobbiamo puntare anche, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, a ritornare nel Paese». L' esodo all' esterno rimane clandestino: tra le 15 mila e le 20 mila persone avrebbero passato il confine pakistano a Chamann, nel Beluchistan, e cent inaia di famiglie sarebbero entrate allo stesso modo nelle zone attorno a Peshawar. Il Pakistan progetta di costruire nuovi campi profughi: un centinaio di siti sono stati individuati all' interno delle aree tribali. L' Unhcr, l' Alto commissariato p er i profughi dell' Onu, ne ha visitati una trentina. «Ma non è una proposta che ci soddisfa. Sono posti difficilmente raggiungibili, dove manca l' accesso all' acqua e qualsiasi garanzia di sicurezza», dice Filippo Grandi, coordinatore regionale del l' Alto commissariato. Amministrate da capi locali, dotate di milizie proprie, rappresentato una zona off limits per qualsiasi visitatore: vi si entra solo con un permesso e con una scorta armata. Controllate dai pashtun, la stessa dei Talebani, potr ebbero trasformarsi inoltre in una retrovia degli integralisti. mercoledi, 03 ottobre 2001 STRUMENTI PER CAPIRE gli effetti sulla POLITICA ESTERA. gli effetti sull' ECONOMIA. gli effetti sulla SOCIETÀ STRUMENTI PER CAPIRE gli effetti sulla POLITICA ESTERA La guerra in Afghanistan può essere vinta? E la guerra al terrorismo? Gli americani potranno vincere delle battaglie, eliminare degli avversari, ma controllare l' Afghanistan è impossibile. Una c ampagna terrestre comporterà un numero di perdite alte sia tra i militari che i civili. Inoltre la storia insegna che chiunque si sia avventurato nel Paese, dagli inglesi ai sovietici, ne è uscito sconfitto. Terzo elemento: imporre un nuovo regime al posto dei talebani non garantisce stabilità. Terrorismo: la sola risposta militare è insufficiente. E' una minaccia che muta continuamente, ha carattere globale ed è spinta dal fanatismo religioso. Le società occidentali non sono in grado di superar e la sfida a meno di sacrificare principi intoccabili. I talebani possono essere sostituiti? Da chi? Si sta preparando un fronte di resistenza interno che dovrebbe portare alla sostituzione del regime dei Talebani. La soluzione politica più accredita ta è la Loya Jirga, l' antico consiglio supremo, caduto in disuso negli anni ' 70 con la fine della monarchia. Si tratta di un organismo largamente rappresentativo formato da saggi, anziani, capi tribali religiosi, che comprenderebbe i rappresentanti di tutte le etnie, le tribù e le fazioni politiche di ogni regione dell' Afghanistan. Il garante di questo progetto dovrebbe essere l' ex re Mohammed Zahir Shah, in esilio a Roma dal 1973. Il vecchio monarca sta già preparando una nuova struttura po litica militare, pronta a combattere e sostituire i talebani. Esiste davvero il pericolo di un attacco chimico o batteriologico? Sappiamo che la rete di Osama Bin Laden e altre fazioni estremiste cercano da molto tempo di sviluppare armi di distruzio ne di massa. Non è facile usarle, ma l' attacco in Giappone, nel metrò di Tokio, avvenuto nel 1995 ha dimostrato come sia possibile per un gruppo bene organizzato usare gas o sostanze venefiche. Questo aspetto resta l' aspetto più inquietante del con flitto. Anche perché un attentato chimico o batteriologico porterebbe a una risposta durissima dell' Occidente, con il rischio di alterare i fragili equilibri dei Paesi islamici oggi schierati con Stati Uniti ed Europa. Saddam Hussein non svolge alcu n ruolo in questa crisi? Entra ed esce dal conflitto. Si è parlato di possibili complicità irachene nel complotto, tuttavia fino ad oggi non sono state esibite prove. Dovesse spuntare qualche prova Bagdad finirebbe nel mirino degli Usa. A Washington, comunque, non si esclude che l' Iraq possa essere colpito in una seconda fase, anche se questo comporterebbe serie ripercussioni nei rapporti tra Usa e mondo arabo. Più in generale è possibile che Saddam tema, come conseguenza della crisi, un miglio ramento dei rapporti tra Stati Uniti e Iran, che lascerebbe l' Iraq in un isolamento assoluto. Questa crisi avvicinerà o allontanerà la soluzione del problema palestinese? È una delle domande cruciali di questo conflitto. Ci sono possibilità di uno s viluppo positivo. Gli Stati Uniti hanno lanciato ieri il primo segnale dicendosi a favore della nascita di uno Stato palestinese. Una mossa dettata dalla necessità di mostrarsi, agli occhi dei musulmani, interessati al lungo conflitto in Terrasanta m entre stanno per lanciare l' offensiva anti-Osama Bin Laden. Gli arabi accusano infatti Washington di un doppio standard: vogliono punire chi viola la legge internazionale ma non fanno adeguate pressioni su Israele affinché si ritiri dai territori oc cupati. gli effetti sull' ECONOMIA È cominciata la recessione? La risposta è sì, anche se i numeri ancora non la registrano. Gli Stati Uniti erano già vicini alla recessione prima dell' 11 settembre: ora ci stanno entrando a vele spiegate. Europa, As ia e resto del mondo seguiranno, anche a causa del calo delle esportazioni verso gli Usa. Di certo, le crisi sono già in atto in settori come turismo, aerolinee, trasporti merci, assicurazioni, telecomunicazioni, intrattenimento, lusso, pubblicità. I noltre, è quasi scontato un calo generale dei consumi. Una recessione sincronizzata tra Usa, Europa e Giappone non si registra da 30 anni. Quando inizierà la ripresa dipende molto dagli sviluppi, anche militari, della campagna contro il terrorismo. L a globalizzazione subirà una frenata? Se sì, in quali campi? In un primo momento, certamente sì: i rapporti commerciali tra Paesi saranno meno facili, sia sul piano fisico sia su quello psicologico. Caleranno gli investimenti diretti e di portafoglio nei Paesi emergenti. La circolazione di manodopera, anche qualificata, potrebbe rallentare. Sul medio periodo, tutto dipende dalla campagna contro il terrorismo. La prospettiva peggiore è quella di chiusure sempre maggiori tra le economie e d i protezionismo (scenario anni Trenta). La migliore vede un ritorno a una globalizzazione sempre più aperta e cosciente dei problemi politici e sociali da affrontare. Aumentare gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo potrebbe ridurre la minaccia terror istica? In sé, no: gli attacchi dell' 11 settembre non sono stati provocati dalla povertà del mondo e Osama Bin Laden non è un difensore degli oppressi. Più aiuti possono però sanare alcune ingiustizie sociali e ridurre lo spirito anti-occidentale ch e si registra in numerosi Paesi poveri. Ma, più importante degli aiuti, è riuscire a fare entrare questi Stati in un meccanismo di commercio internazionale a loro favorevole: fornirli degli strumenti per creare le loro economie. Anche attraverso una sorta di Piano Marshall per il Terzo Mondo. In questo periodo i risparmiatori devono stare lontani dalla Borsa? Tutti i manuali di investimento sconsigliano la fuga dalla Borsa nei momenti di panico. Chi vende senza remore, rischia di portare a casa perdite irrecuperabili. Per alleggerire con razionalità il portafoglio azionario bisogna aspettare i giorni in cui gli indici recuperano. Diverso è il discorso per chi ha nuovi flussi di liquidità da impegnare: parcheggiarli a basso rendimento ma al sicuro è una buona idea nell' attesa che i listini trovino nuovo slancio. Infine non bisogna dimenticare che i momenti di ribasso sono, per chi riesce a superare la paura, i migliori per cominciare a investire in azioni, magari a rate. In ogni caso l ' investimento azionario va sempre considerato in un' ottica di lungo periodo. Investire in immobili è una buona alternativa alla Borsa? Il mattone è tradizionalmente considerato un bene rifugio nei momenti bui dell' economia. Ma quando la crisi è da vvero profonda, le quotazioni degli immobili spesso crollano insieme a tutto il resto. Va anche tenuto presente che il settore ha conosciuto una forte crescita negli ultimi anni e quindi i prezzi sono piuttosto elevati. Diversificare una parte del patrimonio in case e affini è però una scelta giusta. Se non si hanno capitali a sufficienza per un acquisto diretto, si può puntare sui fondi comuni specializzati nel settore o sui fondi immobiliari. gli effetti sulla SOCIETÀ Viaggiare in aereo è diventato rischioso? È sconsigliabile? Tutto il mondo è diventato più rischioso di quanto non lo fosse prima dell' 11 settembre. La tragedia delle Torri gemelle ha dimostrato la vulnerabilità di qualunque sistema e agglomerato urbano. Gli a ttentati negli Stati Uniti hanno tuttavia fatto emergere la necessità di adottare con urgenza misure di sicurezza per aerei e aeroporti che mai in passato erano state contemplate. Nel clima di insicurezza generale, dunque volare e frequentare aeropor ti dovrebbe diventare più sicuro che nel recente passato. Quali sono le città considerate obiettivi possibili del terrorismo? L' Italia è a rischio? Difficile stabilirlo. In cima alla lista ci sono città come Los Angeles, Londra, Parigi, Berlino e pi ù in generale le grandi capitali europee. Anche l' Italia è a rischio. Lo è in quanto alleata degli Usa e Paese occidentale, perché nel nostro Paese hanno agito e agiscono cellule legate al terrorismo di matrice islamica. L' Italia, nel quadro di que sta sfida terroristica, rappresenta anche un simbolo per la sua storia, per le sue città d' arte, per la presenza del Vaticano. I piani che il governo sta allestendo per la sicurezza dei cosiddetti «obiettivi sensibili» (monumenti, acquedotti, aeropo rti, strutture industriali) tengono conto di questi pericoli. Ha senso comprare le maschere antigas? Nonostante la corsa di migliaia di persone, soprattutto negli Stati Uniti, a comprare maschere antigas, è purtroppo un acquisto che non ha grande sen so. La maschera antigas può avere efficacia su un campo di battaglia dove l' impiego da parte del nemico di agenti chimici o batteriologici è prevedibile e circoscritto. Se i terroristi ci aggredissero con ordigni biochimici ce ne accorgeremmo probab ilmente soltanto a contaminazione avvenuta e, pertanto, la maschera antigas sarebbe del tutto inutile. A questi aspetti bisogna aggiungere che non tutti i filtri vanno bene per ogni tipo di agente chimico o batteriologico. Le nuove norme sulla sicurezza ridurranno gli spazi delle libertà civili? E' molto probabile che le nuove norme di sicurezza finiranno per ridurre spazi, libertà di movimento e forse libertà civili. Non a caso c' è già chi ha posto il problema se sia opportuno limitare la libertà di movimento attraverso gli Stati europei contemplata dal Trattato di Schengen (entrato in vigore il 26 ottobre 1997). Anche la privacy personale ed elettronica subirà probabilmente qualche condizionamento. Tra le leggi internazionali invocate conro l' antiterrorismo c' è la richiesta di nuovi documenti di identità obbligatori per tutti i cittadini. Volare (viaggiare) costerà di meno o di più? Nell' immediato volare e viaggiare costerà meno perché compagnie aeree e gruppi turistici do vranno affrontare il crollo del mercato e vorranno convincere la gente che è ancora possibile viaggiare in assoluta sicurezza. Nel medio termine, anche per la necessità di ammortizzare i maggiori costi che verranno imposti dalle nuove misure di contr ollo, è invece ipotizzabile una risalita di prezzi e tariffe. Le compagnie più «gettonate» saranno quelle capaci di garantire il più alto grado possibile di sicurezza. Un esempio: agenti a bordo del velivolo. lunedi, 01 ottobre 2001 PROFUGHI «A Kabul è il terrore, le milizie coraniche arruolano i bambini» IL RACCONTO DI UNA PROFUGA «A Kabul è il terrore, le milizie coraniche arruolano i bambini» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR (Pakistan) - Quattro giorni di marcia verso il Khyber Pass. Duecento chilometri a piedi o a dorso di mulo, tra valichi di montagna che si intervallano a deserti pietrosi, villaggi in rovina e fortini di fango. Sono le 5 del mattino quando Anisa, 42 anni, si lascia alle spalle Kabul, con i suoi nove figli, unendosi a una carovana di anziani, donne e bambini in fuga dalla capital e. «Scappiamo per paura dei bombardamenti americani. Per paura che l' opposizione attacchi e arrivi in città. Perché non c' è acqua, non ci sono soldi. Ma soprattutto per salvare i nostri figli dalle retate dei talebani». L' ultimo incubo delle madri di Kabul sfila negli occhi, piccoli e vivaci, di una profuga afghana arrivata in Pakistan. E' un tonfo di pugni contro la porta, un rintronare di urla, l' irruzione delle milizie coraniche a caccia di nuovi soldati. L' età non importa, racconta Anis a, chiunque sia in grado di premere un grilletto è costretto ad arruolarsi. «Sono venuti anche da me, a cercare Mohammed, che ha 14 anni. Sono riuscita a nasconderlo dentro il tandoori, il vaso per il pane». Altre vicine sono state scoperte, i loro r agazzini caricati sui pick up dai barbuti guerrieri di Allah, altre ancora hanno visto sparire mariti e fratelli. I fotogrammi da Kabul disegnano una città nel caos. «La gente è terrorizzata - spiega Anisa -. I capi militari hanno abbandonato la capi tale, lasciandola in mano alle squadracce. Non c' è famiglia che non abbia subito saccheggi, rapine, richieste di tangenti. Per noi donne è difficilissimo: appena i mariti escono di casa, arrivano i talebani a prenderci a bastonate». Qualunque cosa a ccada - si legge nello sguardo di Anisa - nuove rovine copriranno le vecchie, da vent' anni è così: invasori rabbiosi torneranno ad accanirsi sulla devastata geologia della città. «Arriverà l' Alleanza del Nord? Torneremo a vedere il generale Dostum con le sue tribù? Perderemo tutto?». Anisa si anima, il tono della voce diventa concitato. Una ciocca di capelli ricci, tirata dietro l' orecchio, spunta fuori dal velo bianco. Ha lasciato il marito nella capitale, a proteggere la casa, l' orto, qual che gallina. Quattro giorni di marcia con i piedi sanguinanti e la polvere del deserto che intasa gli occhi. La carovana di Anisa si sposta per sentieri secondari, evitando il tracciato diretto che porta da Kabul al Khyber Pass per scantonare i posti di blocco dei talebani. «Non c' è acqua, né cibo lungo la strada - racconta -. Non c' è un posto dove noi donne possiamo far pipì, né tende o coperte per la notte». I muli non bastano per tutti, bisogna darsi il cambio. Alla frontiera, si evita il c ancello di Torkham, chiuso dalle autorità pachistane. Ci sono altri varchi aperti. Anisa trova 2 mila profughi in attesa di passare in Pakistan. «Ma le guardie appaiono anche lì, ci chiedono una tangente di 1.000 rupie a testa (quasi 35 mila lire). I miei compagni implorano: fratelli, l' America sta per bombardare. Siete musulmani come noi, lasciateci passare. Ma quelli: passa solo chi ha il denaro». La donna paga. Arriva dall' altra parte della frontiera, in mano ai capi delle tribù. «Loro ci a iutano - spiega -, ci portano cibo e acqua. Ci procurano i mezzi per arrivare in città». Anisa, come decine di migliaia di afghani che in questi giorni tentano di passare il confine, è diventata una profuga invisibile. Ufficialmente non c' è, visto c he il governo pachistano continua a tenere le frontiere chiuse. Non ci sono campi, né strutture umanitarie pronte ad accogliere quelli come lei. Trova posto con i suoi figli ai margini di Nasser Bagh, un vecchio campo costruito durante l' invasione s ovietica, ma dovrà andarsene presto. Il governo vuole smantellarlo. Sono guai per i rifugiati che ci abitano da oltre 15 anni. Figurarsi per chi non esiste nemmeno. Il disastro umanitario I PROFUGHI Migliaia di afghani hanno lasci ato il Paese già nei mesi scorsi per sfuggire alla siccità e alla guerra civile tra talebani e Alleanza del Nord. Si sono rifugiati in Pakistan e Iran LA PAURA Dopo l' attacco terrorista dell' 11 settembre, decine di migliaia di afghani sono scappati in Pakistan e nei Paesi confinanti: l' Onu teme che il numero totale dei rifugiati possa arrivare a un milione e mezzo. I NUOVI AIUTI Il Pam, il programma alimentare mondiale, ha ripreso gli aiuti che aveva dovuto sospendere dopo gli attentati «per mancanza di condizioni di sicurezza» domenica , 30 settembre 2001 Gli americani lavorano all' accordo tra il re in esilio a Roma e l' Alleanza LE TRAME POLITICHE Gli americani lavorano all' accordo tra il re in esilio a Roma e l' Alleanza DA UNO DEI NOSTRI INVIATI PESHAWAR - La città delle trame è in fermento. L' ipotesi di un cambio di regime a Kabul trasforma Peshawar, l' ex retrovia dell a jihad contro i russi, in una fucina di dissidenti. Alla periferia della città pachistana, migliaia di fuoriusciti afghani, sparsi in una ragnatela di casbe, villaggi, quartieri residenziali, stringono alleanze contro i talebani, preparano milizie, progettano piani di rivolta. Ma oggi il nemico ha facce diverse. Tra gli oppositori della frontiera, quasi tutti di etnia pashtun, assieme alla speranza di ribaltare gli integralisti, cresce il timore che sia l' Alleanza del Nord, dominata dai tagiki , a prendere il sopravvento con l' aiuto degli Stati Uniti. I ribelli del «terzo polo», divisi in una pletora di gruppi, hanno scelto il re come futuro leader. Da Roma però, dove l' ex sovrano Zahir Shah ha annunciato la nascita di un Consiglio supre mo di salvezza per l' Afghanistan, arrivano notizie impreviste per il fronte monarchico. Il monarca, anziché rivolgersi ai suoi seguaci, vuole organizzare in una struttura militare proprio i leader dell' Alleanza. A suggellare l' accordo, il sovrano incontrerà stamattina anche membri del congresso americano. Il re ha tradito? Pir Sayed Ishaq Gailani, 48 anni, un ex mujaheddin di buona famiglia «con discendenza diretta da Maometto», non ha chiuso occhio ieri notte. «Spero che il sovrano non facci a passi avventati. L' Alleanza del Nord non piace alla gente dell' Afghanistan, né tanto meno al Pakistan». Gailani, leader del fronte monarchico, è un uomo dai modi raffinati, vestito con un abito tradizionale di seta blu. Riceve nella sua villa, pr otetto da guardie armate di kalashnikov. «I fucili sono la mia passione», dice per inciso, ricordando anche che i talebani l' hanno inserito in una lista di 80 oppositori da eliminare. Una foto del suo studio lo mostra stretto in un abbraccio paterno del re. Un' altra, giovanissimo in testa a un gruppo di mujaheddin armati di artiglieria pesante. «Il re non può pensare di creare un governo in esilio, senza coinvolgere tutte le tribù afghane. Bisogna creare una base più larga possibile». Gailani svelerà il suo progetto domani mattina: un' organizzazione che farà da ombrello a 45 gruppi monarchici. «Vi prenderanno parte giovani, intellettuali, gente interessata a portare pace e benessere in Afghanistan». Nel frattempo l' elegante signore prep ara la guerra. A lui si sarebbero rivolti migliaia di comandanti locali, sparsi per le province di Paktia, Zabol, Helmand, già impegnati a combattere contro i talebani. «Se gli Stati Uniti continuano ad appoggiare l' Alleanza del Nord, si finirà con un governo fantoccio. E nessuno dei Paesi vicini, l' Iran per primo, è disposto ad accettarlo. Bisogna escogitare una soluzione che abbia un consenso internazionale». Una soluzione, appunto. Il futuro dell' Afghanistan, senza i talebani, rischia di p rofilarsi come un ritorno al passato, agli anni tra il ' 92 e il ' 96 in cui le fazioni della jihad (le stesse che si ritrovano nell' Alleanza del Nord) si sparavano addosso l' una con l' altra, distruggendo il Paese. Altri gruppi potrebbero aggiunge rsi alla guerra di tutti contro tutti. E forse non basta un anziano re, assente da 27 anni, a garantire un equilibrio etnico e tribale, fondamentale in Afghanistan. venerdi , 28 settembre 2001 «Bush non ci fermerà. Anche dall' Italia i fondi per la guerra santa» I FIANCHEGGIATORI DI OSAMA «Bush non ci fermerà Anche dall' Italia i fondi per la guerra santa» DA UNO DEI NOSTRI INVIATI ISLAMABAD - L' uomo utilizza un nome di copertura, Jehangir. È alto, magro, ha la barba ben curata e si presenta come il portavo ce di Herakat-ul-Mujaheddin («Uniamoci ai combattenti»), una delle 27 organizzazioni «umanitarie», sospettate di terrorismo, che gli Stati Uniti hanno messo al bando chiedendo il congelamento dei conti bancari. Il suo ufficio, sulla strada tra Islama bad e Rawalpindi, è stato chiuso mercoledì dal governo pachistano. Il suo cellulare è sotto controllo. I movimenti del suo gruppo sono spiati. Jehangir non si preoccupa di smentire le accuse: «Il congelamento dei conti ci fa ridere: hanno bloccato se i milioni di rupie (poco più di 200 milioni di lire, circa 103 mila euro, ndr.) - dice -. Non teniamo mai troppi soldi in banca. I nostri fondi vengono subito destinati ai guerriglieri della jihad». L' appuntamento è fuori città. Da lì ci si sposta i n macchina in un albergo dei dintorni, che l' uomo definisce «più sicuro». Jehangir prende tempo prima di parlare. Poi comincia: «La sede centrale della nostra organizzazione è in Cecenia, mentre in Kashmir gestiamo quattro campi di addestramento. Il lavoro del nostro gruppo si concentra soprattutto a Srinagar dove prepariamo i kamikaze». Decine, centinaia? «Chiunque combatta per la jihad è pronto al sacrificio. I due kamikaze che sono stati arrestati a New Delhi dieci giorni fa erano uomini nos tri». Un altro gruppo parallelo, l' Harakat-ul-Jihad Islami, opera in Afghanistan a fianco dei talebani. «I suoi membri combattono contro le forze d' opposizione dell' Alleanza del Nord - continua Jehangir -. Uno dei padri fondatori, Qari Saif-ul-Akh tar, che figura nell' elenco dei terroristi ricercati dagli Stati Uniti, vive a Kabul». È un pachistano del Punjab, l' uomo che gestiva alcuni campi per guerriglieri durante la jihad contro i russi e avrebbe continuato a farlo fino al 1998. Entrambe le organizzazioni raccoglierebbero adepti da 34 Paesi. Jehangir abbozza un sorriso: «Se sapeste quanti finanziamenti ci arrivano dall' Italia non ci credereste. È una delle fonti più proficue». Ottimi i rapporti con Osama Bin Laden, ma si tratterebbe di una comunanza ideologica e niente più. Nessuna dipendenza, né vera affiliazione. Il portavoce di Herakat-ul-Mujaheddin l' ha incontrato tre mesi fa, «in un luogo segreto» dell' Afghanistan. «Osama non rilascia dichiarazioni contro gli Stati Uniti da tempo. Tutto quello che è apparso sulla stampa è falso. Ci finanzia? E come potrebbe? Vive isolato dal mondo». In ogni caso il terreno è comune. «Con lui dividevamo i campi d' addestramento attorno a Jalalabad e il maestro spirituale, Shee r Abdullah Azam, un giordano assassinato dalla Cia a Peshawar nel 1998 per aver rigirato ai palestinesi una partita d' armi destinata alla guerra contro i russi». La storia dell' organizzazione segue un percorso a ostacoli, fatto di clandestinità, di divisioni. La prima cellula nasce nel 1979, con l' invasione russa. Negli anni Novanta i combattenti si spostano in Pakistan. Nel 1996 tentano di rovesciare il governo di Benazir Bhutto che li ha messi al bando. E le attività umanitarie, quelle che Bush considera una copertura al terrorismo? Jehangir se ne ricorda solo ora: «I fondi che riceviamo dall' estero servono a procurare aiuti ai profughi del Kashmir». Si è fatto tardi, l' uomo si alza dalla poltrona. «È il tempo della preghiera. Devo andare giovedi , 27 settembre 2001 Stinger, il mistero dei missili dispersi ARMA LETALE Stinger, il mistero dei missili dispersi DA UNO DEI NOSTRI INVIATI ISLAMABAD - «Missing in action». L' operazione, lanciata negli anni Novanta, si chiamava proprio così, abbreviata sotto la stessa sigla (Mia) che era stata utilizzata per la guerra del Vietnam. Ma non erano soldati da recuperare nella giungla, quelli che la Cia voleva ritrovare. I «dispersi in azione» erano aggeggi lunghi un paio di metri, sufficientemente leggeri da poter essere trasportati in spalla, abbastanza pote nti da inseguire e colpire un cacciabombardiere a 4 mila metri di quota. Centinaia di missili Stinger, regalati dagli Stati Uniti ai mujaheddin afghani per contrastare l' invasore sovietico, spariti nel nulla. Tutto si ripete in questo angolo di mondo, che fece da crocevia al Grande Gioco tra russi e britannici all' epoca degli imperi e poi da spartiacque per le sfere d' influenza tra americani e sovietici. Tutto torna come un boomerang, contro i burattinai di ieri: Mosca e Washing ton ormai alleati sullo stesso fronte. Sono gli Stinger la grande incognita della guerra prossima ventura, tanto per gli Usa che li inviarono in Afghanistan, quanto per i russi che li subirono. Quanti ne sono rimasti in circolazione? E in che condizi oni? Gli esperti militari ne calcolano un centinaio, nascosti nei depositi dei talebani, e si augurano che siano catorci da rottamare. «Lo vedremo quando i caccia americani sorvoleranno l' Afghanistan», sghignazzano gli ex mujaheddin nelle zone di fr ontiera pachistane. Unico dato certo: un esperimento della Cia nel ' 99. Si provò a lanciare un vecchio Stinger: funzionava ancora. Unico elemento di conforto: può essere usato solo di giorno, mentre le Special Air Forces americane colpirebbero di no tte. L' America sbagliò tante mosse in Afghanistan. Ma questa degli Stinger va oltre l' ingenuità. Se ne comincia a parlare nel 1980, quando la Cia stila il piano segreto - nome in codice Sovmat - con il quale rimpinguerà il rudimentale armamento dei mujaheddin. Per i primi anni gli americani si limitano a fornire armi anti-tank, con la mediazione dell' Isi, i servizi segreti pachistani. Poi, nell' 86, arriva il momento dei missili terra-aria. I mujaheddin abbattono 5 cacciabombardieri e 270 eli cotteri. Gli Stinger cambiano le sorti della guerra, ma agli Usa è presto chiaro che missili e guerriglieri sono fuori controllo. Dopo il ritiro dei russi dall' Afghanistan comincia la caccia all' ordigno scomparso. «Sembra il mercato del pesce», con fessa un agente americano al Washington Post. La Cia mette una taglia di 100 mila dollari (oltre 200 milioni di lire) su ogni Stinger riportato alla base. Recupera quasi nulla. I «dispersi in azione» in compenso appaiono in Iran, transitati nelle man i dei trafficanti di droga. Nel ' 97, gli uomini di Hekmatyar, uno dei capi fazione, ne avrebbero venduti 16 ai pasdaran. Persino un paio di giornalisti stranieri in cerca di scoop - se ne discute a Kabul nel ' 95 - sarebbero possibili acquirenti. I «missing in action» non sono soli. Un' altra insidia si nasconde nelle sabbie afghane: 10 milioni di mine, sparse per il Paese. Cominciano i sovietici, poi i mujaheddin e di nuovo i guerriglieri quando scoppia la guerra tra fazioni islamiche nel 1992 . Tra le macerie dell' antico bazar di Kabul, fino a qualche anno fa, c' erano mine anti uomo nei vicoli, nelle case, sui tetti. Le squadre dell' Onu hanno cercato di bonificare le città. «Abbiamo invece marcato con pietre dipinte di rosso le zone ru rali», dice Antonio Donini, responsabile del coordinamento umanitario Onu. «Ma persino i canali sono intasati dalle mine». Per i profughi è un incubo permanente. Per eventuali truppe di terra, gli ostacoli di una gincana letale. mercoledi, 26 settembre 2001 Trecentomila «soldati di Allah» su carri armati senza cingoli L' ESERCITO DEI TALEBANI Trecentomila «soldati di Allah» su carri armati senza cingoli DA UNO DEI NOSTRI INVIATI ISLAMABAD - Una guerra si fa anche con i numeri. E quelli lanciati dai megafoni dei talebani potrebbero far paura, se fossero veri. «Trec entomila combattenti per la Jihad», ha annunciato lunedì il ministro della Difesa, il barbuto mullah Obaidullah, cavalcando l' emozione di una mobilitazione generale di fronte al nemico americano. Trecentomila guerriglieri da reclutare in un Paese di 20 milioni di abitanti, stremati da un regime oppressivo, dalla carestia e dalla guerra civile, sembrano davvero troppi. Ma i conti si fanno oltre frontiera, nelle scuole coraniche del Pakistan, sotto l' influenza del maggiore schieramento islamico, il Jamiat Ulema Islam e dei gruppi fondamentalisti affiliati. Al di là della propaganda, dei cortei nei bazar, degli auguri di lunga vita a Osama, quanti «studenti» sono veramente pronti ad aiutare i fratelli talebani? Quanti tradiranno il governo d el proprio Paese, schierato con gli Stati Uniti? Lungo le aree di confine, nel regno dei pashtun (stessa etnia degli integralisti di Kabul) la mobilitazione è cominciata, accelerata dall' offensiva lanciata dall' opposizione nel nord dell' Afghanista n. E' Quetta, nella regione del Beluchistan, dove la frontiera sfuma in un deserto rosato, il punto d' osservazione migliore. In poche ore si è a Kandahar, bastione ideologico del regime. Da Quetta gli studenti partirono nel 1994 alla conquista del P aese. Da qui, tornano a percorrere la stessa strada per rinfoltire le armate dei «puri», assediate dall' Occidente. Se ne vedono centinaia entrare in Afghanistan. Viaggiano a bordo di pick-up, hanno i turbanti in testa, ma vanno a mani vuote senza ka lashnikov. Il fucile sarà fornito dai talebani. A Temerganah, 120 chilometri a sud di Peshawar, le autorità religiose celebrano invece cerimonie per il reclutamento. A Darra, la città dove si fabbricano e copiano armi di ogni tipo, i capi tribali met tono a disposizioni le loro milizie, mentre a nord, dalla grande madrassa Haqqania, il maulana Shar Alì Shah avverte: «L' Afghanistan sarà il cimitero degli americani». Il passato insegna. Né i britannici ai tempi dell' impero, né i sovietici durante la Guerra fredda riuscirono a piegare il bellicoso Afghanistan. Ma i conti di un conflitto, oltre che con le tecniche secolari dell' agguato e della guerriglia di montagna, si fanno anche su altre varianti. Senza calcolare i nuovi rinforzi, le miliz ie integraliste contano tra i 40 mila e i 50 mila effettivi, cinque divisioni, di cui una corazzata. Tutti agli ordini del mullah Omar, che oltre a essere il leader supremo è anche il comandante delle forze armate. Gli «studenti» delle madrassa, che rappresentavano il numero originario del movimento, negli ultimi mesi si erano ridotti a 10-15 mila. Venivano utilizzati per le emergenze, poi rimandati a studiare i versetti del Corano e i detti del Profeta. Molto più affidabili, per capacità milita ri e addestramento, i mercenari islamici di Osama Bin Laden. Seimila uomini, dicono le stime più caute. Sessantamila, vuole la leggenda. Il mullah Omar li avrebbe schierati nei punti strategici: i ceceni con cavalli, cammelli, casse di munizioni, att orno alla provincia di Jalalabad, dove da tempo si addestrano in una mezza dozzina di campi, pronti a difendere il Khyber Pass. Gli uzbeki a nord di Kabul, mentre i pachistani e gli arabi del Golfo sarebbero rimasti stretti attorno ad Osama. A Kandah ar, altri arabi si sarebbero infiltrati tra la popolazione, con l' obiettivo di usare i civili come scudi umani contro eventuali attacchi delle forze americane. Il braccio destro di Osama, Juma Nyumagani, sarebbe nella capitale con ruolo di stratega a preparare la difesa del regime. Trent' anni o poco più, è considerato uno dei capi emergenti dell' internazionale del terrore, con contatti ben radicati nelle Repubbliche dell' Asia centrale. Dopo una militanza tra i ribelli islamici del Tagikistan , nel 1999 ha tentato di destabilizzare l' Uzbekistan, in testa a un gruppo di guerriglieri nascosti nella Fargana Valley, roccaforte della rivolta fondamentalista a cavallo di tre frontiere nel cuore dell' ex Unione Sovietica. Scacciato dal presiden te tagiko Enomal Rahmonov, ha trovato accoglienza presso lo sceicco saudita, suo vecchio finanziatore. Una guerra si fa con i numeri. Quante armi possiede l' esercito del mullah Omar, «comandante dei fedeli»? Dagli Stati Uniti l' International Instit ute for Strategic Studies traccia un inventario dell' arsenale lasciato in eredità dai sovietici dopo il 1992, alla caduta del regime filo russo di Najibullah: mille carri armati, 190 caccia bombardieri tra Mig e Sukhoi, una trentina di Scud. E poi, kalashnikov, bazooka, artiglieria antiaerea, oltre ai celebri Stinger, missili terra aria, regalati dalla Cia ai mujaheddin. Quel che si vedeva nei mesi scorsi sui passi di montagna dell' Afghanistan, attorno a Kabul o nei deserti rocciosi del sud, p rima che i talebani chiudessero il confine agli stranieri, è un esercito di soldati in ciabatte, mimetiche logore, più spesso tuniche tradizionali. I carri armati, per esempio: nella valle di Bamyan, a marzo scorso ce n' erano un paio, senza cingoli, nascosti tra case diroccate, con le sole torrette funzionanti come postazioni d' artiglieria. Carcasse «cannibalizzate», usate per i pezzi di ricambio, antiquati e senza manutenzione. Di tank funzionanti in giro ce ne sarebbero un centinaio. Di Mig, capaci di bombardare, sei o sette, mentre una ventina si troverebbero nelle mani di Dostom, uno dei leader dell' opposizione. Gli Scud, tra i 20 e i 30, non spaventano il Pakistan, il primo Paese che rischia di riceverli in casa. Dall' Arabia Saudit a e dallo stesso Pakistan, ex alleati del regime, sarebbero arrivati solo maestri d' addestramento ed esperti artificieri. E gli Stinger, micidiali contro gli elicotteri russi? I talebani ne avrebbero un centinaio. In condizioni ottimali possono colp ire a 4 mila metri di quota. Oggi, chissà. Ma la storia insegna: in un Paese come l' Afghanistan, le imboscate dei «soldati di Allah» possono essere più pericolose di qualsiasi arma ultra-sofisticata. Washington lo sa e aspetta a colpire, mandando av anti l' Alleanza del nord, le forze dell' opposizione guidate dai vecchi signori della guerra. Per adesso, mujaheddin contro altri mujaheddin. L' arsenale delle milizie coraniche GLI STUDENTI I talebani (letteralmente, studenti co ranici) sono i figli dei profughi afghani rifugiatisi in Pakistan durante l' occupazione sovietica (1980-89). Educati nelle madrasse, le scuole coraniche pachistane, hanno preso il potere in Afghanistan nel 1996. L' autoproclamato Stato islamico non è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite. Solo il Pakistan mantiene rapporti diplomatici con Kabul (mentre gli Emirati Arabi e l' Arabia saudita li hanno interrotti in questi giorni) IL MULLAH Il leader spirituale e politico dei talebani è il mullah Omar, uno sceicco cieco da un occhio, che sarebbe stato ferito nella guerra contro gli invasori sovietici. Il mullah Omar ha sposato una figlia di Osama Bin Laden LE MILIZIE Benché Kabul pretenda di disporre di 300 mila uomini pronti al «martirio», g li esperti dell' IISS (International Institute for Strategic Studies) stimano che i miliziani non siano più di 40-50 mila. Di questi, 7.000 sarebbero pachistani e 2.000 arabi del Golfo Persico GLI ARMAMENTI L' arsenale dei talebani consta soprattutto dei residuati bellici della disastrosa occupazione russa: 100 tank; 6 Mig (l' opposizione antitalebana, l' Alleanza del Nord, ne avrebbe una ventina); da 20 a 30 missili Scud. Tanto le milizie dei talebani quanto quelle dell' Alleanza del Nord dispo ngono anche di missili Stinger (forniti loro dagli Usa durante la guerra contro i sovietici) lunedi, 24 settembre 2001 Le grandi manovre per rovesciare il regime Gli esuli afghani cominciano a organizzare la successione. Favorita la restaurazione monarchicaLe grandi manovre per rovesciare il regime Gli esuli afghani cominciano a organizzare la successione. Favorita la restaurazione monarchica DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR (Pakistan) - La guerra alle porte scatena ipotesi, forse premature, di un cambio di regime a Kabul. Oltre la frontiera, in questa babele di gruppi, etnie e tribù che è Peshawar, capitale del nord-ovest pachistano, è già cominciata la corsa alla successione. Un milione di fuoriusciti afghani vivono qui. Una galassia caleidoscopica, nutrita di oppositori, ciascuno con un' agenda politica in testa. La domanda più frequente è: chi mettere al posto dei Talebani? La risposta più ovvia è Loya Jirga, parola magica che accomuna i moderati contro i radicali. Unica alternativa al caos. U ltima soluzione per non svendere la nazione a un futuro governo fantoccio degli Usa, salvando religione e tradizione. La Loya Jirga è l' antico Consiglio supremo, utilizzato dai monarchi afghani prima che negli anni Settanta l' impero sovietico mette sse le mani sul Paese. E' la grande assemblea dei saggi e dei notabili, 130 mila membri, formata da capi tribali, anziani, scolari e giureconsulti dell' Islam. Un' istituzione rappresentativa, con un leader carismatico: re Zahir Shah, il monarca cost retto a lasciare l' Afghanistan nel 1973, oggi esiliato a Roma. Ha 86 anni il vecchio re, il fisico ricurvo, modi raffinati e austeri. Erede di una dinastia guerriera, è ancora orgoglioso di essere stato il primo e l' unico a modernizzare l' Afghanis tan. Fu lui a fondare l' Università di Kabul, a dare il voto alle donne, le stesse che oggi vivono seppellite sotto la burqa, a trasformare la corte orientale in monarchia costituzionale. Una meteora spenta dal colpo di Stato del cugino, Mohammad Dao ud, che aprì la strada all' invasione sovietica del 1979. I rappresentanti dell' Onu lo corteggiano da anni. Anche la diplomazia italiana ci ha provato. Ma solo adesso, con la madrepatria sull' orlo della catastrofe, il monarca ha dichiarato di esser e pronto a tornare in Afghanistan. Di più: il sovrano starebbe preparando un appello alla resistenza contro i Talebani. Francisc Vendrell, l' inviato dell' Onu, l' ha incontrato ieri a Roma, mentre a Peshawar un giornale locale in lingua pashtun, il «Daily Wahdat», pubblicava la lista di coloro che potrebbero entrare nel suo futuro governo. «Le Nazioni Unite potrebbero annunciare la costituzione di un gabinetto in esilio nel giro di una settimana», scriveva il quotidiano. Negli uffici di Francis c Vendrell non si sbilanciano: «Lavoriamo da tempo a quest' ipotesi - dice il portavoce Karl Fischer da Islamabad -. Siamo in contatto con molti leader afghani che potrebbero appoggiare il re». Tra i sette nomi citati, compare Abdul Haq, comandante s torico nelle province dell' est, oggi impegnato in affari a Dubai, e Samad Hamid, ex primo ministro del re. Ci sono membri dell' Alleanza del Nord (le forze dell' opposizione del presidente Rabbani) come Younas Qanooni, ex braccio destro di Massud e anche una donna, Fatima Gilani. Nomi rispettabili? A Peshawar protestano. Una cugina di Fatima, per esempio, con un nome molto simile alla parente, Fatana Gilani. Consorte di un influente esponente del fronte monarchico, Pir Sayed Ishaq Gilani, oltre che fondatrice di un' associazione femminile, l' Afghanistan Women Council, impegnata nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro il fondamentalismo, ha da ridire: «Quella lista arriva dagli Usa. E, se i nomi scelti sono questi, si rischia d i commettere un errore. Molti di loro vivono all' estero, non sanno nulla di quello che la gente ha passato qui». La Loya Jirga è l' ultima chance, ricorda la signora, lasciando intendere che la gara d' appalto per la conquista virtuale del potere ha già schierato le lobby afghane l' una contro l' altra. Si votano alla restaurazione i commercianti afghani nei bazaar, i profughi confinati nei ghetti di periferia, le élites intellettuali e persino vecchi nomi della Jihad contro i russi. Haji Hayat Ullah, compagno in armi di un signore della guerra come Galbuddin Hekmatyar, passato poi dalla parte del presidente Rabbani, riceve in un quartiere residenziale di Peshawar. «La Loja Jirga è l' unica istituzione consona alla nostra tradizione. L' 85 per cento degli afghani la vuole». Haj Haya Ullah oggi commercia in pietre preziose, ha una sua organizzazione politica e ha preso le distanze anche dall' Alleanza del Nord. «Gli americani devono formare un governo legittimo prima di un attacco mili tare». Lo stanno facendo? L' ex guerrigliero scrolla le spalle: «Io non sono stato contattato. Altri, chissà.» sabato , 22 settembre 2001 Le donne di Kabul: «Torni il nostro sovrano» Il «fronte femminile» in esilio in Pakistan invoca la restaurazione Le donne di Kabul: «Torni il nostro sovrano» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Anche la burqa ha i suoi vantaggi. Sodaba e compagne la indossano per nascondersi, passare la frontiera sen za essere identificate, entrare clandestinamente in Afghanistan, il Paese da dove sono fuggite come profughe o perseguitate politiche. Una volta dentro c' è un' organizzazione di dissidenti che le accompagna nelle città e nei villaggi. Fino a Kabul d ove tengono in piedi una rete di aiuti che permette a molte donne afghane di sopravvivere sotto il soffocante regime dei talebani. Scaltre come piccole Mata Hari, agguerrite come femministe d' altri tempi, Sodaba e compagne minano dal basso il bastio ne di Allah: portano cibo e medicinali, organizzano scuole informali per le bambine, ma soprattutto parlano di diritti umani. In questa vigilia di guerra hanno deciso di schierarsi anche loro, ma fuori dai blocchi. Né con l' Islam né con gli american i. «Siamo le prime a chiedere che vengano sospese le coperture internazionali a questi integralisti criminali - dicono a Peshawar -. Non siamo però disposte ad appoggiare alcun intervento militare». Sodaba e compagne lavorano per il Rawa, il fronte r ivoluzionario femminile per l' Afghanistan, un' associazione nata nel 1977, impegnata nella lotta contro il fondamentalismo islamico. La loro base è il Pakistan, i campi profughi nei quali alcune si sono rifugiate durante l' invasione sovietica, altr e con l' arrivo delle milizie coraniche. Da questa parte della frontiera non portano la burqa. Solo un velo trasparente sui capelli. Ma sono controllate a vista da spie talebane e polizia. Nomi fittizi, niente foto. Sodaba, 28 anni, parla per tutte: «Siamo contro i talebani e contro l' Alleanza del nord. Gli anni dei mujaheddin sono stati i peggiori per le donne afghane». Stupri, rapimenti, violenze dal 1992 al 1996. La ragazza sfata un luogo comune: non è la burqa imposta dalle milizie coranich e, non sono gli editti del mullah Omar a segnare la discesa nel Medio Evo. Anche il comandante Massud è stato uno degli architetti della segregazione femminile. L' ultimo ricordo che Sodaba ha di una Kabul che si apriva alla modernità risale all' ini zio dell' invasione sovietica. Aveva sette anni quando è fuggita con la famiglia. Ha passato due anni in un campo profughi di Jalalabad, ai confini con il Pakistan. «Non è il velo il nostro problema - dice -. Quello che vogliamo è un Paese democratic o». Peccano d' idealismo le suffragette afghane? «No, abbiamo un programma politico: far tornare il re Zahir Sha dal suo esilio italiano, l' unica autorità riconosciuta dalla gente». E poi: «Resuscitare la loja jirga, l' antico consiglio dei notabili . Ma stavolta facendo decidere anche le donne». venerdi , 21 settembre 2001 E il principe del terrore potrebbe nascondersi fra le tribù guerriereMa c' è una seconda ipotesi: il ricercato potrebbe cercare scampo in Cecenia, altra regione fuori controlloLA VIA DI FUGA E il principe del terrore potrebbe nascondersi fra le tribù guerriere DAL NOSTRO INVIATO DARRA ADAM KHEL (Pakistan) - L' ultima segnalazione viene da Kabul. Tre giorni fa l' hanno visto salire su una jeep dai vetri scuri e poi balzare su un cavallo, come Maometto in fuga dalla Mecca, scortato da 500 mercenari arabi. Osama Bin Laden avrebbe imboccato le piste di terra gialla che si perdono tra le montagne afghane, per sparire ancora una volta nel segreto dei suoi bunker di roccia. Ma oggi, dovunque si trovi, lo sceicco saudita sembra accerchiato. I talebani stanno per scaricarlo. Persino il mullah Omar, leader supremo degli integralisti afghani, l' amico che gli ha offerto ospitalità e che è sempre rimasto in contatto con lui (due telefonate al giorno via satellitare, battute di pesca nei momenti di calma), sembra non avere altra scelta che metterlo alla porta. L' onnipotente finanziatore del terrorismo internazionale rischia di trasformarsi in un latitante braccato a ogn i frontiera, respinto anche dai governi che in passato gli sono stati vicini. Dove andrà Osama, l' uomo ricercato dall' Fbi con una taglia di 10 milioni di dollari (circa 20 miliardi di lire)? Il transito più naturale sembra l' area tribale del Pakis tan tra le cime del Khyber Pass. Una regione in gran parte inaccessibile, i stituita all' epoca della colonizzazione britannica come zona cuscinetto con l' impero russo, dove ancora oggi impera il Pashtun Wali, il codice d' onore e vendetta. Nei gior ni scorsi i capi tribali si sono dichiarati contrari all' alleanza del Pakistan con gli Usa e pronti a offrire combattenti per la Jihad. A Darra Adam Khel, la cittadina degli armaioli, una fila di botteghe aperte sulla strada principale dove si vendo no riproduzioni artigianali, perfette e funzionanti, di ogni tipo di arma leggera, sembrano tutti pronti per la mobilitazione. «Alla prima bomba americana, porto 10 mila uomini in prima linea - dice Riasullah Afrid, uno dei capi locali, seduto a gamb e larghe tra una fila di kalashnikov e fucili a pompa -. Tutti si stanno attrezzando per combattere a fianco dei talebani. Si stanno distribuendo e immagazzinando partite di armi». E non solo leggere. Nei retrobottega ci sarebbero anche lanciagranate e artiglierie pesanti. Osama potrebbe essere il benvenuto? Nelle strade non si parla di altro. La frontiera tra l' Afghanistan e l' area tribale è un colabrodo, un intreccio di interessi legati soprattutto al contrabbando, un passaggio continuo di g uerriglieri. E un' unica geografia: il Pashtunland, la terra dei pashtun, stessa etnia dei talebani. «In molte zone vige un codice collettivo, un controllo sociale dei clan che permetterebbe anche al governo del Pakistan d' identificare subito un osp ite scomodo come Osama - dice un commerciante, Salam Khan -. Ma ci sono sacche chiuse tra le montagne, come Teerah nella zona del Khyber Pass, dove agli estranei è impossibile entrare». Osama potrebbe andare lì, un covo provvisorio nella terra di nes suno. Rischierebbe però di non poter più uscire. E poi: «Si può offrire ospitalità a lui, ma cosa fare delle migliaia di miliziani arabi che lo circondano?». Se gli Usa cercano un solo uomo, si sbagliano. La forza del saudita si basa su questi combat tenti, reclutati dall' Algeria, dal Sudan, dall' Egitto, dalla Cecenia, che imperversano in Afghanistan. Il mullah Omar, dopo averli utilizzati contro l' opposizione, dovrà sbarazzarsi anche di loro. A Kabul si azzarda una seconda ipotesi: la Cecenia , altra terra fuori controllo, con guerriglieri addestrati nei campi dello sceicco. In mezzo ci sono frontiere in stato di massima allerta, come quella dell' Iran o del Tagikistan. Ma Osama potrebbe incamminarsi sugli stessi corridoi dell' Asia cent rale usati per il passaggio di miliziani, partite d' armi e carichi di droga. giovedi , 20 settembre 2001 Mille uomini cercano la risposta nel Corano DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR - Il mullah Omar stavolta ha bisogno di loro. Il leader supremo dei talebani li ha convocati da ogni angolo dell' Afghanistan per decidere se consegnare Osam a Bin Laden agli americani o se scatenare la guerra santa contro l' Occidente. Il Paese è a una svolta, il mondo in attesa. E gli ulema, i prelati del clero islamico, hanno percorso centinaia di chilometri di piste sterrate, a bordo di jeep dai vetri neri, per arrivare fino a Kabul, dove è in corso la più grande assemblea indetta in cinque anni di regime. Sono in mille, accovacciati sui tappeti del palazzo presidenziale - turbanti in testa, barbe d' ordinanza - a discutere come in una riunione d i villaggio la risposta che potrebbe cambiare la geopolitica del secolo. Fuori dall' edificio, sfregiato dai proiettili, sono schierate decine di miliziani armati di kalashnikov e lanciagranate. Oggi dovrebbe essere il giorno della fatwa, l' editto f inale. E' stato rimandato due volte, pensato e ripensato con i tempi di una cerimonia tribale. Senza testimoni, senza telecamere, in una babele di voci e pareri, destinati a rimanere confinati dentro la muraglia che circonda il palazzo presidenziale. Sarà il mullah Omar a pronunciare l' ultima parola sulla consegna di Bin Laden, ma stavolta - c' è da giurarci - l' intervento della Shura suprema, il consiglio degli Ulema, orienterà ogni decisione. Il leader si rivolge a loro - «scolari religiosi dell' Afghanistan» - per scegliere la soluzione giusta secondo lo spirito dell' Islam. Poi lancia un' offerta a Washington: «E' una disgrazia che l' America non voglia ascoltarci. In passato abbiamo avuto vari incontri con i rappresentanti del govern o statunitense. Siamo pronti a dialogare anche stavolta». Il mullah chiede le prove del coinvolgimento del suo ospite negli attentati, ma ricorda anche che se la Superpotenza attaccherà i talebani risponderanno. Gli ulema discutono per sette ore, pri ma di aggiornare l' assemblea a stamattina. Non c' è fretta, le tv di tutto il mondo possono aspettare. Ulema è il plurale di «alim», che significa scolaro. Colui che si è laureato nelle madrasse, ma soprattutto colui che è in grado di insegna re il Corano. Sono i maestri della fede, ai quali storicamente si rivolgevano le popolazioni analfabete dei villaggi per risolvere ogni problema. Un' élite che ha resistito a fatica ai continui stravolgimenti subiti dall' Afghanistan. La monarchia mo dernista di Zahir Sha, il vecchio re oggi in esilio a Roma, li aveva messi da parte. Altrettanto aveva fatto il regime filo-comunista di Najibullah. La terza umiliazione è arrivata proprio dai talebani, che hanno preferito affidare la direzione spiri tuale del regime ai mullah, i preti di base, più ignoranti e ciechi nell' applicazione della sharìa. Sotto il regime integralista gli «scolari religiosi» hanno però mantenuto un ruolo giuridico: la Suprema corte degli Ulema si è riunita per pronuncia rsi sulla distruzione delle statue pre-islamiche in Afghanistan o sull' editto che vieta di fotografare gli esseri viventi. La convocazione della Shura rimane invece un evento straordinario. Qualcuno ricorda l' assemblea del 4 aprile 1996, quando furono gli ulema a regalare al mullah Omar il titolo di Amir ul-mumineen, «comandante della fede». Si era tenuta a Kandahar, santuario morale dei Talebani. Oggi a Kabul, capitale politica. Segno che gli equilibri del regime sono forse cambiati. Di front e all' emergenza che sta vivendo l' Afghanistan, al mullah Omar non bastano i tre Consigli che fanno da pilastro al governo: la Shura principale di Kandahar, quella amministrativa di Kabul e quella militare. E' il momento dei maestri della fede mercoledi, 19 settembre 2001 «In Pakistan siamo centinaia di migliaia pronti alla guerra santa con l' America» IL LEADER DEL PARTITO ISLAMICO «In Pakistan siamo centinaia di migliaia pronti alla guerra santa con l' America» DAL NOSTRO INVIATO PESHAWAR (Pakistan) - I nuovi mujaheddin cominciano a contarsi. «Siamo centinaia di migliaia - dice Abdul Jalil Jan, l eader del partito Jamiat Ulema Islam - pronti alla guerra santa». Si contano nelle moschee, tra gli studenti delle scuole coraniche, tra gli estremisti di strada, fra i clan che popolano l' area tribale a ridosso dei confini con l' Afghanistan. Dopo la riunione di ieri, nella quale si è decisa la strategia da adottare contro un eventuale attacco americano, gli aspiranti combattenti della Jihad proclamano per oggi due ore di sciopero a Peshawar. Domani sarà sciopero tutta la giornata. Sarà protes ta di piazza. Mobilitazione generale nella North West Frontier Province, la regione ad amministrazione speciale nel Pakistan occidentale. L' appoggio ai talebani parte da qui, dalla stessa area che negli anni Ottanta fece da retrovia alla resistenza afghana contro i sovietici. Creata dai britannici all' inizio del secolo come zona cuscinetto con l' impero russo, la «frontiera del nord ovest» copre quasi un terzo del Paese, include 1300 chilometri di confine con l' Afghanistan, una larga enclave governata secondo il codice tribale, ed è abitata dalla stessa etnia dei talebani, quella «pashtun» di fede sunnita. Nelle sue 650 madrasse (scuole coraniche) studiano oltre 100 mila studenti. Il Jamiat Ulema Islami (Alleanza del clero islamico), il più potente partito religioso del Pakistan, conta su di loro. Ma non solo. «Anche i capi tribali ci hanno dato il loro appoggio, anche la gente comune. Saremo tantissimi», dice Abdul Jalil Jan, vicepresidente del partito nella regione, un uomo sulla cinquantina, con una lunga barba tinta di nero. Qual è la vostra strategia? «Abbiamo deciso di resistere con tutti i mezzi a un possibile attacco americano. Non ci sono prove contro Osama Bin Laden, non c' è nessuna ragione perché gli Usa minaccino l ' Afghanistan». Sarà una resistenza armata? «Certamente. Stiamo studiando risposte differenziate per rispondere sia a eventuali bombardamenti aerei sia a una possibile invasione di truppe. E' un piano segreto. Non posso dire di più». Avrete bisogno d i gente addestrata. Dove la troverete? «Siamo musulmani e siamo sempre pronti per la Jihad (guerra santa, ndr). Non sono i problemi tecnici o logistici a preoccuparci. La gente addestrata non manca. Nelle aree tribali, tutti possiedono armi. Normalme nte non le usano, ma adesso potrebbe essere il momento di tirarle fuori». Che ruolo avranno le madrasse? «Un ruolo chiave. E' lì che sarà reclutata la maggior parte dei combattenti». Che età avranno? «L' età non conta. Alla Jihad parteciperanno tutti , comprese le donne». Le manderete in prima linea? «No, daranno supporto logistico. Prepareranno da mangiare, si occuperanno dei rifornimenti. E soprattutto saranno loro a incoraggiare padri, fratelli, mariti, figli a combattere». Siete stati voi rel igiosi a chiedere l' aiuto dei capi tribali? «No, sono stati loro a contattarci. Nella città di Wana, vicino al confine, ci hanno messo a disposizione 10 mila persone». Il governo pachistano non ha altra scelta che appoggiare gli Usa. Non credete che la vostra insurrezione possa scatenare una guerra civile nel Paese? «Sì, se qualcuno proverà a fermarci. Ma non lo faranno». Contate sull' appoggio di settori dell' esercito o dei servizi segreti? «No comment, è un affare delicato. Spero che l' eser cito non faccia nulla contro l' interesse del Pakistan e della sua gente». Quali sono le ragioni della Jihad? «La guerra santa è il nostro dovere. E' uno dei fondamenti dell' Islam. Il Corano ci obbliga a rispondere a ogni aggressione contro i musulm ani. Combattiamo per ristabilire la giustizia». La guerra santa di Maometto e il codice d' onore dei pashtun GUERRA SANTA Benché sia comunemente tradotta come «guerra santa», la parola araba «jihad» significa più propriamente «lot ta santa» (gli studenti islamici, con una punta di sarcasmo, fanno notare che il concetto di guerra santa fu coniato in Europa ai tempi delle crociate contro i musulmani) JIHAD Il significato religioso del termine «jihad», mutuato dal Corano, è dupli ce: da un lato fa riferimento al concetto di lotta per il bene comune, dall' altro allude alla battaglia interiore contro le tentazioni e i peccati. Le due accezioni sono sintetizzate da un detto del profeta Maometto che, tornando da una campagna militare, disse ai suoi seguaci: «Oggi siamo tornati dalla jihad minore per intraprendere quella maggiore», cioè appunto dalla battaglia sul campo a quella martedi, 18 settembre 2001 Quel misterioso leader delle milizie coraniche che non appare maiSecondo la leggenda, ha perso un occhio combattendo contro l' Urss. Ha 42 anni e tre mogliIL MULLAH OMAR Quel misterioso leader delle milizie coraniche di cui non esistono foto DA UNO DEI NOSTRI INVIATI PESHAWAR (Pakistan) - È l' uomo che non appare mai, l' icona misteriosa di un regime isolato dal mondo. Inavvicinabile, ma soprattutto no n fotografabile. Pena di morte per chiunque si azzardi a farlo. Il mullah Omar, il leader dei talebani, il grande protettore di Osama Bin Laden, ha 42 anni, tre mogli e un soprannome, Amir ul-mumineen che significa «comandante della fede». Il segreto del suo volto, sfregiato da un occhio cieco, è più di un simbolo. È il cuore nascosto del potere teocratico che impera sull' Afghanistan. La sua biografia corre tra leggenda e realtà. Nato da una famiglia poverissima a Nodeh, un villaggio vicino Kan dahar, nell' Afghanistan centromeridionale, Omar perde il padre da bambino. In cerca di lavoro si sposta a Singesar, un altro paesino di case di fango della regione, dove comincia gli studi in una scuola coranica, diventa mullah e apre una sua piccol a madrassa. Nel 1979, all' arrivo dei russi in Afghanistan, anche lui sente il richiamo della Jihad. È in prima linea che perde l' occhio destro? I talebani accreditano l' eroismo. Occhiali neri e barba folta rendono i lineamenti del viso ancora più sfuggenti. Alto, magro, silenzioso. Finita la guerra santa Omar si ritrova nella regione di Kandahar. Parla solo pashtun (una delle lingue afghane). Ma tra i vicini gode della fama di saggio. Il suo potere comincia il giorno in cui alcuni compaesani gli chiedono aiuto contro le bande dei mujaheddin che imperversano nel Paese. Due ragazze sono state rapite dai miliziani e stuprate. «Non si può andare avanti», protestano padri e fratelli. «Questo non è l' Islam che vogliamo», rincarano la dose i v icini. Omar, con una trentina di seguaci e una dozzina di fucili, attacca la base dove sono state rapite le ragazze riportando indietro il corpo del comandante impiccato al cannone del carro armato. «Abbiamo combattuto contro musulmani che hanno sbag liato», avrebbe detto in quell' occasione. Il gruppo dei «puri» si trasforma in movimento e trova subito adepti nelle madrasse sul confine tra Pakistan e Afghanistan. Trova sponsor a Islamabad, interessata a liberare le vie commerciali dell' Afghanis tan dai taglieggiamenti delle fazioni. Trova appoggio tra gli americani, interessati a pacificare il Paese per costruire un oleodotto. Nello stesso periodo Omar decide di accogliere anche Osama Bin Landen, ex combattente della Jihad. Un' amicizia des tinata a consolidarsi, con un matrimonio tra il mullah e la figlia più giovane di Osama. Leggenda? Forse il modo più semplice per spiegare un' alleanza fatta di altro. Osama ha un passato da imprenditore alle spalle. Tornato nel Paese devastato dalla guerra, offre il suo aiuto a ricostruire strade, scuole, ospedali. Nel 1996 i talebani entrano a Kabul. Il mullah Omar ha già stabilito il suo quartier generale in un compound fortificato di Kandahar, che diventa la capitale spirituale e morale dell e milizie integraliste. Vive tutt' oggi nel timore di essere assassinato. E' dotato di senso di humour, dicono, ma sostanzialmente silenzioso. Disdegna ogni contatto con gli occidentali. L' unico, o forse uno dei pochissimi stranieri che l' hanno inc ontrato, è Lakhdar Brahimi, inviato delle Nazioni Unite per l' Afghanistan. Nel ' 98 il mullah si decide a parlargli sotto la minaccia di un attacco iraniano. Dopo, nuovamente silenzio. Si conoscono le sue promesse mancate, come quella di tutelare i due Buddha di Bamyan, i suoi editti, le sue interdizioni. Poco altro. Il leader che sta tenendo in ostaggio il mondo è ancora un uomo senza volto. martedi, 18 settembre 2001 Un grido sale dalle scuole coraniche: «Pronti alla guerra santa» DAL NOSTRO INVIATO RAHAT ABAD (Pakistan) - Anche Osama vuole partire per la guerra. Ha 11 anni e porta un nome glorioso per i suoi compagni. Osama, come Osama Bin Laden. «Giovane? Non sono affatto giovane per combattere», sussurra stringendo le spall e. È nato in Pakistan, nella regione di Peshawar, ai confini con l' Afghanistan, e tutto quello che gli insegnano a scuola è una vita consona ai principi della sharia, la legge coranica. Ascolta gli adulti parlare di mobilitazione e di guerra santa, ed è come se sprofondasse in un coro unanime, piccolo e magro dentro una tunica bianca, tra una fila di volti incorniciati da barbe, dichiarazioni che si assomigliano tutte. «Pronti alla Jihad». «Sicuri della vittoria». Trentamila, quarantamil a, cinquantamila pachistani in armi, dicono gli studenti, per dare aiuto ai talebani nella battaglia contro l' America. E' quasi sera a Rahat Abat, sobborgo di Peshawar. Alla Marka Uloom Islamia, una delle madrasse (scuole coraniche) da cui parte in questi giorni l' appello di massa alla Jihad, le lezioni sono finite da poco. Da un cortile, si entra nel salotto del maulana Siad ul Arifeen, direttore della scuola. Una stanza spoglia con divanetti disposti a quadrato e qualche tappeto. Il «grande saggio» è un uomo di media statura, laureato in geologia, che ha passato da poco la quarantina, che ha viaggiato nel mondo islamico, ha visitato la Gran Bretagna «per capire come si sta sviluppando la società occidentale», ed è in perenne attesa di u n visto per conoscere gli Stati Uniti. «Sosterremo gli afghani con tutti i mezzi che abbiamo», esordisce. «E non saranno solo gli studenti a prendere il fucile, anche la popolazione è con noi». Una situazione diversa, spiega, da quella passata. E' ve ro che sono state le madrasse pachistane, le vecchie scuole ispirate a una delle correnti più radicali dell' Islam, quella deobandista, a far da culla ai talebani già nel 1994, quando il movimento si preparava a invadere l' Afghanistan. E' vero che o gni volta ci sia stato bisogno di nuovi soldati, migliaia di studenti hanno passato la frontiera per unirsi agli integralisti che governano ormai sul 90% del Paese. Ma stavolta non si tratta di una mobilitazione nell' ombra. E' una chiamata alle armi che viene gridata nelle piazze, risuona sui giornali. E' una guerra santa, ma è anche una sfida aperta al presidente pachistano Pervez Musharraf, disposto ad appoggiare l' operazione statunitense contro l' Afghanistan. Tutti al passo dei mullah. Tut ti inchiodati agli appelli di Fazlur Rehman, il leader del Jamiat Ulema Islami, il più potente partito religioso del Paese, venuto alla ribalta nel 1993 sotto il governo di Benazir Bhutto. Finanziatore di centinaia di scuole coraniche, disseminate ne i campi profughi e nelle aree rurali, Rehman è anche uno dei principali alleati dei talebani, l' uomo che ha tessuto la rete d' appoggio agli integralisti con la collaborazione di larghi settori dell' esercito e dei servizi segreti. Tutti pronti - do vrebbe succedere in una riunione convocata oggi - a pianificare la strategia da adottare nel caso l' attacco scatti davvero. «Che cosa faremo? - dice il maulana -. Difenderemo i diritti umani, ci schiereremo con i nostri fratelli musulmani. Osama Bin Laden non c' entra nulla con gli attentati terroristici negli Usa. Non c' è nessun motivo perché l' America debba prenderlo in consegna». Il punto di non ritorno, secondo lui, è stata la conferenza di Durban, dove gli Usa avrebbero «mostrato il loro volto, schierandosi con Israele contro il resto del mondo». La necessità di una grande alleanza islamica, sarebbe nata lì, nella città sudafricana. Raccoglie 250 studenti la sua madrassa, dai 5 anni in su, fino all' università. Ma la forza della scu ola sono gli adolescenti, già pronti per la Jihad. «Anche i bambini, vedete, vogliono andare». Osama fa sì con la testa. «Abbiamo le armi? Certamente, sono sempre arrivate da queste parti, ricordatevi la guerra contro i russi, o altrimenti fermeremo i tank con le pietre». I legami con i «fratelli» oltre frontiera sono inscindibili. L' etnia prima di tutto, pashtun i talebani e pashtun la popolazione che vive attorno a Peshawar, e ancora più a sud, coprendo quasi un terzo del Paese. E non basta. I talebani, figli dispersi della Jihad contro i russi, combattenti fuoriusciti dalle fazioni che nei primi anni Novanta, alla caduta del regime filosovietico di Najibullah, si sparavano addosso l' una con l' altra contendendosi il potere a Kabul, sono partiti da queste regioni. Dai campi profughi lasciati in eredità dalla guerra. E da scuole come queste. Naqeeb Ullah, per esempio, è afghano. Il padre e il fratello combattevano contro i sovietici, adesso sono con i talebani. Vive in Pakist an e spera di diventare insegnante. «Se non arriva la guerra Altrimenti vado anch' io. Addestramento militare? Non ne abbiamo bisogno. Per combattere serve solo la fede». E poi, in Afghanistan ci sono i mercenari arabi. «Da loro abbiamo tantissimo da imparare», dice un altro studente. «Hanno forza e coraggio in prima linea, nessuno li può fermare». Come Osama: un vecchio guerriero. «Ha passato 20 anni a combattere contro i russi. Ce la farà anche stavolta». Di consegnarlo agli Usa neanche a parl arne. «E' un nostro ospite e per noi l' ospitalità è sacra». Alla Marka Ulooma Islamia si studia economia secondo i dettami del Corano. In altre parole, come gestire gli affari senza tradire la fede. Letteratura, storia, scienze, sempre in linea con ciò che recita il sacro testo. Alle spalle del salotto, c' è persino una sezione informatica di cui il direttore della scuola va particolarmente fiero. «Abbiamo computer, connessioni Internet e corrispondenze e-mail». Gli alunni aspirano a profession i normali. Chi vuole diventare maestro, chi ingegnere, chi economista. «L' Islam è la religione della pace - conclude Abdul Ahad, 23 anni. - Il terrorismo non piace neanche a noi, ma se Bush lo usa come scusa per attaccarci, saremo costretti a rispon dere». Gli studenti si guardano in silenzio. E' l' ora della preghiera. Anche il giovane Osama, 11 anni e la Jihad nel cuore, si prepara a inchinarsi verso la Mecca sabato , 15 settembre 2001 I palestinesi: «Ma New York non ha mai pianto per noi» NELLE STRADE DI GERUSALEMME I palestinesi: «Ma New York non ha mai pianto per noi» DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - «Noi e loro». Nei quartieri arabi di Gerusalemme, la linea verde che divide la città rischia di diventare un fossato tra due civiltà. Ma l' avversario ha cambiato aspetto, è diventato un Giano bifronte. Bush e Sharon. Usa e Israele. «Un unico nemico per il popolo palestinese». Imad vende penne e quaderni in una delle cartolerie più fornite del quartiere. Ha 38 anni, baffi curati e un sorriso amaro. «Se la pigliano sempre con gli arabi. Siamo sempre i primi ad essere sospettati per le nefandezze del mondo. Sia chiaro, nessuno gioisce pensando a tutti quei morti di New York, nessuno però se la sente di giustificare il governo am ericano». Ci sarà una guerra santa? Imad bada ai fatti suoi. «Abbiamo già i nostri problemi ai quali pensare». La città di Jenin sotto assedio. La paura che il premier israeliano Ariel Sharon - dopo quello che è successo negli Stati Uniti - sia ormai il solo a dettare leggi, come e quando vuole. Pericoloso in una posizione così fragile come quella dei palestinesi schierarsi apertamente in questa vigilia di guerra globale. La gente che si incontra per strada lo lascia fare ai leader più radicali. Abdel Aziz Rantisi, per esempio, il portavoce di Hamas, che proprio ieri dai territori di Gaza ha invitato alla mobilitazione pro talebani. «Se gli americani attaccheranno sono pronto a unirmi alla causa musulmana». Gli altri si allineano sulle posi zioni di Yasser Arafat: solidarietà con le vittime degli attacchi, condoglianze a Washington, condanna del terrorismo. L' astio contro gli americani, quello però è impossibile da nascondere. «Sono loro a vendere le armi a Israele - dice Sharif, 18 an ni -. Loro ad autorizzare gli ebrei a spararci addosso». Lo scontro di civiltà non era affatto scontato. Molti palestinesi che abitano a Gerusalemme Est hanno vissuto negli Stati Uniti. Hanno fatto soldi in America. Qualcuno ha lasciato i suoi figli a studiare oltre l' Atlantico. Ma dopo le immagini degli aerei kamikaze che si abbattono sulle Torri gemelle e sul Pentagono, niente sarà più come prima. Saeb gestisce un laboratorio fotografico, ha passato dieci anni negli Usa. «La tragedia che oggi vive l' America, è la stessa che viviamo noi ogni giorno, che hanno vissuto anche gli iracheni. Gli Stati Uniti devono riflettere. Che cosa ha prodotto la politica del doppio standard? Facile parlare di libertà e poi negarla agli altri», continua Sa eb. L' attacco non è stato fatto a caso: sono stati colpiti i centri del potere giudaico-americano. Adesso vogliono usare i Talebani come capro espiatorio di tutti i loro errori». L' equazione «Usa-Israele» è immediata. Meno quella tra i kamikaze del cielo e i martiri dell' Intifada. «I palestinesi che si fanno saltare in aria sono combattenti della libertà - interviene un cliente -. Nessuno è felice di suicidarsi, ma qui la pressione è troppo forte. Ci hanno privato della nostra terra e della n ostra dignità. Che cosa ci resta da fare?». Anche Noah, 31 anni, mamma di due bambini, fa sì con la testa. «Abbiamo compassione per i morti, ma non per il governo americano. Abbiamo mai visto qualcuno di loro piangere quando i nostri ragazzini vengon o uccisi dai soldati israeliani?». Ahmed Jarradat, uno studente di 17 anni, capelli imbrillantinati davanti alla sala biliardo, giustifica i palestinesi che martedì hanno danzato e festeggiato l' attacco sugli Usa. «Gioivano non per le vittime, ma pe r l' umiliazione subita dall' America. Nessuno poteva credere che la superpotenza diventasse un bersaglio così facile». E' come se il mondo si fosse capovolto l' 11 settembre 2001. E' stato come assistere alla più tragica farsa della storia. «L' Amer ica mostrata alla tv, è l' America per la prima volta nella parte della vittima - dice Ryad, 33 anni -. Chi poteva crederlo?». L' America ostaggio di un uomo, Osama Bin Laden. «Osama, chi è Osama?», chiedono tre ragazzini usciti da scuola, sgranando gli occhi e masticando chewing gum. L' America pronta alla guerra? Ryad si dondola sulla sedia. «L' America sembra un leone ferito che tenta di colpire alla cieca. Ma ormai ha perso la sua potenza. Solo Dio è grande. Solo Dio è il più forte». sabato , 15 settembre 2001 I talebani: «Islam unito contro l' America» La guida spirituale dell' Afghanistan: «Nessuna concessione su Bin Laden, sarebbe un tradimento»I talebani: «Islam unito contro l' America» La guida spirituale dell' Afghanistan: «Nessuna concessione su Bin Laden, sarebbe un tradimento» DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Vendetta. La parola che chiude ogni possibilità di mediazione è stata pronun ciata. Il mullah Omar, la guida suprema dei talebani, mette in guardia gli Stati Uniti dalla reazione del regime afghano di fronte a un attacco militare. «Ci vendicheremo con vari mezzi», lascia dire al suo portavoce, mentre lui sceglie una moschea d i Kabul per far appello alla fratellanza islamica: «Musulmani di tutto il mondo, uniamoci contro gli Usa». Il fossato è scavato. Le milizie integraliste si preparano a cavalcare lo scontro con l' Occidente. Non ci saranno arresti, nessuna estr adizione. Ancora una volta il mullah Omar, un ex combattente della Jihad contro i russi, cieco di un occhio perso in battaglia, rifiuta ogni concessione sul suo ospite-protettore Osama Bin Laden. «Tradirlo sarebbe un tradimento dell' Islam», ha detto nel suo discorso rilanciato da Radio Kabul. E ancora «Non ho paura di dare la vita o il potere, non cederemo. Chiedo a tutti coraggio e onore». Se si guarda ai precedenti, è difficile pensare che sia un gioco delle parti. Sono mesi ormai che il regi me di Kabul tende a mostrarsi monolitico. E' cominciato a dicembre, dopo le ennesime pressioni americane per la consegna di Osama. Erano circolate voci: sembrava che il mullah fosse tentato di arrestarlo. Voci, appunto. Il regime ha ribadito il suo n o, tirandosi addosso le sanzioni dell' Onu. La distruzione dei Buddha di Bamyan è stata la prima dimostrazione plateale di una linea durissima, perseguita senza dar ascolto a nessuna pressione straniera. Anche adesso i talebani, piuttosto che cedere, preferiscono correre il rischio di crollare sotto un' offensiva militare. Ma non è solo Osama la ragione di questo gioco d' azzardo. Sono i suoi uomini, migliaia di mercenari dell' internazionale islamica, addestrati nei campi del miliardario saudit a. La loro presenza è fondamentale per il regime, che li utilizza contro le forze d' opposizione dell' Alleanza del Nord. La loro influenza è decisiva sulle scelte politiche dei mullah. Dall' altra parte della frontiera c' è un Paese, il Pakistan, al trettanto condizionato dalla sua politica interna. Il presidente Pervez Musharraf ha dichiarato l' altro ieri piena disponibilità ad aiutare gli americani in un campagna militare contro l' Afghanistan. Ma adesso si mostra più cauto. Il Pakistan, oltr e a essere uno dei tre Paesi ad avere riconosciuto il regime dei talebani (con Arabia Saudita ed Emirati arabi), è anche quello che ha tenuto a battesimo il movimento nel 1994, a quel tempo con l' aiuto degli Usa per interessi legati alla costruzione di un oleodotto. Ancora oggi è dominato da gruppi etnici, ideologici e religiosi legati agli integralisti afghani e allo stesso Bin Laden. Uno di questi è il «maulana» Sami ul-Aq, leader del Jamiat Ulena al Islami e presidente di Haqqania, l' univer sità in cui si sono formati gran parte dei quadri integralisti. «Se gli Stati Uniti attaccheranno - ha detto ieri - faremo appello alla Jihad contro Washington». Altro problema: influenti settori dell' Isi, i servizi segreti pachistani, continuano a essere vicini ai talebani. La Cia è ovviamente in azione. Ma il terreno, oggi come ai tempi della guerra contro i russi, è infido. A proposito di russi: anche Mosca, teoricamente allineata con Washington nella lotta al terrorismo, è più cauta del gio rno prima. «Non c' è stata nessuna consultazione diretta russo-americana sulla nostra partecipazione a una rappresaglia», ha detto ieri il capo di Stato maggiore Anatoly Kavashin. «Le forze armate statunitensi sono abbastanza forti per occuparsene 14 settembre 2001 Bin Laden, il ricercato nel mirino cambia rifugio A Kabul si preparano già le trincee in attesa della «punizione». Il Pakistan chiede la consegna del ricercatoAfghanistan, Bin Laden cambia rifugio A Kabul si scavano trincee in attesa della «punizione». Il Pakistan chiede la consegna del ricercato DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - L' Afghanistan si prepara alla guerra con l' Occidente. I mercenari islamici, migliaia di combattenti ospitati dal regime dei talebani, addestrati nei campi di Osama Bin Laden, escono dalle loro ville nascoste nei quartieri residenziali di Kabul, per scavare le prime trincee attorno alla capitale. Molti arabi fuggono, temono l a resa dei conti. Gli stranieri se ne vanno per motivi diversi. Misure di massima sicurezza. Comincia l' evacuazione degli staff dell' Onu, della Croce rossa, delle organizzazioni non governative. Paura e attesa. «Ci aspettiamo il peggio», dice uno d egli abitanti per telefono. «Forse la catastrofe». La Nato smentisce ogni piano d' attacco, ma tutte le piste dell' inchiesta sugli attentati terroristici contro gli Stati Uniti portano nella stessa direzione: i rifugi segreti di Osama Bin Laden, l' ospite d' onore dei talebani, l' amico e il finanziatore più scomodo che le milizie integraliste potessero trovare. Lo stesso uomo che ha portato l' Onu a decretare le sanzioni contro il regime, spingendo già una volta gli Stati Uniti, dopo gli atten tati del 1998 alle ambasciate di Nairobi e Dar es Salaam, a bombardare l' Afghanistan. La guerra si è sfiorata anche nel dicembre scorso, quando Usa e Russia, accomunati da ragioni diverse, avevano pensato di unire le loro forze contro i talebani. Wa shington per fermare i piani di Osama. Mosca per stroncare i legami tra i guerriglieri ceceni e il miliardario saudita. Ieri sono partite le pressioni sul regime integralista, affinché arresti e consegni all' Occidente lo sceicco del terrore. Non si tratta di una richiesta nuova, ma i termini stavolta sono perentori. Il leader supremo degli integralisti, il mullah Omar prende le difese del suo ospite: «Osama non ha niente a che vedere con gli attacchi terroristici negli Stati Uniti. Non è il cer vello di un' operazione complicata e sofisticata come quella». Non ci sarebbero piloti, aggiunge, capaci di azioni kamikaze così devastanti e precise. Prima di procedere a un arresto, occorrono prove, dice il mullah. Fonti arabe a Kabul riferiscono a l Corriere di una lettera inviata dall' ambasciata pakistana in Afghanistan al ministro degli Esteri dei talebani, Wakil Ahmed Muttawakil, con un ultimatum: «Consegnate subito Osama e senza condizioni». Anche l' alleato più fedele, il Pakistan, uno d egli Stati che hanno tenuto a battesimo il movimento integralista, ha preso le distanze. «Siamo pronti a offrire tutta la nostra collaborazione agli Stati Uniti», ha dichiarato ieri il presidente Pervez Musharraf, sperando di riguadagnare i favori di Washington, persi dopo l' avvicinamento americano all' India. Nessun piano d' attacco, forse. Ma il vice segretario di Stato americano, Richard Armitage, si prepara a incontrare gli esponenti dell' Isi, i servizi segreti pakistani. Amici ai tempi de ll' invasione sovietica, quando Usa e Pakistan finanziavano i mujaheddin nella guerra contro i russi. Washington starebbe così creando una base d' appoggio nell' area. Osama, il figlio ribelle della politica statunitense nella regione, non sta ad asp ettare. Subito dopo gli attentati negli Stati Uniti, avrebbe lasciato il suo rifugio. Niente di straordinario. Dai bombardamenti americani del 1998 in poi, si dice che non abbia mai dormito più di due notti di seguito nello stesso posto. Lo si dava a Kandahar, capitale spirituale del regime, alle frontiere del Pakistan, a quelle con l' Iran. Sempre circondato dai suoi apparati di sicurezza, dotato di computer e satelliti, nascosto in grotte accessoriate come bunker tra le montagne più inaccessib ili del Paese. Sempre in grado di controllare, secondo un rapporto pubblicato da un organismo del Congresso americano, le cellule della sua organizzazione Al Qaida in 34 Paesi diversi, Italia compresa. Ha i giorni contati? A Kabul se lo chiedono in m olti. E' certo che i talebani devono scegliere: o lui e la sopravvivenza del regime. Le milizie integraliste potrebbero trovarsi di fronte una coalizione che non vedrebbe solo gli Stati Uniti schierati, ma anche la Russia, l' India e persino l' Iran. A Kabul circola anche un' altra ipotesi. Usa e Russia potrebbero mandare avanti con una copertura aerea, l' Alleanza del Nord, le forze d' opposizione ai talebani che controllano il 10-15% del Paese. E' un esercito ormai scompaginato, retto per anni da una figura debole ma carismatica come il comandante Massud. La settimana scorsa due finti fotografi si sono fatti esplodere davanti a Massud tentando di ucciderlo. Non si sa ancora se il «leone del Panshir» sia vivo o morto, ma l' 11 settembre, l o stesso giorno degli attacchi sull' America, l' Alleanza lo ha sostituito con un leader ad interim, il generale Muhammad Fahim. Poche ore dopo l' opposizione ha lanciato dei missili su Kabul. La natura dell' attacco è rimasta misteriosa, ma forse si trattava di una prova. domenica , 07 ottobre 2001 Viaggio nell' università della guerra santa «Ma il mullah Omar non ha il diploma» Viaggio nell' università della guerra santa «Ma il mullah Omar non ha il diploma» DAL NOSTRO INVIATO AKHORA KHATAK (Pakistan) - Difficile sostenere che il mullah O mar sia stato uno studente modello. Il maulana ci prova, accarezzandosi un a barba tinta di hennè: «Un vero gentleman, un uomo squisito e cortese». Ma un fatto è un fatto, e alla fine anche Sami ul Haq, 63 anni, rettore dell' Haqqania, la più grande scuola coranica del Pakistan (mezz' ora d' auto da Peshawar), è costretto a d ammettere che il capo supremo dei talebani, il leader che tiene le chiavi della centrale del terrorismo mondiale, non ha neanche un vero diploma da appendere al muro. «Ha dovuto interrompere gli studi per fare la guerra». Poco male. I meriti sul ca mpo valgono di più dei voti in pagella. Ed è così che l' emiro semi-analfabeta, senza essere mai uscito dall' Afghanistan, si trova annoverato tra gli allievi più celebri della madrassa. «Gli abbiamo dato una laurea ad honorem per l' impegno dimostra to. Se la meritava». Il maulana e il mullah si sono conosciuti nel 1996 a Kandahar. Il primo era leader del Jamiat Ulema I slam, uno dei partiti fondamentalisti più influenti del Pakistan, da cui si è poi staccato per creare u na propria fazione. Il secondo aveva appena ricevuto dal Consiglio supremo del clero il titolo di «comandante della fede». Sodalizio perfetto. Nel 1997, dopo la sconfitta dei talebani a Mazar-i-Sharif, Sami ul Haq ha chiuso l' istituto per un mese, inviando migliaia di stu denti a combattere al fianco del mullah. La scuola (che raggruppa 12 madrasse nelle quali gli allievi vengono seguiti dalle elementari fino ai master post-universitari) aveva sfornato schiere di mujaheddin durante l' invasione russa. Ma è ai talebani che Haqqania, tempio della sharia ornato di archetti e fregi orientali, ha offerto l' impalcatura ideologica per tradurre in prassi politica la legge coranica. Ministri, governatori, comandanti hanno assimilato i princìpi della corrente Deobandi, pe r sviluppare una versione ultraradicale dell' Islam, senza precedenti nel mondo musulmano. «Il 90% dei loro quadri dirigenti s' è formato nelle nostre classi - aggiunge Sami ul Haq, in una posa da cardinale -. Gente impegnata nella difesa dei propri princìpi». Gente a cui adesso è affidata la difesa di un regime sotto assedio. Jalaludin Haqqani, per esempio. Durante la guerriglia anti-sovietica, era stato uno dei leader militari più celebrati. Passato dalla parte dei talebani nel 1995, aveva gui dato l' armata dei puri sul fronte di Kabul. Poi qualcosa è andato storto e il comandante si è rifugiato a Dubai con la moglie. E' tornato a Paktia, la sua provincia d' origine, poche settimane fa, con un nuovo incarico: capo delle operazioni militar i contro il nemico americano. Ad Haqqania si laureato anche Younis Khalis, altro esponente di spicco della jihad, un mullah vicino ai talebani. Rientrato da Peshawar nel suo feudo di Jalalabad, ai confini con il Pakistan, pare stia esercitando tutta la sua influenza religiosa per evitare defezioni tra i soldati di Allah. Il cordone ombelicale con i vecchi allievi non si rompe. Il direttore di Haqqania è tra i leader del Consiglio di difesa per l' Afghanistan, la coalizione di gruppi fondamentali sti scesi in piazza anche ieri a Peshawar per ricordare al mondo che l' unica vera «superpotenza è Allah». La settimana scorsa avrebbe dovuto far parte della delegazioni pakistana inviata a trattare con i talebani. E' rimasto a casa. Dal punto di vis ta di uno come lui, amico personale di Osama Bin Laden, c' era poco da trattare. «Gli Usa vogliono installare un governo fantoccio in Afghanistan. Ma sanno che devono fare i conti con l' Iran, la Russia, la Cina, il Pakistan?». La violenza dilaghereb be, pronostica il maulana. «I combattenti della jihad sono pronti a colpire a Est come a Ovest». Haqqania sarà un centro di reclutamento? Il maulana cambia tono. Troppe pressioni dal governo pakistano e troppe voci sulla sua madrassa. «Non abbiamo ma i avuto campi di addestramento qui dentro. Abbiamo solo formato allievi che hanno portato pace e sicurezza in Afghanistan. Se cadranno loro, il Paese ripiomberà nella guerra civile». sabato , 19 maggio 2001 I Talebani chiudono l' ospedale degli italiani Irruzione degli estremisti islamici nella clinica di Gino Strada. «Uomini e donne mangiano insieme, infranta la legge coranica» I Talebani chiudono l' ospedale degli italiani Non avrà vita facile, veniva da pensare, in una città come Kabul. Bastava s entirlo parlare un paio di mesi fa, prima che l' ospedale venisse inaugurato, la sigaretta tra le labbra, il profilo aquilino, il passo nervoso: «A trattare con i Talebani c' è da diventare matti - borbottava con voce roca -. Non avete idea di che co sa sia stato mettere su questa struttura». Gino Strada, il fondatore di Emergency, camminava irrequieto tra i padiglioni freschi di vernice, costruzioni basse dipinte di bianco, sale operatorie, aiuole in fiore. Il 25 aprile l' ospedale, con i suoi 1 20 posti letto, i reparti di chirurgia ricostruttiva, oculistica, pediatria, è stato aperto al pubblico. Ma l' avventura del chirurgo milanese, abituato a operare in prima linea, era destinata a una frenata. Ieri le milizie integraliste hanno deciso di chiudere «l' ospedale degli italiani» a tempo indeterminato. Lì dentro saltano le regole imposte del regime, ha accusato la polizia religiosa: «Uomini e donne mangiano insieme, nella stessa mensa». Saltano i diktat della sharìa, che impone l' asso luta separazione dei sessi. Vacilla l' intransigenza che domina ogni aspetto della vita quotidiana dell' Emirato islamico dell' Afghanistan. I «puri di Allah», spediti dal Ministero per la prevenzione del vizio e la salvaguardia delle virtù, sono arr ivati in 25, scavalcando il muro di cinta, kalashnikov e fruste nelle mani. Non si sono limitati a entrare in sala da pranzo. Hanno anche distribuito punizioni: impiegati in ginocchio, picchiati con rami strappati dagli alberi, tre dipendenti locali arrestati per «aver opposto resistenza». Per «questioni di sicurezza» Gino Strada ha deciso di dimettere i pazienti in via di guarigione e ha affidato gli altri a strutture esterne, mentre la direzione tentava di chiarire che la mensa è divisa da una tenda: uomini da una parte, donne dall' altra. Tempo perso. Non è gente che si lascia convincere facilmente questa che governa a Kabul. Il mondo se ne è accorto a marzo, quando i Talebani, senza sentir ragione, hanno distrutto i Buddha giganti di Ba miyan. E, negli anni passati, quando i dissidi «ideologici» con le agenzie umanitarie si trasformavano in evacuazioni dal Paese e blocco dei soccorsi. Non avrà vita facile Gino Strada, veniva da pensare. L' ospedale, costato 350 mila dollari (700 mil ioni di lire), è un piccolo paradiso se paragonato alle sale fatiscenti del vecchio Karte Se di Kabul, ai reparti sforacchiati dalle granate, ai corridoi tetri delle altre strutture sanitarie dell' Afghanistan. C' è chi dice, come la Croce Rossa inte rnazionale, che si tratta di un' opera superflua. L' emergenza umanitaria, scatenata dalla guerra e dall' ultima carestia, tocca altre regioni del Paese: 4 milioni di persone a rischio, secondo il segretario di Stato americano Colin Powell, che ieri ha annunciato aiuti per 43 milioni di dollari (86 miliardi di lire). Ma per i Talebani non è questo il punto. Gino Strada aveva un peccato da farsi perdonare: un primo ospedale inaugurato nel 1999 ad Anabah, nel Panshir, la valle controllata dal capo dell' opposizione, il comandante Massud. «Abbiamo voluto costruire una seconda struttura a Kabul - sostiene il chirurgo - proprio per dimostrare la nostra imparzialità». Dietro al progetto c' è anche il governo italiano e, indirettamente, il «proces so di Roma»: un piano di pace che propone di resuscitare la loya jirga, l' antica assemblea suprema dell' Afghanistan, per lanciare un governo di coalizione tra i Talebani, l' opposizione e i vecchi «saggi» del Paese. L' ex re Zahir Sha, che dal 1975 vive in esilio a Roma, farebbe da garante. A settembre scorso la visita in Afghanistan del sottosegretario agli Esteri, Ugo Intini, è servita tanto a benedire l' ospedale di Strada quanto a sottolineare l' impegno italiano per ricucire il conflitto. Ma i Talebani temono il sovrano, tutt' oggi rimpianto dalla popolazione afghana, molto più dell' opposizione. E se la struttura costruita da Gino Strada nel Panshir era stata soprannominata l' «ospedale di Massud», questo di Kabul è già diventato l' «ospedale del re». Il regime ha fatto di tutto per mettere le mani sull' ospedale: ha rivendicato la presidenza, le cariche amministrative, la gestione del personale, fino a bloccare i lavori per mesi. Gino Strada non si è lasciato intimorire : «La struttura appartiene a Emergency e, finché sarò qui, rimane sotto il mio controllo». E, per finire, ha violato un mezzo tabù: «Diamo lavoro a 240 persone. E, potete giurarci, la priorità va alle donne». Ma è qui che gli integralisti l' hanno co lto in fallo. I Talebani permettono a infermiere e dottoresse di operare nelle corsie femminili. Non di mischiarsi agli uomini al tavolo da pranzo. lunedi, 07 maggio 2001 Sfida sul Buddha più alto del mondo L' India progetta una statua di 150 metri, la Cina risponde con un' altra di 153 Dopo la distruzione dei colossi di Bamiyan in Afghanistan, i Paesi asiatici entrano in gara per raccoglierne l' eredità Sfida sul Buddha più alto del mondo L' India progetta una statua di 150 metri, la Cina risponde con un' altra di 153 Il culto riso rge dalle polveri di Bamiyan. Sarà il trionfo del gigantismo religioso, grandezze e volumi senza precedenti, meraviglie della modernità destinate a offuscare il ricordo dei Buddha distrutti dai Talebani in Afghanistan. Effetto della campagna iconocla sta condotta in nome dell' Islam, in Asia si diffonde un nuovo interesse verso il buddhismo e le sue icone. Tale da mettere in competizione le due superpotenze del continente, Cina e India, sul terreno della fede. E' Pechino a sfidare l' avversario: il suo Bodhisattva, il Buddha della Compassione, svetterà più in alto del Maitreya Buddha, il Buddha del Futuro, progettato dagli architetti di New Delhi. Tre metri di più, 153 contro 150, per raggiungere un primato mai sfiorato. Nemmeno i colossi di Bamiyan - 55 metri l' uno, 35 l' altro - si avvicinavano a tanto. La statua cinese nascerà sul monte Jiuhua, uno dei quattro santuari buddhisti del Paese. Sarà formata da 1100 pezzi di rame, mille tonnellate per un costo complessivo di 55 milioni di dollari. Anche sui tempi Pechino si propone di battere l' India. I lavori cominceranno a settembre per terminare nel 2004, un anno prima di quelli del rivale. Il Buddha della Compassione, ispirato a Jin Qiaoqui, un antico pricipe coreano che nel 719 dopo Cristo si ritirò sulle alture cinesi, è una divinità militante. Dopo aver ottenuto l' illuminazione, anziché aspettare il Nirvana, si trasformò in pellegrino per aiutare l' umanità. Il progetto indiano, il Buddha del Futuro, pensato con l' aiut o di architetti britannici, sorgerà nello stato del Bihar e sarà invece di bronzo, con uno scheletro di metallo. Costerà 200 milioni di dollari e creerà un indotto di mille posti di lavoro. Più basso di quello cinese, ma non meno ambizioso. Se c' è u n posto dove l' antico spirito di Bamiyan potrebbe rivivere, è proprio qui. Attorno alla statua, rappresentazione dell' amore di tutti i Buddha, come in Afghanistan tra il II e il V secolo dopo Cristo, nasceranno monasteri, pensioni, padiglioni di me ditazione, negozi d' oggetti sacri, scuole e ospedali. Crocevia di fede e turismo. Cosicché persino la comunità indù si è guardata bene dal sollevare obiezioni. Felice del progetto il Dalai Lama. Meno contento, forse, del Buddha cinese: la ferita del Tibet, occupato da Pechino, è sempre aperta. Non basta una statua a risanarla. Né in India né Cina possono definirsi buddhisti. Il culto è minoritario in entrambi i Paesi. Ma è l' eredità simbolica di Bamiyan ad essere in ballo. Altri Stati entrano nella contesa. A cominciare dallo Sri Lanka, che vorrebbe ricostruire due copie perfette dei colossi demoliti dai Talebani. Per finire all' islamico Tajikistan, che più modestamente si preoccupa di salvare quanto possiede: un Buddha dormiente, lungo 14 metri. Il reperto, ritrovato nel 1966, quando il Paese faceva ancora parte dell' Urss, era rimasto a lungo nascosto, come traccia perniciosa del passato, nei sotterranei del museo di Dushanbe, la capitale. Resuscitato dopo la distruzione dei colos si di Bamiyan, si rivela adesso quanto mai prezioso. Non sarà «gigante» come le statue progettate in India e in Cina, ma di certo più autentico. Mille e 500 anni alle spalle. venerdi , 13 aprile 2001 Corano e guerra, la scuola dei Talebani In Pakistan un' università alimenta le file degli integralisti: «Combattere è nostro dovere»Viaggio nella «madrassa» di Haqqania, presso il confine afghano, dove la tv è bandita e lo studio è una missione Corano e guerra, la scuola dei Talebani In Pakistan un' università alimenta le file degli integralisti: «Combattere è nostro dovere» DAL NOSTRO INVIATO AKHORA KHATAK (Pakistan) - L' accesso è proibito alle donne, agli infedeli, agli stranieri. «I nostri studenti non amano le visite», sussurra uno dei mullah percorrendo a passi felpati un vicolo costeggiato da caseggiati e buganville. È concessa solo una sbirciata attraverso l' inferriata, oltre la quale si scorge una facciata bianca con archetti verdi, un prato con le tombe dei padri fondatori e la penombra delle stanze segrete dove i futuri guerrieri d' Allah si esercitano allo studio del Corano. Il resto del complesso architettonico che ospita Haqqania, una delle più grandi «madrasse» (scuole coraniche) del Pakistan, rimane nascosto dentro un labirinto di aule, dormitori, moschee, destinate ad accogliere i giovani accoliti dell' integralismo islamico dall' infanzia alla maturità. La scuola sorge ad Akhora Khatak, una cittadina della «North West Frontier», a un' ora d' auto da Peshawar, appena al di qua del Kyber Pass, su quel confine montagnoso che fa da tormentata re trovia all' Afghanistan. Negli anni Ottanta fu una delle centrali di smistamento dei mujaheddin che dal Pakistan, divisi in sette fazioni, organizzavano la resistenza all' invasore sovietico. Oggi è diventata la Cambridge dei Talebani (letteralmente gli «studenti»), il santuario teoretico delle milizie coraniche che governano a Kabul, l' accademia della sharia. Da qui escono i dirigenti del movimento, i quadri medi, i combattenti: 16 province afghane sulle 26 amministrate dai Talebani hanno gove rnatori diplomati ad Haqqania. «Se credete però di trovare qui dei campi di addestramento militare, sbagliate indirizzo», ride Samiul Haq, 63 anni, rettore e guida spirituale della madrassa, un uomo imponente avvolto in una vestaglia marrone con una lunga barba rossa di henné, un turbante in testa e pantofole ai piedi. È un maulana, il «grande maestro», colui che sa interpretare i testi e i codici dell' Islam, oltre che il leader del partito religioso «Jamiat-e-Ulema Islam». «Per noi istruzione e religione coincidono, così come religione e politica», spiega sposandosi dal patio al suo ufficio, dove si accomoda tra una fila di librerie e una corte di mullah. «Combattere fa parte dei nostri doveri. Abbiamo aiutato i mujaheddin nella guerra sa nta contro i sovietici. Adesso sosteniamo i Talebani. Il mondo dovrebbe essere loro grato perché hanno riportato pace e tranquillità in Afghanistan». Il rapporto di filiazione tra i vertici di Haqqania e le milizie afghane ricalca, come ai tempi dell a jihad contro l' Urss, gli interessi del governo pakistano oltrefrontiera. Un esercito amico a ovest serve a bilanciare il fronte aperto in Kashmir con l' India, l' ostilità dell' Iran, le pressioni della Russia. La storia si ripete. «Nel 1992, alla caduta del regime filo-comunista di Najibullah, i mujaheddin hanno cominciato a combattersi tra di loro - ricorda il maulana -. Bisognava trovare una soluzione». L' Afghanistan era nel caos. Il Pakistan in ambasce. Quella massa di figli ribelli, orm ai fuori controllo, ostruiva le vie commerciali per l' Asia centrale, bloccava il progetto americano di un oleodotto che arrivasse al porto di Karachi, fomentava instabilità nell' intera regione. La creazione di un nuovo esercito, un' armata di «puri » capaci di ristabilire i veri principi dell' Islam e sgominare le altre fazioni, venne appoggiata tanto dai gruppi religiosi quanto da alcuni settori dell' esercito e dei servizi segreti pakistani. Il maulana fu il primo a benedire quegli integralis ti di etnia pashtun, come gran parte della popolazione della North West Frontier, che nel 1994 si preparavano a invadere il Paese. «Lasciate che gli studenti prendano le redini dell' Afghanistan», sentenziò Samiul Aq davanti agli uomini dell' Isi, gl i 007 pakistani. Lo stesso anno il maulana ha conosciuto il mullah Omar, il capo dei Talebani. Non era stato tra i suoi studenti dell' Haqqania, ma l' amicizia si è cementata al punto che nel 1997, quando Omar l' ha chiamato al telefono per chiedergl i aiuto dopo la sconfitta a Mazar-i-Sharif, il rettore ha chiuso la madrassa per spedire i suoi ragazzi a combattere in Afghanistan. Dopodiché ha convocato i leader di una dozzina di scuole coraniche, sparse per la North West Frontier, convincendoli a mandare 8 mila uomini di rinforzo. Più antico il rapporto con Osama Bin Laden, conosciuto ai tempi della jihad contro i russi. «Eccolo qui - dice il maulana mostrando due foto che lo ritraggono assieme al miliardario saudita -. Questo è l' uomo che gli americani avevano considerato un eroe durante la resistenza contro i sovietici. Perché adesso lo dipingono come un demonio con le corna? Non è cambiato. È lo stesso di allora». Nelle foto, scattate all' interno di uno dei suoi rifugi afghani, Os ama sfoggia il solito sorriso enigmatico, ha una radiolina attaccata all' orecchio, mentre Samiul Aq di profilo gli parla con fare da amico. Crocevia di combattenti, Haqqania. O vivaio del terrore? Dal 1991 la scuola ospita anche gli islamici dell' e x Unione sovietica, tagiki, uzbeki, ceceni, le stesse nazionalità che si ritrovano in Afghanistan a fianco dei Talebani. In prima linea contro l' opposizione guidata dal comandante Massud o nei campi di addestramento finanziati da Osama a imparare l' uso del tritolo. Ma c' è anche un aspetto accademico che alimenta la vocazione alla jihad. La scuola, fondata nel 1947 dal padre di Samiul Aq subito dopo l' indipendenza del Pakistan, si rifà ai principi del «deobandismo», una corrente dell' Islam s unnita nata in India nell' 800 come risposta alla disgregazione creata dall' impero britannico. È una delle scuole più radicali della religione musulmana, più intransigente persino del «wahabismo» saudita, con cui spesso si incrocia in Afghanistan. « Loro, i sauditi, accettano l' imperialismo americano - precisa il maulana -. Noi no». Oggi la scuola accoglie circa 3 mila studenti, ai quali offre oltre all' insegnamento primario e secondario, un master in studi islamici, un PhD con corso supplemen tare di due anni a costo zero. Le regole sono ferree: lezioni e preghiere si alternano fino a sera, pasti due volte al giorno a carico dell' istituto, consentiti alcuni sport come la palla a volo, il calcio, il cricket. Bandita la televisione, permes so invece l' ascolto dei notiziari alla radio. Tra gli hobby praticati dagli studenti, la ceramica e la recita dei poemi ispirati ai versi del profeta. Nessuno spazio alla cultura secolare, a parte una piccola sezione informatica, dotata di una decin a di computer. I fondi non mancano, Haqqania conta su una rete capillare di donatori. Come le altre scuole religiose del Pakistan continua a esercitare il suo peso politico sul nuovo capo di Stato, il generale Pervez Musharraf, salito al potere con u n golpe nel 1999. Nonostante le pressioni internazionali stiano spingendo il governo pakistano a una presa di distanza dai Talebani, gli integralisti non hanno intenzione di mollare la presa. Una prova è l' editto che ha messo al bando le statue pre- islamiche e i Buddha di Bamiyan. Se in privato Samiul Aq ha contestato la campagna demolitoria sostenuta in Afghanistan, in pubblico si allinea ai rigori della sharia. «La volontà di Dio è stata compiuta, inshallah». martedi, 27 marzo 2001 Bamiyan, la valle dell' "esecuzione" dei Buddha DAL NOSTRO INVIATO BAMIYAN (Afghanistan) - Una jeep dai vetri neri taglia il piazzale polveroso che si apre davanti all' aeroporto di Kabul. Isakhan, 26 anni, si aggiusta il turbante di seta grigia sulla testa e sfoggia un sorriso vagamente mefistofe lico. «Il portavoce del ministero è arrivato - annuncia -. Adesso partiamo davvero». Il giovane funzionario dei Talebani, direttore del Kabul Time, unico giornale di lingua inglese dell' Afghanistan - interprete quando occorre, negoziatore in questo caso - ha raggiunto uno dei successi più importanti della sua carriera: dopo una settimana di spola tra il ministero degli Esteri, della Cultura e della Difesa, vale a dire tra le anime moderate e oltranziste del regime, è riuscito a organizzare il p rimo viaggio della stampa straniera nei territori proibiti di Bamiyan. L' arrivo di Faiz Ahmed Faiz, il grassoccio portavoce degli Esteri, suggella i suoi sforzi: «Non è vero che a Bamiyan si combatte - dice Isakhan, con gli occhi neri che mandano la mpi di soddisfazione -. La regione è sicura». La valle dove sono stati distrutti i due Buddha giganti non è una vergogna da nascondere. Il grande palcoscenico della «sharìa», la legge coranica, nella sua interpretazione più estrema. Il patibolo dei s imboli di una cultura millenaria e una religione nemica. I Talebani, gli «studenti coranici» che controllano il 90% dell' Afghanistan, hanno deciso di aprirla a pochi giornalisti per mostrare che l' editto emanato il 26 febbraio contro le statue prei slamiche è stato rispettato, che tutti gli «idoli» sono stati abbattuti, che il progetto integralista sostenuto in sei anni di offensiva militare e in quattro di governo non si arresta. Un corteo di interpreti, funzionari e miliziani si mette in moto in un vortice di scialli, zuccotti ricamati, stole lucenti e stracci verso la pista, dove un Antonov dell' Ariana, la compagnia di bandiera afghana, riscalda i motori in attesa di levarsi in volo. Dopo giorni di consultazioni, è stato stabilito che è il mezzo più sicuro per raggiungere Bamiyan. L' aereo è una carcassa che non vede un pezzo di ricambio da anni, ma in pochi minuti raggiunge le alte quote, sorvola il deserto a ovest di Kabul e punta verso le cime innevate dell' Hindu Kush. Un' ora dopo si incunea tra gole di montagna, sfiora una geologia primordiale fatta di rocce rosa, di crepacci ocra, di costruzioni di fango perduti nei fondovalle aridi dell' Hazarajat. Bamiyan appare dall' alto, una distesa gialla delimitata da un costone traforato, e a poca distanza l' una dall' altra, due orbite vuote, le due nicchie che hanno ospitato per secoli i Buddha di pietra. Dalla pista sconquassata, sulla quale atterra l' Antonov, un altipiano a 2.500 metri d' altezza circondato da montagn e, arrivano i toni sommessi di Faiz Ahmed Faiz, il portavoce del ministero degli Esteri: «Benvenuti a Bamiyan, una delle regioni dove i Talebani hanno portato pace e stabilità». Difficile credergli. Attorno ci sono solo volti rugosi di miliziani, arm ati di bazooka e kalashnikov. Sono «pashtun» reclutati dalle scuole coraniche, il nocciolo duro delle milizie integraliste. Più in basso si scorgono vecchi carri armati e un lanciarazzi, puntato verso le montagne per far fronte alle armate di Khalili , il capo di una delle fazioni Hazara che combatte con l' opposizione. Anche i pick-up, pronti sulla pista per trasportare i visitatori ai piedi delle grandi nicchie, sono zeppi di munizioni e fucili. La valle è deserta. «Gli abitanti sono scappati v enti giorni fa - spiega l' autista - durante l' offensiva dell' opposizione». Si è combattuto anche ieri a Bamiyan. Ma la distruzione del villaggio e la fuga degli Hazara, un' etnia di fede sciita, è storia vecchia. Nel 1995, quando la regione era ca duta in mano al comandante Massud, il grande nemico dei Talebani, avevamo visto case di fango vuote come adesso, i resti di antichi alloggi sventrati, i fortini minati e diroccati. L' unica differenza erano i Buddha, ieratici guardiani di questa vall e della morte. I «mujaheddin» si erano arrampicati fin sopra la testa dei due colossi. Cantavano «Allah Akbar» al tramonto, mentre i traccianti illuminavano il cielo in segno di festa per la vittoria. Oggi c' è poco da esultare. Le jeep si fermano ai piedi del grande costone, una gruviera di cappelle, di alloggi, di anfratti scavati nella roccia. I Buddha non esistono più. Al posto del più grande, 55 metri d' altezza, c' è come un bassorilievo impresso nella pietra, un' ombra che le cariche di d inamite non sono riuscite a cancellare, e una montagna di sassi. «Abbiamo visto tutto», dice uno dei Talebani, ma il comandante lo zittisce con il calcio del kalashnikov. «Ci hanno messo venti giorni a distruggerli - aggiunge un funzionario sottovoce -. È stato un lavoro duro e difficile». Duecento metri più in là, si apre la nicchia del secondo Buddha, 35 metri d' altezza. Qui è rimasto qualcosa: sembra un drappo scolpito, un pezzo di gomito attaccato alla roccia. Qualche affresco si è salvato in una nicchia laterale, decorazioni blu su un fondo mattone sfregiate da iscrizioni in arabo, volte a botte e una scala nascosta dentro la roccia che portava fino in cima alla statua. Tornano in mente le descrizioni lette sui libri di storia: le inf luenze greche sulla foggia dei due Buddha, costruito il più piccolo attorno al II secolo d.C., l' altro tra il IV e il V, le lacche rosse e oro degli abiti, una distesa di «stupa» e di statue minori attorno al complesso architettonico che segnava il punto d' incrocio tra l' eredità alessandrina e la cultura buddhista. È terra di passaggio, Bamiyan, sosta per i mercanti che trasportavano ori, argenti, pietre preziose, ma anche grande crocevia di filosofi, artisti, missionari. Le invasioni musulma ne tra il IX e l' XI secolo cancellarono il buddismo dalla valle, ma risparmiarono le due statue, limitandosi a sfregiare la parte superiore del viso. Anche il «mullah» Omar, leader dei Talebani, arrivati nella valle nel 1997, aveva promesso che li a vrebbe protetti. Poi, con un improvviso voltafaccia, ha emanato l' editto che li ha messi fuorilegge. Adesso a Bamiyan si dice che per abbattere il più grande dei due colossi siano state impiegate 14 tonnellate di dinamite. Altre voci parlano di quat tro. Testimoni segreti inviati da archeologi stranieri, sostengono che la distruzione sarebbe cominciata il 15 marzo alle due del pomeriggio, e non subito dopo l' editto come i Talebani vorrebbero far credere, che gli Hazara avrebbero combattuto per fermarla e lo stesso comandante militare della valle per due settimane si sia rifiutato di procedere alla demolizione. La distruzione sarebbe stata opera di artificieri di un Paese islamico amico. La decisione presa dai vertici del governo integralis ta ha spaccato i Talebani, rafforzando l' ala più radicale. Ma è stata veramente una reazione alle sanzioni votate a gennaio dall' Onu? Una sfida all' isolamento di un regime che continua a ospitare Osama Bin Laden, a reclutare e addestrare migliaia di combattenti islamici provenienti dalle fazioni più radicali dell' Algeria, dello Yemen, della Cecenia, fino alla Cina e alle Filippine? Sulla pista dell' aeroporto di Bamiyan, Faiz Ahmad Faiz ripete la sua litania: «La demolizione delle statue è u n affare interno dell' Afghanistan. L' Occidente ha votato sanzioni che colpiscono solo noi e lasciano libera l' opposizione di armarsi e destabilizzare il Paese. Invece di criticarci per aver distrutto le statue, perché non ci viene incontro?» Nella logica dei Talebani il sacrificio delle statue era forse necessario per richiamare l' attenzione del mondo. Adesso il vento si è levato sull' altipiano. Le parole di Faiz sono sempre più deboli. Dalle macerie dei Buddha si alzano nuvole di polvere. Bamiyan è diventata la valle dei fantasmi venerdi , 23 marzo 2001 Nel ventre di Kabul, capitale di macerieVisita al museo della città afghana: «Abbiamo tenuto le opere che non offendono l' Islam, il resto è distrutto» In vendita anche merci semiproibite, come macchine fotografiche, sigarette, cosmetici. Circolano cassette di film: «Titanic» è la pellicola più amata, seguita da James BondCon la demolizione dei Buddha giganti i talebani sembrano aver voluto riaccendere l' attenzione internazionale: «Aspettiamo il riconoscimento» Nel ventre di Kabul, capitale di macerie Visita al museo della città afghana: «Abbiamo tenuto le opere che non offendono l' Islam, il resto è distrutto» DAL NOSTRO INVIATO KABUL - Najibullah Ahmadiyar ha un sorriso beffardo mentre scende le scale veso i sotterranei del museo di Kabul, la testa coperta da un turbante nero, il viso ornato dalla barba, i baf fi illuminati dalle lampade a petrolio. Il direttore mostra i pochi oggetti esposti: una porta di marmo del IX secolo, reperti con l' iscrizione islamica, cocci di terracotta ammassati negli scaffali. «Perché insistete tanto sulle statue? Qui ci sono solo ceramiche». L' editto, promulgato dai talebani contro gli idoli pre-islamici, applicato con la demolizione dei due Buddha giganti di Bamiyan, e la distruzione di ogni icona del Paese, sembra aver ringalluzzito l' orgoglio del regime. «Abbiamo t enuto solo le opere che non offendono la nostra religione - interviene Hammed Naim Safi, alto funzionario del ministero della Cultura e dell' Informazione -. Il resto è stato distrutto. Non c' è un solo Buddha intero in tutto l' Afghanistan». Il giro del museo non offre nessuna prova sulla campagna iconoclasta che ha allarmato la comunità internazionale. Non ci sono detriti, polveri che testimonino la demolizione delle statue «contrarie allo spirito dell' Islam». Ma è l' unica concessione fatta dai talebani, le milizie integraliste che governano Kabul, alla stampa straniera. L' unico mattatoio artistico individuabile, visto che la valle di Bamiyan è interdetta «per motivi di sicurezza». All' interno, per la verità, resta poco da esibire. Il museo, costruito nel 1931, è sopra una spianata di macerie, davanti al relitto del palazzo di Re Ammanullah, sulla Darwan Aman Road, un boulevard surreale costeggiato da mura diroccate, residenze sventrate, tracce di rocce corrose da fatti lontani. Il corpo centrale dell' edificio è stato restaurato, il resto, pericolante senza soffitto, è ancora squarciato dalle bombe lanciate dai mujaheddin durante la guerra civile dei primi anni Novanta. «Dei centomila reperti raccolti in Afghanistan - spieg a il direttore - ne sono rimasti solo 30 mila». Gli altri sono stati distrutti, saccheggiati o rivenduti oltre frontiera. Da allora il museo è stato aperto solo una volta, ad agosto scorso, e per quattro giorni. Gran parte di quel che è stato salvato , catalogato dalla Spach, società archeologica affiliata all' Unesco, è stato depositato nelle cantine del ministero della Cultura. Impossibile stabilire quindi che cosa è stato distrutto in nome del Corano, e che cosa potrebbe essere invece sparito, con la copertura dell' editto, per essere contrabbandato altrove. Lo scempio delle opere d' arte è l' ultimo specchio in cui si riflette l' Afghanistan. Non bastano le motivazioni religiose per giustificare la campagna demolitrice del governo. È ver o che tra i talebani trionfano le fazioni più radicali. Ma dietro la distruzione si affaccia anche la sfida all' Occidente. Assediati dalle sanzioni per l' appoggio dato a Osama Bin Laden, accusati di traffico di droga e violazione dei diritti umani, i guerrieri d' Allah sembrano aver voluto riaccendere così i riflettori sul Paese. «Abbiamo garantito pace e stabilità dopo vent' anni di guerra», è il primo slogan recitato dal portavoce del ministero degli Esteri Faiza Ahmad Faiz, non appena si me tte piede a Kabul. «Abbiamo abolito le coltivazioni d' oppio. Adesso ci aspettiamo che la comunità internazionale riconosca il nostro governo». Un' operazione propagandistica difficile da gestire. Il fronte con l' opposizione, guidata dal comandante Massud, è ancora aperto. Guerra e carestia hanno spinto fuori dai villaggi 700 mila persone e altre 300 mila oltre la frontiera dell' Iran e del Pakistan. E anche Kabul, laboratorio della Sharia, la legge coranica, a quattro anni e mezzo dall' arrivo dei talebani, non è certo la vetrina migliore per ricavare una legittimazione, accordata finora solo dall' Arabia Saudita, dal Pakistan e dagli Emirati Arabi. Città di spie Kabul, messe alle costole di ogni straniero. Capitale di macerie, di mendica nti che stazionano a ogni incrocio, di bambini laceri e affamati. Per chi la ricorda negli anni in cui i mujaheddin, dopo la caduta del regime filosovietico di Najibullah, si combattevano da un quartiere all' altro, la capitale sembra aver fatto qual che progresso. In molte zone è tornata l' acqua e la luce. Ingorghi di automobili e biciclette guidano verso le strade del centro, in un' incalzare di bancarelle che smerciano frutta, verdura, pezzi di ricambio, orologi e persino merci semiproibite, come macchine fotografiche, sigarette, cosmetici importati dal Pakistan. Nonostante i bandi del regime, sul mercato sotterraneo circolano cassette di film: «Titanic» è la pellicola più amata, seguita dai James Bond d' annata. Ma la polizia religiosa, il braccio armato del ministero per la Promozione della virtù e la repressione del vizio, non ha mai sospeso le sue incursioni tra la popolazione. Gli agenti piombano dai loro pick-up, afferrano, bastonano, imprigionano chiunque violi i sacri editti . Uno degli ultimi riguarda il taglio dei capelli alla Leonardo DiCaprio: arrestati i barbieri e i loro clienti. I bambini giocano con gli aquiloni lungo le sponde fangose del fiume Kabul. Ma è proibito anche questo, così come parlare con gli stranie ri o riceverli in casa. Afisullah, 41 anni, una laurea in ingegneria presa a Mosca, si azzarda a farlo solo tra le mura di un ospedale gestito da occidentali. «Sotto i mujaheddin abbiamo visto le nostre case distrutte e saccheggiate, i nostri parenti deportati e uccisi, ma questi che sono adesso al potere non sono meglio degli altri. Viviamo con il terrore di infrangere le loro leggi. Tutto è considerato un crimine». Esiste una vita sotterranea, fatta di angoscia e paura. «In casa ascoltiamo mus ica, guardiamo qualche film, ma bisogna chiudere porte e finestre, in modo che nessuno veda. I nostri figli crescono senza istruzione. La stessa storia dei Buddha è la prova di come i talebani stiano distruggendo ogni traccia di cultura». La miseria è un destino di massa: «Un' intera classe professionale è senza lavoro. Qui si campa con pochi dollari al mese». L' embargo ha svalutato la moneta nazionale del 40 per cento, 70 mila afghani per fare un dollaro. Ma anche senza il tonfo della valuta, l' economia è quella di un Paese in guerra, delegata ai traffici del bazar o agli aiuti della comunità internazionale. Le donne restano avvolte nella burqa. Si avventurano a gruppi di tre o quattro. A passi incerti sotto i loro sudari, per far la spe sa al mercato. L' unico diritto riconosciuto è quello alle cure mediche. Dottoresse e infermiere sono le sole autorizzate a lavorare. Alla periferia di Kabul, tra case di argilla e palazzi, si nasconde uno dei pochi posti franchi del regime: una clin ica gestita da «Médecins sans frontières», dove le madri a viso scoperto passano le ore in attesa di far visitare i propri bambini. Anis ha 29 anni, i capelli raccolti in una coda di cavallo, il rossetto e gli occhi bistrati. «Lavorare qui dentro è l ' unico modo per non cadere in depressione. Fuori tutto ci soffoca». Una prigione in cambio di sicurezza? «Ma quale sicurezza. I talebani arrivano dentro le nostre case - incalza una dottoressa -. Con la scusa di cercare armi, saccheggiano e rubano». Non è questo quello che propagandano i guerrieri di Allah: il progetto teocratico di un emirato di fede sunnita che superi in «purezza» ogni altro regime islamico sembra naufragare in una serie di editti formali, più che in una vera morale religiosa . Come la distruzione dei Buddha. «Se ne sono andati all' altro mondo», sghignazza Ahmed, giovane talebano in carriera. È il loro vanto. Sarà forse anche il loro fallimento lunedi, 19 marzo 2001 «La mia fuga dai Talebani» Il racconto dell' inviata della Bbc espulsa da Kabul perché «comunista»Decisiva l' intervista a un intellettuale che definiva ignoranti gli islamici afghani «La mia fuga dai Talebani» Il racconto dell' inviata della Bbc espulsa da Kabul perché «comunista» DAL NOSTRO INVIATO ISLAMABAD (Pakistan) - Ventiquattr' ore per la sciare il Paese. Non c' è stato tempo che per impacchettare la propria roba e farsi accompagnare alla frontiera. Kate Clark, la corrispondente della Bbc a Kabul, ha lasciato la sua prima sede all' estero dopo 18 mesi di lavoro in Afghanistan. Persona non grata, secondo i Talebani. Agente della propaganda occidentale, «comunista». Nell' arco della stessa giornata, la giornalista ha visto i sorrisi trasformarsi in ostracismo. «Alle 9 - ha raccontato dal Pakistan - uscivo dal centro stampa di Kabul con il mio visto rinnovato per altri sei mesi. Due ore dopo mi sono sentita dire che era meglio che me ne andassi per un po' . Sapevo che questo sarebbe potuto succedere, ma è stato uno choc». La Bbc è la radio più ascoltata in Afghanistan. L' unica voce straniera, oltre alla radio dei Talebani, a divulgare notizie sul Paese, in inglese ma anche in pashtun. Nessun corrispondente era mai stato cacciato. Kate aveva vissuto da sola nella capitale, giovane donna occidentale a raccontare la criminal ità, la presenza di arabi e di pakistani nei campi di addestramento delle milizie integraliste, il massacro dei civili di etnia hazara che si è consumato a gennaio. Le era stato tollerato tutto, tranne l' ultima intervista trasmessa in pashtun, quell a a un intellettuale afghano emigrato negli Usa, Ashar Ghani, che condannava la distruzione dei due Buddha di Bamiyan. E' difficile trovare un solo afghano che fosse d' accordo con l' editto del capo dei Talebani, il mullah Omar, contro gli «idoli pa gani», racconta la giornalista. E' difficile trovare una sola voce nel mondo che possa difendere, in nome dell' Islam o di qualsiasi altro principio, l' attacco iconoclasta ai simboli di una civiltà millenaria. Ma l' interlocutore di Kate ha usato un a parola sbagliata nei confronti dei puri di Allah: jaahil, che significa ignorante. I Talebani hanno esibito l' orgoglio. Annunciando l' allontanamento dei «giornalisti comunisti che intendono imporre le proprie vedute». Due mesi fa era toccato a un interprete. Quando l' editto contro le statue è stato emesso, Kate Clark era in vacanza all' estero. Era riuscita a tornare lunedì, in tempo per trasmettere l' intervista incriminata. Tre giorni dopo è stata messa alla porta. «Sono una rifugiata del Pakistan», ha detto all' ufficiale di frontiera. «No, lei è una giornalista conosciuta. E' un onore averla come ospite», le ha risposto il doganiere. Kate ha cercato di non piangere. Ora è in Pakistan ma conta di tornare a Kabul. lunedi, 12 marzo 2001 «La strage delle statue è compiuta» I Talebani afghani a Kofi Annan: anche i grandi Buddha non esistono piùTesto non disponibile Ormai è solo un' enorme prigione, un campo di battaglia, una terra devastata e depredata. Dopo aver infierito con cannoni e sharia, la legge coranica, i Talebani avrebbero chiuso il cerchio, cancellando dall' Afghanistan, uno dei Paesi più ricchi e saccheggiati di opere d' arte, ogni traccia «politicamente scorretta» della storia. Pietre, legni, avori, tutto ciò che rimandava a un passato pre-islamico e che era sopravvissuto ai traffici e agli scempi degli anni passati, sarebbe finito in polvere. L' annuncio, dato dal regime, è stato riferito da Kofi Annan: «Tutte le statue trasportabili sono state distrutte», ha detto il segretario generale dell' Onu, dopo un incontro a Islamabad, in Pakistan, con il ministro degli Esteri dei Taleba ni, Ahmed Muttawakil. Troppo tardi anche per i due Buddha di Bamiyan. «La demolizione - ha spiegato il ministro ad Annan - sta per essere completata. Dei due monumenti rimane poca cosa». L' intervento del segretario generale dell' Onu per bloccare l' editto con i quali i Talebani hanno decretato l' eliminazione degli «idoli» è l' ultimo inutile passo della diplomazia internazionale. Le milizie coraniche, che controllano il 90% dell' Afghanistan, hanno voluto liquidare la questione come «un affar e interno e religioso», il completamento di un progetto teologico che vede l' applicazione della sharia su ogni aspetto della vita del Paese. Hanno smentito l' ipotesi di una ritorsione alle sanzioni, votate dall' Onu contro il regime per i suoi lega mi con Osama Ben Laden. Ma nello stesso tempo sono rimasti sordi davanti alle esortazioni dei più prestigiosi teologi (ulema) della Conferenza islamica, arrivati ieri a Kandahar, nel sud dell' Afghanistan, per incontrare il mullah Omar, capo delle mi lizie. «Se entrambe le parti, gli ulema e il mullah, dovessero emettere una sentenza secondo la quale la distruzione è impropria - ha detto Abdul Salam Zaef, ambasciatore dei Talebani in Pakistan - la accetteremo. Al momento non l' hanno fatto». I co nfini tra politica e religione restano confusi. Ma fino a quando la valle di Bamiyan, il museo di Kabul e gli altri siti dove sarebbe stata condotta la campagna demolitoria, non saranno aperti a testimoni esterni, resta misteriosa anche la fine delle opere d' arte. E' davvero tutto distrutto? C' è ancora qualcosa da salvare in Afghanistan? O statue e reperti potrebbero un giorno riapparire sottobanco sui mercati clandestini? Secondo il quotidiano britannico Guardian, alla frontiera con il Pakist an, le dogane sono in allerta. Ci si aspetta «merce fresca». «Tombaroli», ex guerriglieri, contadini in miseria sono sempre pronti a procurare qualunque pezzo. E i trafficanti hanno ottimi rapporti con i signori della droga, tanto buoni da potere usa re i loro canali, attraverso i quali passa il 79% dell' oppio prodotto nel mondo, per smerciare anche gli oggetti più antichi e preziosi. L' Afghanistan, del resto, è da sempre terra di razzie. «Ancora prima che cadesse la monarchia, all' inizio degl i anni ' 70, non era difficile vedere apparire nel bazaar di Peshawar, sul confine pakistano, o nei retrobottega di Karachi, statue e monili che si diceva provenissero dall' Afghanistan», racconta al Corriere Sebastiano Tusa, oggi direttore presso la Sovrintendenza alle belle arti di Trapani, all' epoca membro delle spedizioni archeologiche italiane dell' Ismeo in Asia Centrale. «Sapevamo che i magazzini del museo di Kabul venivano regolarmente saccheggiati». Il traffico viaggiava attraverso le valige diplomatiche o, come adesso, sulle rotte della droga. Attraversava il Kyber Pass, transitava oltre il confine pakistano nelle «zone del contrabbando» che costeggiano la regione tribale, da Quetta fino a Peshawar, per poi raggiungere il Giappon e, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Quando i sovietici nel 1989 si sono ritirati dall' Afghanistan si è gridato al grande sacco: l' oro di Telapata, 21 mila oggetti tempestati di turchesi, sarebbero stati prelevati, imballati e stipati sui camion d ell' Armata rossa. Mosca ha sempre negato. Ma tre anni dopo, con l' inizio della guerra civile tra le fazioni dei mujaheddin, del museo di Kabul, ridotto in macerie, e del suo patrimonio non rimaneva più nulla. Nel 1996, arrivati in città i Talebani, il museo è stato riaperto, alcune collezioni misteriosamente riapparse, altre definitivamente perdute. Chi ha preso cosa? Un paio di mesi fa, un commerciante inglese ha ricevuto una telefonata da un politico pakistano che lo invitava a vedere alcuni pezzi. Arrivato a Peshawar, l' antiquario è stato portato a casa di un capo tribale dove ha ritrovato niente meno che alcune delle tavolette d' avorio di Bagram, una delle collezioni più preziose risalente a 2000 anni fa, da tempo sparite dall' Afgh anistan. Ne ha comprate alcune per donarle a un museo. Londra, secondo il Guardian, rimane una delle principali piazze dello smercio, con prezzi che superano i 150 milioni di lire a manufatto. L' entità del contrabbando è stata rivelata da un carico destinato alla capitale britannica, a Francoforte e a Dubai, sequestrato nel 1998 a Peshawar: 2.500 pezzi, tra i quali molte opere buddhiste della civiltà Gandahara di 1500 anni fa. Una rete nascosta di piccoli commercianti, con base a casa propria, sarebbe capace di smerciare le antichità afghane in ogni parte del mondo. Clienti privilegiati, oggi come 30 anni fa, inglesi, americani, giapponesi. IL REGIME E I DUE BUDDHA I TALEBANI I guerrieri d' Allah, reclutati dalle scuole coraniche, vengono finanziati dal Pakistan e inizialmente anche dagli Stati Uniti. Invadono l' Afghanistan nel 1994, conquistando in pochi mesi le regioni meridionali. Nel 1996 prendono Kabul: il governo del presidente Rabbani e le forze del comanda nte Massud sono costrette alla fuga. Oggi controllano il 90% del Paese. Si ispirano a una versione ultra-integralista dell' Islam I BUDDHA DI BAMIYAN Le due principali statue, «condannate a morte» dall' editto dei Talebani, rappresentano le raffigura zioni del Buddha più alte del mondo: 53 metri una, 35 l' altra. Sarebbero state costruite tra il II e il V secolo dopo Cristo. Sono state scavate nella roccia di Bamiyan, la cittadina dell' Afghanistan centrale, nascosta a 2.500 metri di quota tra le montagne dell' Hazarajat sabato , 10 marzo 2001 I Talebani: decapitato il primo Buddha Le milizie afghane annunciano la demolizione degli «idoli». L' Onu vota una risoluzione: «Fermatevi»I Talebani: decapitato il primo Buddha Le milizie afghane annunciano la demolizione degli «idoli». L' Onu vota una risoluzione: «Fermatevi» La prima testa è caduta, mandata in frantumi da una carica di dinamite. Anche la base, quel che restava dei pi edi e della gambe del più alto dei due Buddha di Bamiyan, sarebbe stata distrutta dai Talebani. Il colosso di pietra, una scultura di 50 metri intagliata 1500 anni fa nel costone roccioso di una delle valli più spettacolari dell' Hazerajat, sarebbe r idotto a un tronco informe, ultima reliquia di una memoria con i giorni contati. Uguali segni di demolizione sarebbero visibili sul secondo Buddha, 35 metri d' altezza, scolpito nella stessa parete di roccia. Dopo tre giorni di pausa, obbligata dalla festività islamica di Eid al-Adha, i Talebani, le milizie integraliste che controllano il 90% dell' Afghanistan, si sono rimesse al lavoro con caparbia puntualità. L' editto con il quale il loro leader, il mullah Omar, ha ordinato la demolizione di tutti «gli idoli» del periodo pre-islamico, sottoscritto dagli ulema e dalla Corte suprema, ha la forza di una fatwa. Una sentenza irreversibile. Le notizie che arrivano da Bamiyan continuano però ad essere confuse. Se l' Afghan Islamic Press, l' age nzia di stampa vicina al regime, ha ufficializzato la decapitazione del Grande Buddha, altre fonti riferiscono di distruzioni ancora più ampie e di un frenetico passaggio di cariche di tritolo su e giù per la valle. «Secondo i nostri rapporti, la dem olizione è cominciata giovedì pomeriggio ed entrambe le statue sono state attaccate con gli esplosivi - ha detto ieri uno dei portavoce delle forze d' opposizione da Daraye Souf, a nord di Bamiyan -. Entro oggi (cioè ieri, ndr) completeranno lo sforz o abbattendo quel che rimane della statua più alta». Una guerra nella guerra. Qualche chilometro più in là, sono ripresi i combattimenti tra le milizie coraniche e l' Alleanza del Nord, la coalizione, sempre più scompaginata e fragile, guidata dal co mandante Massud dal 1996, quando i Talebani hanno conquistato la capitale Kabul. I combattimenti, assieme al freddo e alla carestia, continuano a far vittime e produrre profughi: un milione di persone sfollate tra il nord del Paese e il Pakistan. Ma l' emergenza umanitaria rimane in secondo piano di fronte all' attacco alle opere d' arte. Tutti gli sforzi della diplomazia sono concentrati sul miracolo: salvare in extremis le macerie della storia. Ha fallito però anche l' ultima delegazione invia ta dal governo giapponese a Kandahar, capitale «morale» dei Talebani, con una cospicua offerta di aiuti per la popolazione. «Ci hanno proposto di trasportare le statue fuori dall' Afghanistan - ha detto il ministro degli Esteri Ahmed Muttawakil -, ma io ho risposto che l' Islam non accetta tali proposte, né potrebbero farlo gli studenti afghani di teologia». Inutile, probabilmente, anche la risoluzione votata ieri all' Onu in cui si esortano i Talebani a fermare l' opera di distruzione. È propri o con le Nazioni Unite, dopo il rafforzamento dell' embargo votato a gennaio dal consiglio di sicurezza, sotto pressione di Usa e Russia, che i Talebani sono in crisi: le Superpotenze domandano loro di consegnare Osama Ben Laden, lo «sceicco del terr ore» ospitato dal regime. Le milizie rispondono con la distruzione delle statue. L' ultima opera di convincimento è affidata oggi al ministro degli Esteri del Pakistan, Moinuddin Haider. I Talebani sono creature di Islamabad. È il Pakistan forse l' u nico Paese che può ancora dirigere il gioco. martedi, 06 marzo 2001 La sfida dei Talebani «Un quarto dei Buddha è già stato distrutto» «Il mondo è contro di noi ma non ci fermeremo». Il Giappone: «sarà molto difficile ora aiutare Kabul»Il regime integralista afghano La sfida dei Talebani «Un quarto dei Buddha è già stato distrutto» Il mullah Omar ha parlato attraverso Radio Sharia: «Musulmani afghani, non lasciatevi intimidire dagli infedeli. Respingete la propaganda dell' Occident e». Parole di piombo contro i Buddha di Bamiyan. Il capo dei Talebani ribadisce la condanna a morte dei due «idoli» di pietra e di tutte le altre statue pre-islamiche dell' Afghanistan. «Non rappresentano - ha detto il mullah - che l' 1% del patrimon io storico-culturale del Paese. E in ogni caso i sacri principi dell' Islam impongono di cancellarli». Le proteste, arrivate dalla comunità internazionale contro l' editto che sancisce la demolizione delle opere d' arte, non hanno aperto brecce. Al c ontrario. Sembrano aver ingigantito l' orgoglio dei guerrieri di Allah: «Il mondo è contro di noi - ha incalzato il mullah Omar - ma questo non ci scoraggia. Noi proseguiamo sulla strada dell' Islam». Qualche ora dopo, l' annuncio dal Pakistan, per b occa di Abdul Salam Zaef, ambasciatore delle milizie coraniche a Islamabad: «I Talebani hanno iniziato ieri, 4 marzo 2001, a demolire le statue di Bamiyan». Non sono bastati i cannoni, le granate, i proiettili a sconfiggere il nemico di pietra. Il 4 marzo 2001 è stato anche il giorno della dinamite. Una carica piazzata tra le gambe millenarie dei due Buddha, costruiti tra il II e il V secolo dopo Cristo, avrebbe fatto saltare in aria «un quarto» dei colossi che il mondo considera patrimonio dell ' umanità. E' insorto l' Oriente buddhista. Sadaki Numata, ambasciatore giapponese in Pakistan, ha ricordato al collega Zaef che la distruzione «renderà molto difficile la mobilitazione dei donatori» per l' Afghanistan. Una minaccia pesante per un Pa ese colpito, oltre che da vent' anni di guerra, da una delle peggiori carestie del secolo, con un milione di persone in fuga, ammassate nei campi profughi fuori e dentro il confine. E ha protestato anche la Chiesa cattolica, attraverso un editoriale dell' Osservatore romano: «Quando prevale l' oltranzismo fanatico non si distrugge solo l' opera d' arte dell' uomo, ma l' uomo stesso». Il mullah Omar, personaggio misterioso e inaccessibile, parla raramente. Se ha deciso di farlo significa che vuol e lo scontro. Ma non si tratta solo di una guerra di religione. Il capo dei Talebani, combattente durante la resistenza contro i sovietici (perse un occhio durante il bombardamento a un villaggio), gode di grande carisma presso i pashtun (l' etnia de l sud predominante tra le milizie islamiche). La leggenda dice che furono i suoi compaesani di Kandahar a rivolgersi a lui come a un grande saggio, negli anni del conflitto civile tra i mujaheddin del 1992-96, per vendicare lo stupro di una ragazza e ripulire la regione dai banditi. Attorno al mullah si sarebbero quindi raccolti i primi «studenti» delle scuole coraniche, finanziati dal Pakistan. Anche gli Stati Uniti diedero una mano nella speranza di sbloccare il progetto per un mega-oleodotto. Timido, riservato, analfabeta, Omar non è mai voluto uscire dall' Afghanistan nè tanto meno trattare con i rappresentanti occidentali. Mentre il suo regime veniva accusato di violazione dei diritti umani e di traffico di droga, il mullah stringeva u n patto di ferro con lo sceicco saudita Osama Bin Laden, fino a dargli in moglie una delle sue figlie. Gli attentati terroristici, che sarebbero stati organizzati dal suo ospite, hanno accentuato l' isolamento del regime. La tensione sembrava essersi allentata a settembre scorso, quando i Talebani hanno travolto Toloqan, uno dei bastioni dell' opposizione, guidata dal comandante Massud: segno che gli aiuti agli avversari erano scemati. Anche i loro nemici tradizionali, come la Russia e l' Iran s embravano disposti a riaprire i primi canali commerciali. Ma poi è ricominciato il braccio di ferro su Osama e nei mesi scorsi sono arrivate le sanzioni dell' Onu volute da Usa e Russia. Il mullah ha rilanciato la nuova jihad: quella contro i simboli della storia. lunedi, 05 marzo 2001 Buddha, no talebano all' Unesco Il ministro degli Esteri: nessuna possibilità di fermare l' attacco alle statueL' inviato dell' ente mondiale deve incassare il no dei guerriglieri afgani Buddha, no talebano all' Unesco Il ministro degli Esteri: nessuna possibilità di fermare l' attacco alle statue La missione, che avrebbe dovuto salvare i Buddha di Bamiyan da lla fatwa islamica, è stata inutile. Il rappresentante speciale dell' Unesco Pierre Lafrance, arrivato ieri a Kandahar, il quartiere generale dei Talebani nell' Afghanistan meridionale, si è trovato di fronte alle posizioni irremovibili dei guerrieri di Allah. E' stato il ministro degli Esteri, Wakil Ahmed Mutawakel, a togliergli ogni illusione: «Non vedo nessuna possibilità di cambiare la nostra decisione e di fermare la distruzione delle statue - ha detto -. L' attacco continua». E anche se la stazza massiccia dei due monumenti, alti uno più di 50 metri e l' altro 35, resiste ai colpi sparati dai cannoni, dai lanciarazzi, dalle armi automatiche, i Talebani lasciano intendere che non rinunceranno a disintegrarli. La sorte dei Buddha resta un giallo. Un abitante della zona, Safdar Alì, ha raccontato di aver visto «i miliziani talebani sparare contro le statue con cannoni anti-aerei». Non ci sono altri testimoni. Ma la comunità internazionale continua a pensare che non tutto è perduto. Secondo Dimitrios Lundras, ambasciatore greco a Islamabad, «la demolizione dei Buddha non è ancora cominciata». Il diplomatico parla a nome della Spach, la società archeologica creata per la tutela del patrimonio dell' Afghanistan, che vede la Grecia alla presidenza e l' Italia come primo finanziatore. «Credo che le pressioni internazionali abbiano funzionato», diceva ieri mattina al Corriere. L' intransigenza dei Talebani, colpiti dall' embargo votato all' Onu, sarebbe solo un gioco delle parti ? Un altro ministro del regime, Qadratullah Jamal, ha pronunciato parole che per la prima volta danno un senso politico all' operazione iconoclasta: «La comunità internazionale ha isolato l' Afghanistan. L' Onu deve domandare a Rabbani di proteggere i Buddha». Rabbani, il leader scacciato da Kabul nel 1996 all' arrivo delle milizie integraliste, è l' unico presidente riconosciuto dell' Afghanistan. Il suo esercito, comandato da Massud, continua la guerra con i Talebani, appoggiato da Russia, Ira n, India. Al contrario il regime degli integralisti è legittimato solo da Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati. Le proteste continuano. L' ultima è arrivata dal vertice del G8 riunito a Trieste: il documento finale rivolge un appello ai talebani affin ché non attuino la loro decisione, definita «profondamente tragica». Un' altra reazione è arrivata dall' Italia. Franceso Rutelli, il candidato dell' Ulivo, chiede «un' iniziativa molto più energica alla comunità internazionale», aggiungendo: «Se fos si premier prenderei subito un aereo per l' Afghanistan». domenica , 04 marzo 2001 Buddha giganti, tre giorni per la distruzione L' ESPERTO. «Non si fermeranno, perderebbero la faccia». Il ministro talebano dell' Informazione: testa e gambe già demolite. L' Unesco: c' è una debole speranzaProteste contro l' operazione sono arrivate da tutto il mondo islamico. Il Dalai Lama si è detto «colpito e preoccupato» Buddha giganti, tre giorni per la distruzione Il ministro talebano dell' Informazione: testa e gambe già demolite. L' Unesco: c' è una debole speranza Tre giorni ancora e la demolizione sarà completata, dicono a Kabul. Dei due Buddha giganti che dominano la valle di Bamiyan, nel centro dell' Afghanistan, resteranno solo detriti e polveri secolari. Un ricordo della storia, disi ntegrato dalla furia religiosa di una milizia, quella dei Talebani, che ancora una volta sfida l' Occidente con una decisione sconcertante. Non ci sono prove. Non ci sono testimoni che possano raccontare al mondo quello che sta davvero succedendo all e grandi statue scolpite nella roccia tra il secondo e il quinto secolo dopo Cristo. Ma le voci che arrivano da Kabul, sebbene contraddittorie, sembrano dimostrare che il regime non intende salvare nessuna delle opere d' arte, bollate da un editto de gli ulema come blasfeme e anti-islamiche. Il ministro dell' Informazione dei Talebani, Qadratullah Jamal, ha parlato di nuovo: «La testa e le gambe dei Buddha - ha detto ieri - sono già state demolite. In tre giorni completeremo l' opera». Poi si è s mentito: «Dozzine di idoli» sono state distrutte ad Herat, a Ghazni, a Kabul, a Jalalabad, «due terzi di tutte le statue pre-islamiche dell' Afghanistan», ma non «sono sicuro sulla sorte dei Buddha di Bamiyan». In un' altra dichiarazione, aveva detto invece che non era stato sufficiente bombardare le statue con granate e proiettili da cannone, ma che c' erano voluti anche dinamite, martelli e scalpelli. Parole diverse devono essere arrivate all' orecchio dei diplomatici occidentali, se Pierre La france, inviato speciale dell' Unesco, dopo un incontro in Pakistan con il rappresentante dei Talebani Abdul Salam Zaef, ha parlato di «una debole luce di speranza per i Buddha». E' probabile che sulla sorte delle due statue ci sia uno scontro tra l' ala oltranzista e quella meno dura dei Talebani. Di certo, la pressione contro il regime continua a crescere. Dopo l' appello dell' Onu, sono arrivate valanghe di proteste dalla comunità buddhista mondiale con il Dalai Lama «colpito e preoccupato» e dagli stessi Paesi islamici. Oltre all' Egitto, all' Iran e al Pakistan, si è schierato contro anche il Qatar. L' archeologo indiano che dal ' 68 al ' 77 curò il restauro dei Buddha, il professor Rakhaldas Sengupta, ha voluto ricordare che «le statu e non fanno danno a nessuno, non fanno convertire nessuno, non vengono adorate dai buddhisti». C' è un prezzo da pagare per salvare i Buddha più antichi e più grandi del mondo? Dietro l' accanimento teologico, si gioca certamente una partita politica . I Talebani, osteggiati dalla comunità internazionale per la protezione accordata a Osama Bin Laden, sono stati colpiti di recente da un embargo dell' Onu che suona come un ultimatum. La vendetta iconoclasta potrebbe essere la loro risposta. L' ESPERTO «Non si fermeranno, perderebbero la faccia» Prima dell' invasione sovietica del 1979, lavorava come archeologo in Afghanistan. La guerra e l' emergenza umanitaria l' hanno spinto a un impegno diverso: osservatore per la Federazione interna zionale dei diritti dell' uomo e poi coordinatore di Médecins du monde. Oggi Michael Barry, 52 anni, orientalista americano, ricercatore a Parigi presso l' Istituto di studi iraniani della Sorbona, ha tra i suoi incarichi anche quello di consulente d ell' Unesco. Conosce ogni pietra dei Buddha di Bamiyan, come di ogni altro sito archeologico dell' Afghanistan. E conosce anche i motivi che spingono i Talebani nella campagna contro le opere d' arte pre-islamiche. «Da quando l' Afghanistan diventò i ndipendente nel 1919, fino a quando venne invaso dai russi, non c' è stato governo che non si sia impegnato a promuovere l' archeologia come fondamento dell' identità nazionale - spiega -. Il nuovo Stato seguiva l' esempio dell' Iran, dell' Egitto, d ella Turchia, di tutti i Paesi musulmani. Venivano invitati archeologi francesi, italiani, giapponesi, indiani proprio con lo scopo di resuscitare il passato». Quando è cominciata la distruzione del patrimonio artistico dell' Afghanistan? «I comunist i hanno continuato a proteggere le opere d' arte. Sono stati alcuni gruppi di mujiheddin, dopo il ritiro dei russi, ad accanirsi sul centro buddista di Hadda, nell' Est del Paese, dove sorgeva un complesso del III secolo dopo Cristo. Negli anni succe ssivi, quando è scoppiata la guerra civile tra le fazioni, ho visto i miliziani dell' Hezb el Wahdat, uno dei gruppi sciiti, bombardare e saccheggiare il Museo di Kabul. Non per ragioni ideologiche, ma predatorie. Molte opere d' arte sono state vendu te fuori dal Paese. Poi sono arrivati i Talebani: i primi danni li hanno fatti nel 1995 ad Herat, contro le decorazioni alle tombe dei "santi" del sufismo». Crede che la ragione del loro accanimento sia realmente religiosa? «Certamente. I Talebani pr aticano il wahabismo, una corrente dell' Islam che si è sviluppata nel XVIII secolo nella penisola arabica. Secondo questa dottrina, ogni forma di civiltà nata dopo la morte del Profeta e dei quattro Califfi rappresenta un' "innovazione blasfema" o u na "deformazione" dello spirito originario dell' Islam. Banditi la musica, il gioco degli scacchi, le miniature figurative. E' considerato blasfemo anche il misticismo islamico come il sufismo, e tanto più una religione diversa come il buddhismo». Ma è il Corano ad autorizzare la distruzione delle statue antropomorfiche? «No, non esiste nessuna prova che sia stato il Profeta. Le teorie che autorizzano la distruzione degli idoli si rifanno ai fenomeni iconoclasti dell' VIII-IX secolo. Dalla Spagn a all' India, i governanti musulmani hanno sempre accettato ritratti, statue, icone all' interno dei propri palazzi». Crede che i Talebani andranno avanti? «Sì, purtroppo. L' opera di distruzione è già in corso. La demolizione dei Buddha, i monumenti afghani più conosciuti a livello internazionale, rappresenta la fine del processo. Solo le pressioni dall' estero erano riuscite finora a salvare le due statue». Non pensa che ci sia anche una motivazione politica? «I Talebani speravano forse con qu esta minaccia di ottenere il riconoscimento internazionale. Ma sono rimasti incatenati dal loro stesso editto: se si fermassero perderebbero la faccia e la credibilità di fronte ai credenti». sabato , 03 marzo 2001 L' ira dei talebani, bombardati i Buddha Cannoni e razzi contro le statue millenarie. Inutile la missione dell' inviato OnuAfghanistan, gli integralisti islamici ignorano gli appelli mondiali. L' India: custodiamo noi le sculture Buddha bombardati, l' ira dei talebani Cannoni e razzi contro le statue millenarie. Inutile la missione dell' inviato Onu La fine dei due Buddh a è arrivata. La loro mole di pietra, intagliata più di 1.500 anni fa nelle rocce dell' Afghanistan, è stata bombardata ieri dai cannoni, dai lanciarazzi e dai Kalashnikov dei «guerrieri di Allah». Le loro orbite cieche, le loro teste senza faccia, g li enormi busti mutilati dalle guerre che si sono susseguite nella regione non veglieranno più sulla valle di Bamiyan, a 2.500 metri di altezza, tra le montagne incantate dell' Hazarajat. I talebani, le milizie integraliste, avrebbero usato tutti i m ezzi, preparando cariche di dinamite da fare esplodere probabilmente oggi, per distruggere quei simboli di diversità che il mondo considera patrimonio dell' umanità e loro bollano come «idoli degli infedeli». In un Paese su cui impera ormai solo l' i ntransigenza della sharia, il sonno della ragione ha partorito anche questo: la condanna a morte delle opere d' arte. Non ci sono testimoni diretti. L' intera zona di Bamiyan è stata evacuata nei giorni scorsi, come un territorio di guerra. Ma le not izie filtrate dall' Afghan Islamic Press, l' agenzia di stampa vicino al governo, parlano di un «attacco» armato contro le icone dell' «idolatria». Un comandante dell' opposizione avrebbe assistito da una collina a una pioggia di tiri contro i monume nti, uno alto 50 metri, l' altro 35, banditi, come ogni opera artistica del periodo pre-islamico, da un editto del regime. E' stato il mullah Omar, il capo dei talebani, un guerrigliero analfabeta cieco di un occhio, a ordinare lo scempio. Il suo bra ccio legislativo è il ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, l' organismo che regola la vita dei civili con la sua sfilza di paradossali divieti. Ma anche i volti più morbidi del regime, come il ministro degli Esteri Waki l Ahmed Mutawakel, si sono dovuti allineare alle decisioni dei falchi. Inutile la missione dell' inviato speciale dell' Onu per l' Afghanistan, Francesc Vendrell. Il diplomatico spagnolo, dopo aver parlato per tre ore con Mutawakel, ha messo in guard ia i guerrieri coranici sulle conseguenze del loro gesto. «I talebani pagheranno caro quanto stanno facendo», ha detto. Il direttore generale dell' Unesco, il giapponese Koichiro Matsuura, ha mandato un suo inviato a Kabul, ma ha ammesso anche la sua sconfitta: «Mi mancano parole per descrivere i sentimenti di costernazione e impotenza». Altri Paesi si sono fatti avanti con proposte concrete. L' India, accusando i talebani di «regressione alla barbarie medioevale», si è offerta di prendere in ca rico le opere d' arte incriminate e così pure il Metropolitan Museum di New York. Persino il Pakistan, l' alleato storico dei guerrieri di Allah, il burattinaio della loro avanzata nella regione, ha condannato il vandalismo dei suoi vicini. Il regime di Kabul, già colpito dalle sanzioni dell' Onu a dicembre scorso, oggi sembra davvero solo. Ma la sua intransigenza rischia di portare il Paese alla catastrofe. Il fronte aperto con l' opposione, guidata dal comandante Massud, assieme alla devastant e carestia, che quest' anno ha colpito gran parte dell' Asia Centrale, hanno già provocato l' esodo di oltre 500 mila persone e centinaia di morti per la fame e il freddo. Come ricordano le agenzie umanitarie, l' Afghanistan ha bisogno di assistenza. Non di un altro braccio di ferro. LA SENTENZA «Solo Allah sia venerato» Ecco la condanna del mullah «Tutte le statue che si trovano nelle varie regioni del Paese dovranno essere distrutte». Il decreto, pubblicato lunedì scorso, d opo una consultazione tra il capo dei talebani, Mullah Omar, i teologi musulmani e la Corte suprema dell' Emirato islamico dell' Afghanistan, aggiunge: «Queste statue sono state utilizzate in passato come idoli e divinità per gli infedeli. Rischiano di ridiventare idoli anche in futuro. Solamente Allah deve essere venerato e tutte le false divinità dovranno essere annientate». venerdi , 02 marzo 2001 I talebani non si fermano: assalto ai due Buddha Afghanistan, gli integralisti eseguono la sentenza della Corte Suprema: eliminare le statue pre-islamiche. Tesori, templi e monasteri Ecco i gioielli in pericolo Le sculture, risalenti a duemila anni fa, scavate nella roccia. L' esperto: ma il Corano non ordina l' abbattimento delle vestigia I talebani non si fermano: assalto ai due Buddha Afghanistan, gli integralisti eseguono la sentenza della Corte Suprema : eliminare le statue pre-islamiche Hanno impiccato la gente negli stadi. Hanno tolto alle donne ogni diritto. Hanno strangolato un intero popolo con la furia dei loro editti. Da ieri i Talebani, le milizie integraliste che controllano il 90% dell' A fghanistan, hanno cominciato a devastare anche le memorie più antiche del Paese: i due Buddha giganti di Bamiyan, le preziosissime statue scavate nella roccia a 2.500 metri d' altezza. E con esse ogni altra scultura che risalga al periodo pre-islamic o, ogni opera d' arte che raffiguri l' essere umano, ogni icona che violerebbe, secondo il mullah Omar, capo supremo dei Talebani, le prescrizioni della legge coranica. Non sono servite le proteste dell' Unesco, le pressioni della comunità internazio nale, le dichiarazioni di sdegno arrivate da ogni parte del mondo. La sentenza pronunciata lunedì dalla Corte suprema («Tutte le statue saranno distrutte», solo Allah sarà venerato) si è tradotta ieri in furia iconoclasta, vandalismo ideologico parag onabile, su scala più ridotta, all' opera di distruzione ordinata da Mao Zedong durante la rivoluzione culturale cinese. Gli agenti della polizia religiosa si sarebbero messi al lavoro all' alba, agli ordini del ministero per la Promozione della virt ù e la prevenzione del vizio, cominciando a setacciare la capitale Kabul e la città di Ghazni. Non si sa se siano effettivamente arrivate a Bamiyan. Ma le parole del ministro dell' Informazione, Quadratullah Jamal, lasciano poche speranze: «Nessuna s tatua sarà risparmiata, nemmeno i Buddha di Bamiyan». E' davvero l' atto finale di un sito archeologico considerato patrimonio dell' umanità? Bamiyan è un posto di incredibile bellezza, a 230 chilometri da Kabul, tagliato fuori dalle rotte turistiche da oltre vent' anni di guerra. Chiuso fra una catena di monti che la luce tagliente dell' Asia centrale colora di verde, di azzurro, di viola, accoglie una distesa di case di fango, protette da falesie rosa, nelle quali tra il II e il V secolo dopo Cristo vennero scolpiti i due Buddha: uno di 50 metri, il più alto della terra, l' altro di 35. Nell' antichità fu centro di preghiera lunga la Via della seta. Negli ultimi anni, solo una tormentata prima linea delle milizie che hanno fatto scempio d ella regione. Il viso dei due Buddha era stato sfregiato da antichi invasori, ma la guerra recente ha coperto di mitragliate i loro busti. Quando i talebani hanno conquistato Bamiyan nel 1998, i piedi delle statue erano stati trasformati in un deposi to per munizioni. E già allora i capi più facinorosi minacciavano la demolizione. Si era messo di mezzo l' Unesco e i Talebani avevano finito per rassicurare la comunità internazionale. Lunedì scorso, invece, l' editto che li mette fuori legge. Un ge sto imperdonabile per gli stessi Paesi islamici: «I musulmani non hanno mai distrutto le statue in nessuno dei Paesi dove hanno governato - ha commentato ieri l' intellettuale egiziano Fahmi Ho weidi -. Questa decisione danneggia l' Islam». Una decis ione che «ha scioccato» il direttore dell' Unesco Koichiro Matsuura, che ha sconcertato Russia, India, Thailandia, che ha suscitato le protese dell' Unione Europea e dell' Onu con un tentativo in extremis di fermare i Talebani. «Un segnale devastante », ha detto il sottosegretario agli Esteri Ugo Intini, in nome dell' Italia, che da tempo lavora a una soluzione del conflitto afgano. Di certo, il segnale che fra i Talebani prevale l' ala radicale. E che le sanzioni, votate di recente all' Onu per la protezione accordata dal regime a Osama Bin Laden, hanno solo esasperato la sfida dei guerrieri di Allah all' Occidente. NEL MIRINO Tesori, templi e monasteri Ecco i gioielli in pericolo MILANO - Mentre i talebani annunciano or gogliosamente di avere iniziato la distruzione metodica delle due gigantesche sculture di Buddha, a Bamiyan, ci si chiede quale sarà il destino dell' intero patrimonio culturale dell' Afghanistan. U na rapida ricognizione delle opere pre-islamiche, e quindi «a rischio», porta subito a una brutta «scoperta»: gran parte dei tesori afgani sono distrutti o scomparsi, specie quelli che erano conservati al museo di Kabul. Ecco i casi più clamorosi. L' ARSENALE AI PIEDI DI BUDDHA - Le due statue di Bud dha a Bamiyan erano già state ampiamente danneggiate prima di essere condannate alla distruzione. Sulla falesia di Bamiyan, oltre alle due statue, sono scavate oltre 750 cappelle dove erano custodite statue e dipinti. Oggi è tutto devastato e in abba ndono. Alla base delle statue, come ha scritto James Levis su Archeo (gennaio 2001), vi sono alcune sale dove sono scomparsi affreschi e statue. Gli ambienti sono stati «trasformati in depositi di armi: in una sala armi automatiche e razzi, in un' al tra mine anticarro di fabbricazione iraniana, statunitense e italiana, nuove di zecca, detonatori per mortai, pericolosamente confusi con mine antiuomo russe, pakistane e cinesi». I GIOIELLI DI TILLIA TEPE - Nel 1978, una missione archeologica afgano -sovietica scoprì nel Nord del Paese un massiccio edificio di culto e sei necropoli reali con migliaia di tombe del I-II secolo dopo Cristo. In ognuna delle tombe scavate vennero rinvenuti dai 2.500 ai 4.000 oggetti d' o ro, oggetti di squisita fattu ra in cui si individuano influenze greche, partiche, scitiche e indiane. Una parte di questi tesori venne portata in Urss, un' altra fu esposta a Kabul nel 1987. Da allora non se ne è saputo più nulla. IL TESORO DI BEGRAM - Nel 1937, a nord della cit tadina di Begram (a nord di Kabul), vennero scoperte le rovine di Kapisa, capitale del regno Kushana tra il I e III secolo dopo Cristo. In una stanza del palazzo reale gli archeologi trovarono una grande quantità di oggetti in bronzo, vetro, avorio e lacca. Un vero tesoro che testimonia traffici e contatti sia con le civiltà del Mediterraneo che con la Cina del Han. Fra tutti spiccano gli avori di origine indiana intarsiati con scene di gineceo. Questo gruppo di raffinati capolavori venne suddiv iso tra il museo francese Guimet e il museo di Kabul. Oggi gli avori rimasti a Kabul sono scomparsi. IL MONASTERO DI TEPE CHOTOR - Negli anni 60 gli archeologi scoprirono un imponente monastero buddista del III-IV secolo dopo Cristo. Era formato da u n grande edificio centrale (stupa) e da vari stupa minori attorno ai quali vennero ritrovate moltissime statue. Gli archeologi afgani decisero di conservare l' intero complesso realizzando una grande copertura. Tutto è andato distrutto nel 1982 duran te i combattimenti fra le truppe sovietiche e i mujaheddin. I TEMPLI DI TAPA SARDAR - Archeologi italiani guidati da Maurizio Taddei scavarono negli anni 60-70 il monastero buddista di Tapa Sardar, sull' altipiano di Ghazni. Nei grandi stupa vennero rinvenute statue di terra cruda, di dimensioni imponenti, riferibili all' arte Gandara. I materiali furono raccolti nel museo di Kabul (incendiato e saccheggiato nel 1995). Nessuno li ha più visti. Viviano Domenici sabato , 05 settembre 1998 Negli Usa dibattito al Congresso sulla legittimita di eliminare i terroristi come il saudita Ben Laden L'America vuole uccidere Osama Un testimone italiano: nella fabbrica di Khartoum medicine, non armi chimiche WASHINGTON - Da un po' di tempo un quesito ossessiona il Congresso americano. Ma solo ieri i senatori hanno avuto il coraggio di formularlo ufficialmente, durante un'audizione del direttore dell'Fbi Louis Freeh: «Perché gli Stati Uniti non possono a ssassinare i terroristi?». In termini meno generici: perché non si può eliminare Osama Ben Laden, lo sceicco miliardario considerato il capo del terrorismo mondiale slamico, oltre che l'ispiratore degli attentati alle ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam del 7 agosto? «Mi piacerebbe molto avere un memorandum legale dall'Fbi in cui si spiega se il divieto di assassinare i capi di Stato è applicabile anche a criminali e a terroristi», ha detto il senatore democratico, Joseph Biden. Free h ha risposto di non essere sicuro che sia legale uccidere Ben Laden e ha promesso di studiare la questione. Nel frattempo ha lanciato un nuovo allarme: Ben Laden, ha detto, reagirà agli attacchi missilistici americani del 20 agosto contro i suoi c ampi di addestramento in Afghanistan. «Possiamo prevedere con un buon margine di certezza che ci sarà una reazione di Osama e della sua organizzazione». Secondo il direttore dell'Fbi gli obiettivi non saranno solo le ambasciate americane: «Abbiamo id entificato persone negli Stati Uniti o persone transitate attraverso gli Stati Uniti che sono suoi complici», ha spiegato, lasciando intendere che i terroristi islamici potrebbero colpire anche in America. Tutto quello che è rimasto a Khartoum, dop o il raid americano del 20 agosto, è un cumulo di macerie. E di misteri. Che cosa nascondeva veramente la «Shifa», la fabbrica sudanese colpita in contemporanea alla base afghana del terrorista islamico Osama Ben Laden? Impianti per la produzione dei micidiali agenti del gas nervino, come sostiene Washington? O solamente stock di farmaci benefici, come ribadisce il governo sudanese? Ad appoggiare la tesi dell'errore americano, compare un testimone italiano: Dino Romanatti, 60 anni, milanese, da oltre trent'anni impegnato nell'export di macchine e impianti per l'industria famaceutica e cosmetica. La sua versione (anticipata in una lettera pubblicata oggi dal Corriere nella rubrica «La stanza di Montanelli»), sembra assolvere la «Shifa» da og ni accusa di attività sospetta. «Da tempo - spiega Romanatti - giro il mondo arabo per vendere i miei macchinari. Gli affari con il Sudan mi sono stati proposti un paio di anni fa da un farmacista giordano, Ahmad Salem Lubbad, socio fino a qualche me se fa della "Shifa" di Khartoum». Nel '97, la prima ordinazione: una linea completa di macchinari per il lavaggio, il riempimento e l'etichettatura di flaconi per sciroppi. La vendita in un primo momento si svolge per corrispondenza. Commesse per un miliardo di lire, pagate prima della consegna. Ma all'inizio di quest'anno, i proprietari della «Shifa» chiedono a Dino Romanatti di recarsi a Khartoum per controllare gli impianti. «Vado in Sudan due volte - dice l'imprenditore - a febbraio per un p eriodo di dieci giorni e a giugno per una settimana». Ed ecco che cosa vede l'italiano: «Una fabbrica circondata da un muro di cinta di due metri scarsi, con larghe inferriate, presidiato all'ingresso da un paio di guardie armate». Niente di diverso da un qualsiasi stabilimento della regione. «Nessun militare attorno». E soprattutto nessuna restrizione all'interno: «Sin dal primo giorno chiedo di poter lavorare oltre l'orario di chiusura della fabbrica, vale a dire oltre le cinque del pomeriggio , compreso il venerdì, giorno di festa islamico. Gli amministratori mi danno tranquillamente l'autorizzazione di rimanere dentro in compagnia dei miei tecnici, e mi forniscono persino le chiavi della palazzina che ospita la direzione, nel caso abbia bisogno di usare le linee telefoniche internazionali». Romanatti gira lo stabilimento in lungo e in largo: «Né sotterranei, né accessi misteriosi, né reparti chiusi a chiave. Quei pochi spazi che non ho visitato non mi è mai sembrato per dimensioni c he potessero contenere impianti chimici». Anche per quanto riguarda i macchinari l'imprenditore è sicuro di quel che dice: «Solo strumenti per confezionare medicinali. Nella fabbrica non solo non si producevano materie prime, ma mancavano persino i c acciavite». Romanatti stringe ottimi rapporti con il primo proprietario, Bechir Hassan Bechine. Non fa in tempo invece a incontrare personalmente Salah Idris, l'uomo d'affari sudanese che a marzo scorso ha comprato la «Shifa». Ma di una cosa è certo: «In quella fabbrica si entrava facilmente. Abbiamo organizzato banchetti in giardino con oltre 200 ospiti». Gli Stati Uniti si sarebbero dunque sbagliati a colpire la «Shifa»? Forse solo in parte. Tra tanti dubbi c'è una certezza: il regime islami co sudanese non ha mai nascosto gli sforzi fatti per acquistare armi chimiche e batteriologiche. E Ttu, bollettino settimanale arabo distribuito a Parigi, conferma nell'ultimo numero pubblicato ieri i sospetti americani su una collaborazione tra Suda n e Iraq per la produzione di gas nervino. A Khartoum - dice il bollettino - era presente una équipe scientifica irachena, diretta da un certo Tamir Abdel Rahaman, impegnata su un «progetto di industria di guerra». Il gruppo, che si serviva spesso di una società di trasporti aerei, la Transarabian, aveva trasferito la sua base di lavoro a Farjok, una località a nord della capitale. Il legame con la «Shifa»? L'attuale proprietario della fabbrica, Salah Idris. La Transarabian è sua. Ma c'è dell'al tro. Il governo nigeriano ha scoperto qualche mese fa che un aereo della compagnia trasportava un carico di armi afghane. E ancor prima, gli Emirati arabi avevano trovato materiale militare su un altro aereo della Transarabian destinato a Nairobi, la stessa città dove il 7 agosto è avvenuto il più sanguinoso dei due attentati africani contro le ambasciate americane, attribuiti dagli Stati Uniti a Osama Ben Laden. E' un caso? L'ipotesi è che gli americani avrebbero solo sbagliato la mira, quand o hanno sganciato i missili su Khartoum. Obiettivo più che la «Shifa» sarebbe potuta essere, per esempio, la località di Farjok. domenica , 23 agosto 1998 Il tenente colonnello, in missione Onu, vittima di una probabile rappresaglia per l'attacco americano. I talebani: E' morto Carmine Calo caduto in un'imboscata a Kabul. I testimoni: hanno sparato per uccidere Come i tre soldati morti negli scontri al check-point Pasta di Mogadiscio. Come i dieci rimasti uccisi lungo i fronti della guerra nell'ex Jugoslavia. Il nome di Carmine Calò, 48 anni, tenente colonnello prestato alle Nazioni Unite, da ieri è nella l ista di sangue degli italiani caduti in missione di pace. Un avvertimento agli occidentali. Un attentato mirato. Qualunque cosa sia stata, la raffica di kalashnikov sparata a Kabul contro un'auto dell'Onu, venerdì poche ore dopo le bombe americane sull'Afghanistan e il Sudan, ha colpito a morte l'ufficiale italiano. A ricostruire la sequenza che si è svolta nelle strade di Kabul è Annie Lavertu, moglie di Eric, il diplomatico francese che si trovava con Carmine Calò al momento degli spari. «Mi o marito e l'ufficiale italiano viaggiavano sull'auto dell'Onu - racconta al telefono da Islamabad - quando una seconda macchina si è messa di traverso, bloccando il passaggio. Sono usciti degli uomini armati di kalashnikov e hanno tirato dritto al p arabrezza». Un attentato in piena regola. Ma c'è dell'altro: «Non erano civili. L'auto era un pick-up militare dei talebani e anche gli assassini, da quello che ha detto mio marito, erano dei talebani». Eppure le milizie islamiche, che da settembre '96 controllano Kabul, sembrano essersi date un gran da fare a catturare i presunti assassini. «Abbiamo preso due pakistani», ha dichiarato ieri il gran mullah Mohammed Omar, autorità suprema dei talebani. Vero? Falso? Alcuni giorni prima degli atta cchi americani, i talebani si erano spaccati proprio sul loro «protetto», Osama Ben Laden, l'uomo che gli Stati Uniti hanno voluto colpire con le bombe di giovedì. Una parte delle milizie era d'accordo, nel caso in cui fosse stato dimostrato il coinv olgimento di Ben Laden nelle stragi di Nairobi e Dar es Salaam, a consegnarlo agli occidentali. Mentre l'ala più dura si era opposta a qualsiasi cedimento al Grande Satana. E' rimasta la stessa spaccatura? Una fazione «ufficiale» pronta ad accogliere l'appello del segretario dell'Onu Kofi Annan, a darsi da fare per catturare gli assassini, preoccupata forse di uno scontro diretto con gli Stati Uniti, che furono tra l'altro i primi finanziatori dei talebani? E un'altra parte pronta a radicalizzar e il confronto, cominciando con un agguato a un'auto dell'Onu? La signora Lavertu si limita a ricostruire gli avvenimenti: «Mio marito ha sentito solo un gran dolore al collo, probabilmente un proiettile che lo ha toccato di striscio. Ma non ha avu to il tempo di rendersi conto di nulla. C'era una seconda macchina dell'Onu dietro che ha portato sia lui sia Calò all'ospedale». Eric Lavertu, intervistato dalle agenzie di stampa all'ospedale militare di Islamabad, dove ieri sera è stata trasport ata la salma del tenente colonnello italiano, è stato molto più cauto nelle dichiarazioni: «Calò guidava, io gli stavo accanto. Una "utilitaria" ci ha bloccato la strada. Sono scesi due uomini e hanno aperto il fuoco». Il funzionario francese ha aggi unto in lacrime: «Ero pieno di sangue. Non riuscivo a vedere bene come stesse Calò quando l'hanno colpito. Mi ricordo solo che tentava di far ripartire l'auto. Quelli che hanno sparato devono aver pensato che io fossi morto. E forse questo mi ha salv ato la vita». Trasportato al Wazir Hakbar-Khan Hospital, l'ufficiale italiano è stato operato d'urgenza. Eric Lavertu, ferito lievemente, è rimasto lì per varie ore, ma non ha fatto in tempo a vedere se il collega avesse ripreso conoscenza. Un aere o dell'Onu l'ha evacuato in Pakistan nel pomeriggio. Per tutta la giornata di venerdì, fonti ufficiali italiane hanno continuato a ripetere che il tenente colonnello si era ripreso, che stava bene, che presto sarebbe stato evacuato anche lui. Ma ness un è in grado di dire in quali condizioni sia stato operato. «Il Wazir è il più grande ospedale di Kabul - dice Lelio Crivellaro, incaricato d'affari dell'ambasciata italiana a Islamabad -. Lì lavorano medici afghani che hanno studiato all'estero, es pertissimi sulle ferite d'arma da fuoco. E d'altra parte le condizioni dell'ufficiale erano tali che era impossibile pensare a un suo trasferimento». Carmine Calò era arrivato a Kabul il 18 luglio per una missione impossibile: portare la pace in un Paese dilaniato da vent'anni di guerra. Il tenente colonnello - arruolato in Italia conme tecnico elicotterista del XX Gruppo Squadroni Andromeda dell'aviazione e dell'esercito di Pontecagnano, in provincia di Salerno - faceva parte dell'Unsma, l'Un ited Nations special mission for Afghanistan, un gruppo impegnato nei negoziati tra i talebani e le forze dell'opposizione. Non era riuscito a far molto: poco dopo il suo arrivo le milizie coraniche avevano lanciato un'offensiva al Nord, bloccando qu alsiasi dialogo con i nemici. A poco gli è valsa l'esperienza accumulata negli anni passati in Libano, in Bosnia, lungo il confine indo-pakistano. La rabbia degli integralisti ha chiuso la sua sfida afghana. sabato , 22 agosto 1998 Il raid Usa scatena in Afghanistan la rabbia anti-occidentale. Washington consiglia l'evacuazione. Annan ai talebani: punite i responsabili dell'agguato Kabul, vendetta contro l'Onu: italiano ferito Raffica sull'auto dell'ufficiale in missione di pace. Un intervento d'urgenza gli salva la vita Non era un'alba come tante quella di ieri a Kabul. Era l'inizio di una giornata grigia di rabbia contro il «grande satana» occidentale. Il risveglio inquieto di un Paese, già avvelenato dai furori integralisti dei talebani, che si trovava a contare i morti e i feriti causati non dall'ennesimo scontro tra fazioni islamiche, ma dalle bombe americane della sera prima. E alle 7 del mattino, il passaggio per strada di quella jeep bianca, con l'insegna blu delle Nazioni Unite, deve essere apparso come un'ulteriore, sfacciata provocazione. Una raffica di kalashnikov, una ritorsione lanciata non si sa da chi, ha colpito l'auto. E dentro l'auto Carmine Calò, tenente colonnello italiano, a Kabul da poco più di un mese, per una difficile, forse improb abile missione di pace. Un proiettile e una pioggia di schegge di vetro l'hanno ferito a un polso e all'addome, sfiorando appena il collega francese che viaggiava con lui. L'ufficiale è stato trasportato al Wazir Hakbar-Khan Hospital, l'unico ospedal e funzionante di Kabul, e lì operato d'urgenza. In serata aveva già ripreso conoscenza, ma era ormai tardi per poter pensare a una evacuazione in Pakistan. Il suo arrivo a Islamabad è previsto per stasera. Prima vittima del rancore islamico, all'in domani degli attacchi americani in Afghanistan e in Sudan. O forse addirittura primo bersaglio di una sfida che si annuncia frontale. Il colonnello Carmine Calò, 48 anni, originario di Gesualdo (provincia di Avellino), era arrivato in Afghanistan il 18 luglio. Non era nuovo a questo genere di missioni. Arruolato in Italia come tecnico elicotterista presso il XX Gruppo Squadroni Andromeda dell'aviazione e dell'esercito di Pontecagnano, vicino a Salerno, aveva speso gran parte della sua carriera a ll'estero: veterano del Libano, reduce dalla Bosnia, dal '94 al '97 aveva partecipato all'Unmogip, il contingente degli osservatori militari Onu dislocato lungo il turbolento confine tra Pakistan e India. A Kabul lavorava per l'Unsma (United Nation s pecial mission for Afghanistan), unico italiano di un contingente formato da 5 funzionari civili e 5 ufficiali impegnati come mediatori di pace. Il segretario generale dell'Onu Kofi Annan ha subito condannato l'attacco, chiedendo ai talebani di «in vestigare sull'incidente e consegnare alla giustizia coloro che possono aver messo in atto questo odioso crimine». Annan ha anche annunciato che si stanno rivedendo tutte le misure di sicurezza per proteggere il personale Onu in Afghanistan. «Ma no n c'è dubbio - dice Lelio Crivellaro, incaricato d'affari all'ambasciata italiana di Islamabad in Pakistan - che la raffica sparata contro la macchina dell'ufficiale sia stata una reazione ai missili americani. Tutto lo fa pensare: Calò viaggiava su un mezzo delle Nazioni Unite e portava addosso la divisa militare. Un bersaglio preciso». Come ogni occidentale rimasto in Afghanistan. Compresi altri due italiani: un uomo e una donna che lavorano per la Croce Rossa. Il consiglio diramato dall'amb asciata americana di Islamabad suona già come un'ordine: «Evacuazione volontaria - dicono al quartiere generale delle Nazioni Unite - almeno per il momento». Ma non è esluso che l'aereo, già messo a disposizione dall'Onu all'aeroporto di Kabul, proce da presto allo sgombero «obbligatorio» dei venti funzionari Onu concentrati nella capitale. Solo la Croce Rossa sembra decisa a rimanere, seppur blindata, nei propri uffici. Le altre organizzazione umanitarie se n'erano andate il mese scorso, dopo un ultimatum dei talebani che pretendevano di far spostare tutti gli occidentali in un edificio semidistrutto, senza acqua e senza luce. «E' chiaro - dice ancora Lelio Crivellaro, l'incaricato d'affari italiano - che il problema della sicurezza a que sto punto è prioritario». A Kabul l'edificio che ospita il contingente Unsma - una villa in centro, nel quartiere Sharenaw («Città nuova»), protetta solo da sacchetti di sabbia e pellicole antischegge ai vetri - non è sufficente a garantire gli ospit i da eventuali attacchi. Ma la stessa presenza della missione Onu in questa situazione non ha più ragione di essere. «L'Unsma opera in Afghanistan dalla caduta del regime filosovietico di Najibullah, nel '92, quando è cominciata la guerra tra le fazi oni - spiega l'incaricato d'affari - ma è da quando i talebani sono entrati nella capitale, nel '96, che il contingente si è impegnato in una mediazione tra loro e le forze d'opposizione». Tempo perso: le milizie integraliste hanno disertato la commi ssione congiunta messa in piedi la primavera scorsa. E l'offensiva da loro sferrata nelle ultime settimane ha sancito il fallimento definitivo di ogni soluzione negoziale. «Il tenente colonnello Calò - aggiunge Lelio Crivellaro - era il primo italian o a partecipare alla missione». Un ufficiale cordiale e alla mano. Preparato e animato da buona volontà. Fatica sprecata. Adesso le milizie coraniche potranno ottenenere quello che hanno sempre voluto: ripulire il «sacro» Emirato d'Allah da ogni pres enza «impura». venerdi , 21 agosto 1998 IL COVO DEL TERRORE Kalashnikov, fax e satellitare: il bunker del terrore , Auto blindate, satellitari, fax, computer. Il nemico numero uno degli Usa, Osama Ben Laden, vive sospeso tra Medio Evo e futuro, nascosto tra le montagne più inaccessibili dell'Asia centrale. Si dice viva in Afghanistan, in un quartier generale, scav ato nella roccia, sicuro come un bunker e attrezzato con la più avanzata tecnologia occidentale. Secondo il Sunday Times, la fortezza del «terrorista più pericoloso del mondo» (come è stato definito da Sandy Berger, consigliere americano per la Sicur ezza) sarebbe formata da tre locali. Il primo è una camera da letto con tre letti bassi e una libreria piena di testi islamici. Lì dorme Ben Laden, con accanto il kalashnikov strappato a un generale sovietico ferito durante l'invasione, e con lui all oggerebbero le sue 4 mogli e i 10 figli. Un secondo locale è formato da una sala più piccola adibita ad arsenale. Il terzo è la sala operativa: scrivania con due computer, fax e telefono satellitare. Da lì Ben Laden si tiene in contatto con il suo uf ficio di Londra, diretto dell'editore Khaled Al-Fawwaz. E da lì gestisce anche un patrimonio stimato sui 450 miliardi di lire. La residenza è protetta da cannoni antiaerei e da ex mujaheddin afghani, sauditi, yemeniti e kuwaitiani. Ben Laden viaggia a bordo di una Toyota blindata. Resta un dubbio: dove si trova veramente la sua roccaforte? Nella zona di Khost, nord-est dell'Aghanistan, come fa credere l'attacco Usa? O proprio in Pakistan? Ad ascoltare tutte le voci, più che un bunker, il suo sem bra un castello incantato. lunedi, 27 ottobre 1997 OPPIO E POLITICA La commissario Ue contesta l'accordo tra Onu e Talebani sulla distruzione delle coltivazioni di papavero in Afghanistan Kabul fa litigare Bonino e Arlacchi Lui, dalla sua poltrona delle Nazioni Unite, lancia «un'iniziativa senza precedenti: un accordo per la distruzione delle coltivazioni d'oppio in Afghanistan». Lei, dal suo podio dell'Unione Europea, ribatte fulminea: «Un errore clamoroso. Accordi com e questo non hanno mai funzionato da nessuna parte del mondo». Lui è Pino Arlacchi, da settembre vice segretario dell'Onu e direttore dell'ufficio di Vienna per i programmi di controllo della droga. Lei è Emma Bonino, commissario europeo per gli ai uti umanitari. Due italiani per due cariche di primo piano in campo internazionale. Oggetto della lite: i Talebani, gli «studenti» coranici, signori di due terzi dello Stato islamico d'Afghanistan - da ieri ribattezzato Emirato islamico - e benefic iari di quasi tutte le coltivazioni di papavero, che fanno del Paese uno dei primi fornitori di eroina del mondo. Secondo l'accordo promosso da Pino Arlacchi, i Talebani dovrebbero provvedere alla riduzione progressiva dei campi d'oppio, in cambio di un pacchetto d'aiuti - l'equivalente di 40 miliardi di lire l'anno - per la riconversione delle colture. Per Emma Bonino, si tratta di un'assurdità. Anzi, di «una mossa naif», come dice il suo portavoce, Filippo di Robilant, che aggiunge: «Come pu ò permettersi l'Onu di stringere patti con i Talebani che violano tanto platealmente i diritti dell'uomo? Nessuno Stato ha ancora riconosciuto il loro governo in Afghanistan, a parte Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Quaranta miliardi sono u n grosso regalo. Si rischia di aiutarli a rifornirsi di armi». Pino Arlacchi finge di non rispondere: «Le solite polemiche all'italiana. Non mi interessa che cosa dice la Bonino. Tutti sanno bene che non stiamo consegnando nessun assegno in mano ai Talebani. Noi aiutiamo i contadini a riconvertire le coltivazioni e finanziamo progetti che siano unicamente destinati alla popolazione». Anche il commissario europeo Bonino poco meno di un mese fa si è recata a Kabul a discutere del piano di aiut i stanziati dall'Unione. «Sì, è vero - dice il portavoce della Bonino - diamo anche noi aiuti all'Afghanistan, ma mai direttamente al governo, solo alle organizzazioni internazionali per finanziare progetti umanitari. Mentre di questa trovata delle N azioni Unite sulla droga si avvantaggeranno solo le milizie islamiche». Secondo Emma Bonino, esperimenti simili fatti in Sud America, si sono rivelati completamente fallimentari. «Basta andare nelle strade di La Paz in Bolivia - dice Filippo di Robil ant - e vedere quante signore se ne stanno sedute con la bombetta in testa a pensare ai loro figli che studiano a Yale grazie ai proventi della cocaina. Come si può credere che i Talebani rinuncino alle ricchezze che vengono dalla droga? Loro che pre ndono il 20 per cento sulla commercializzazione del papavero d'oppio? Questo tipo di politica l'Onu l'aveva abbandonata 20 anni fa». Scontro dunque tra Nazioni Unite e Unione europea sulle politiche umanitarie, o sulla politica tout court? Emma Bon ino ha sempre sostenuto che contro la droga c'è una sola via da seguire: la depenalizzazione degli stupefacenti. E forse non è un caso che il battibecco con Arlacchi scoppi lo stesso giono in cui in Italia il suo amico e collega di partito Marco Pann ella finisce agli arresti domiciliari per aver distribuito della marijuana. E anche lo stesso giorno in cui il commissario europeo riceve i ringraziamenti dal giornale britannico Independent on Sunday per l'appoggio dato a una campagna per la liberalizzazione dei derivati della canapa indiana. domenica , 26 ottobre 1997 Arlacchi stringe un accordo Onu-Talebani per distruggere le coltivazioni l'80 per cento del commercio di eroina in Europa Dal cortile di casa, dove tramano i boss di Corleone, alle basi d'oltremare del narcotraffico globale. Un percorso compiuto di scatto. In meno di due mesi, da quando è stato nominato vicesegretario delle Nazioni Unite, l'italiano Pino Arlacchi, socio logo di mafia, senatore uscente nel contrastato collegio del Mugello, ha già il suo asso da giocare sulla ribalta internazionale: un accordo, firmato venerdì con i Talebani, le milizie islamiche che governano due terzi dell'Afghanistan, sulla distruz ione delle coltivazioni d'oppio. «Un accordo storico - ha annunciato Arlacchi all'assemblea generale dell'Onu, a New York - che può salvare la vita di 8 milioni di persone, tanti quanti sono i consumatori di eroina in Occidente». Come, è presto detto : «Offriremo coltivazioni alternative che dovrebbero garantire la scomparsa dell'oppio da 3 distretti su 42 nei prossimi due anni e dall'intero territorio afgano da qui a dieci anni». L'Afghanistan produce l'80 per cento dell'oppio che rifornisce i l mercato europeo dell'eroina e il 50 per cento di quello mondiale: 2 mila e 800 tonnellate, con un incremento, rilevato proprio dall'Onu, del 25 per cento nell'ultimo anno. Un milione di contadini sono coinvolti nella coltivazioni di 58 mila ettari. Pino Arlacchi, dalla sua poltrona, oltre che di vicesegretario dell'Onu di direttore dell'ufficio di Vienna, dal quale si coordinano le strategie mondiali di lotta al crimine e alla droga, debutta così su un terreno doppiamente insidioso. Quello del narcotraffico e quello della «sharia», nella sua interpretazione più radicale oltre la cortina di ferro dell'Islam afgano. «Ma è proprio la legge coranica - dice - che ci ha permesso di arrivare all'accordo. La sharia non tollera la droga». Ma i T alebani non hanno incrementato la produzione? «L'Afghanistan è un Paese allo stremo. Ma tutto sta nell'offrire una fonte di reddito alternativa. Un contadino afgano dalla coltivazione d'oppio guadagna meno di 100 dollari l'anno. E poi l'idea è part ita proprio dai Talebani: eravamo in trattativa con loro da sei mesi. A settembre hanno emesso un ordinamento che vieta la produzione di eroina e hashish. Non era chiaro se si parlasse anche del papavero. I nostri funzionari di Islamabad, in Pakistan , hanno scritto per chiedere spiegazioni». Risposta positiva? «Eccome, ci hanno presentato un documento che mette appunto al bando il papavero d'oppio». E la contropartita? «Programmi e coltivazioni alternative. A Kandahar, per esempio, nell' Afghanistan centrale, riattiveremo una vecchia fabbrica di cotone che darà lavoro a mille persone. In un'altra provincia creeremo canali d'irrigazione per le coltivazioni di alberi da frutto. Ma non solo, i Talebani ci hanno chiesto di controllare il programma sul posto e di addestrare le loro forze di polizia». Quanto costerà? «Venticinque milioni di dollari l'anno, poco più di 40 miliardi di lire. Niente, rispetto a quello che rende l'eroina sul mercato europeo: dai 45 ai 50 miliardi di do llari l'anno, tra i 70 mila e i 90 mila miliardi di lire». I Talebani vogliono il seggio all'Onu. E questa la ragione del loro assenso? «Non è un problema che ci riguarda direttamente. Noi ci occupiamo solo di controllo del mercato della droga». Ma i Talebani sono anche responsabili di violazione dei diritti dell'uomo. Trattare con loro è come chiudere un occhio. «Lavoriamo anche noi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Per salvare 8 milioni di consumatori di eroina». Nessun rimp ianto per il suo collegio del Mugello, dove la canditura di Di Pietro sta spaccando la sinistra? «Ormai sono un funzionario internazionale. E poi non leggo i giornali italiani da più di una settimana». Copyright and Courtesy of Corriere della Sera |
|
AFGHANISTANW>>
|
|
|
AFGHANISTANW>>
|
|

|
|
|
AFGHANISTANW>>
|
|
 |
|
|
EX-JUGOSLAVIAW>>
|
|
 |
|
|
PORTFOLIO
Srebrenica, Survivors of a Massacre |
|
|
AFGHANISTANW>>
|
|
 |
|
 |
|
|
PORTFOLIO
The Plight of the Afghan Women |
|
|
SIERRA LEONEW>>
|
|
 |
|
|
SIERRA LEONEW>>
|
|
 |
|
|
KOSOVOW>>
|
|
 |
|
|
Postcards From Hell, War / Conflict Photojournalism © 1999-2001 All Rights Reserved. This website's contents may not be published, reproduced, or distributed in print or electronic and / or digital media without the express written consent of the Author. PRIOR TO ANY DOWNLOAD PLEASE READ COPYRIGHT INFOS |